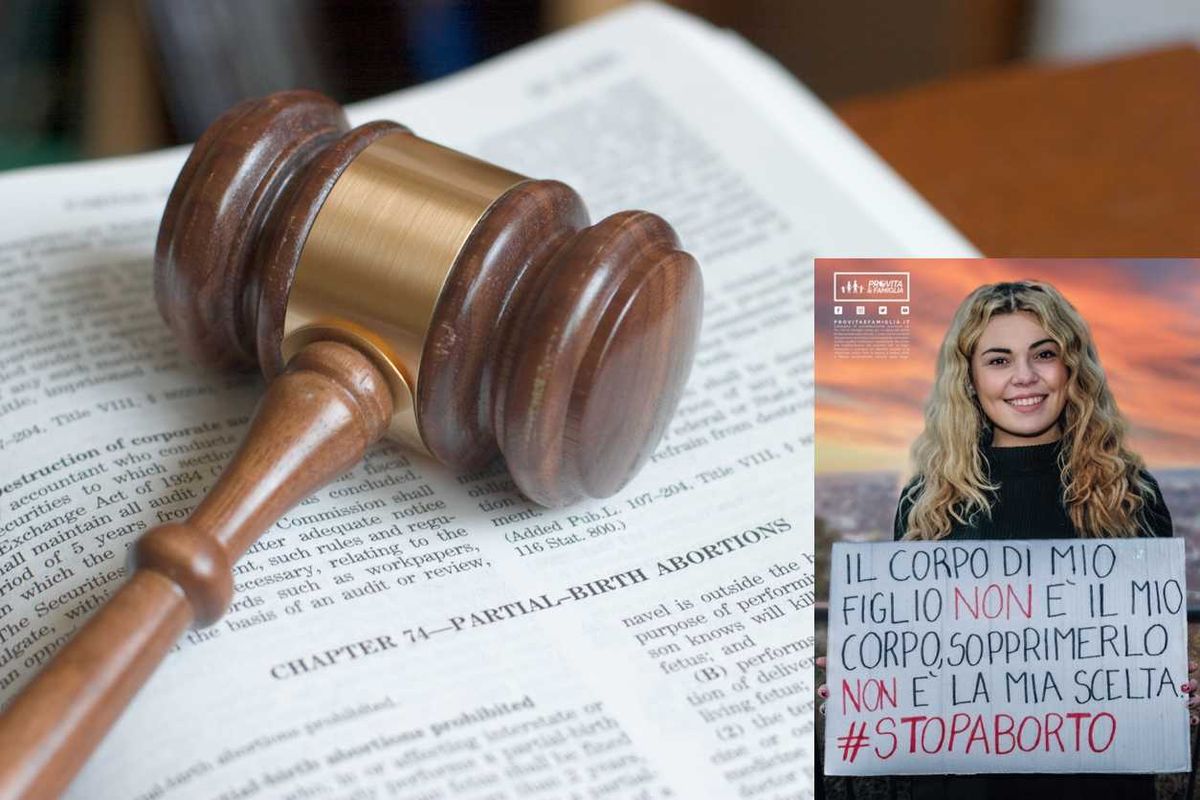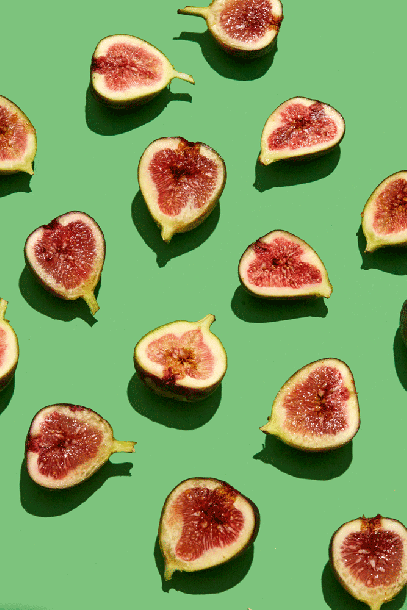
Arcel Keys, l'americano che creò le basi della dieta mediterranea, scelse di vivere nel Cilento per 40 anni, trasferendosi dal suo Colorado. Ogni sera si gustava due fichi. Chissà se è anche per questo che campò sino a 100 anni. Tracce di questa coltivazione si sono trovate in scavi archeologici nei pressi di Gerico, in un'epoca stimata attorno al 9000 avanti Cristo, 1.000 anni prima di analoghi reperti che riconducono all'orzo e al grano. La pianta del fico è l'unica citata nella Genesi, tanto che qualcuno è arrivato a supporre che il frutto del peccato originale non sia la tanto vituperata mela, ma proprio il fico, con le cui foglie, ricoperte le loro vergogne, Adamo ed Eva furono cacciati dal paradiso terrestre. Non fu da meno Giuda che, dopo aver tradito Gesù, si impiccò ai rami di un fico.
Gli antichi egizi, con il suo legno, preparavano i sarcofagi, quale augurio per una rinascita nell'aldilà. Per i greci la forza di Ercole derivava dalla sua dieta a base di fichi. Nella civiltà romana il fico è un dominus incontrastato, a iniziare dal mito di Romolo e Remo. Pianta sacra a Marte, dio della guerra. Da una sua relazione clandestina con Rea Silvia nacquero i due gemelli che, essendo prole illegittima, vennero strappati alla madre per essere uccisi. Un servo pietoso li pose su di una cesta affidata alle acque del Tevere. Furono le fronde di un fico a trattenerli a riva, nei pressi della tana della lupa che poi generosamente li allattò per consegnarli, immortali, alla storia. Fico pluricitato nella letteratura. Plinio il vecchio racconta come Catone convinse il Senato romano a distruggere Cartagine mostrando un cesto di fichi giunti nottetempo (tre giorni, allora, era considerata pericolosa prossimità). Plutarco racconta come Cleopatra si fece portare da un servo l'aspide velenosa nascosta in un cesto di fichi, gesto di estremo orgoglio pur di non arrendersi a Ottaviano. Publio Ovidio Nasone testimonia come i fichi con il miele fossero il miglior augurio offerto nella notte di capodanno. Cambiano i tempi, ma i fichi sempre sugli scudi, a partire dalla scuola medica salernitana che li raccomandava quale eccitante erotico. Le coppie sterili, a luna crescente, staccavano due foglie da un albero e le mettevano sotto i rispettivi cuscini, quale augurio per essere finalmente presi in considerazione dalla cicogna viaggiatrice.
Fichi volano economico, nelle situazioni più disagiate, a partire dall'imperatore Diocleziano che stabilì come la pasta con i fichi secchi fosse il prodotto più economico da mettere sul mercato in tempi di difficoltà, tanto da essere definiti il pane dei poveri, ed è anche per questo che «fare le nozze con i fichi secchi» sta a significare una certa qual debolezza economica. Fichi importanti nella dietetica e farmacopea rurale. Ideali come antiossidanti, grazie alla loro ricchezza di vitamine e sali minerali. I decotti delle loro foglie utili per combattere infiammazioni delle vie respiratorie o le turbe digestive in tempo di gravidanza.
Fichi ben presenti non solo nella letteratura classica, ma anche nell'arte. Non è un caso che gli Adamo ed Eva più noti, custoditi nei musei vaticani, agghindati delle sole foglie, siano quelli dipinti dal pennello di Michelangelo Buonarroti, ma sempre nel loro rinviarli alle tentazioni dei più elementari peccati terreni, ricchi di eros e passioni, più o meno lecite, troviamo un'altra Eva, voluttuosamente dipinta da Ambrogio Lorenzetti, che tenendo in mano un ramo con il relativo frutto, non ha pudore a confessare «fei peccato per passione». Fichi ben presenti nella cultura della civiltà rurale, citati in innumerevoli proverbi, tra cui vale ricordare «anno ficaio, scarso granaio», ma anche «serbare la pancia per i fichi» stava a significare che, nelle rare occasioni di pranzi generosi, valeva la pena trattenersi lungo le varie portate per gustarsi, nel finale, i golosi fichi. Così come etichettare qualcuno di «non valere un fico secco», era l'equivalente di un minus quam qualsiasi.
Pianta molto generosa che, a seconda delle specie, può arrivare a donare qualche quintale di raccolto a stagione, con un frutto che viene prodotto a partire dal quinto anno per una vita media della pianta di circa 60. Il fico ama i climi caldi, con terreni calcarei, sassosi e ben drenati. I primi produttori a livello internazionale sono Turchia ed Egitto. In Italia leader è la Campania, con la metà del mercato concentrato prevalentemente nel Cilento. Ci sono essenzialmente tre tipologie di frutto. Quello viola, dal sapore dolce e delicato. Nero, zuccherino, ma asciutto. Verde, succoso dalla buccia sottile. Il fico del Cilento, già citato da Catone e Varrone, è stato spesso la base alimentare per la manodopera impiegata nel lavoro dei campi. Protagonista nel periodo natalizio, una volta essiccato, per varie preparazioni. Molto usato in pasticceria anche il fico di Cosenza. In Toscana troviamo il fico secco di Carmignano, nei pressi di Prato, cibo di viaggio per i legionari romani. Qui, per anni, si è svolto un singolare concorso volto a stimolare la creatività di cuochi professionisti o semplici appassionati, con il proliferare di un numero incredibile di ricette che lo hanno visto protagonista a tutto menù. Altro che «nozze con i fichi secchi», ma ricchi premi e cotillons per le ricette più intriganti. Infine i fichi mori friulani, dalle parti di Caneva, nel Pordenonese. Prodotto tenuto in grande spolvero nel Rinascimento, tanto da arrivare sui mercati di Venezia ed essere ghiotta riserva per i marinai sulle rotte mediterranee. Ecco allora che il ricettario ficaiolo presenta diverse note di curiosità. Consumati freschi, appena colti, oppure, con maggior oculatezza, essiccati a futura dispensa come ne ebbe già a descrivere Columella nel I secolo dopo Cristo, pigiati in recipienti di terracotta con semi di anice e finocchio.
Al piatto li si può trovare in declinazioni diverse. Con prosciutto e melone, ma anche abbinati a una focaccia farcita di prosciutto, come da antica tradizione romana. Fanno bella figura all'occhio (e poi al palato) decorati con roselline di prosciutto crudo. Ottimo abbinamento con la bresaola in intriganti risotti, oppure con spaghetti e speck o, ancora, alla gricia, con guanciale e pecorino. Sui secondi la duttilità è confermata. In abbinata con il maiale arrosto, ma anche con filetti di anatra selvatica o lepre. E che dire del coniglio ficoso a farcire golosi rotolini? Fichi che sanno ben «nuotare» anche con il baccalà, in diverse e creative varianti.
Ma è nei dolci che scatenano il loro arsenale di voluttuoso piacere. Un grande classico li vede ricoperti al cioccolato. In Romagna li troviamo caramellati, una volta frollati con zucchero e limone. Nell'anconetano ecco il lonzino, con noci, mandorle, avvolto dalle sue foglie e appeso in cantina in attesa di Babbo Natale. All'isola d'Elba il panficato, un tempo pane di tutti i giorni, divenuto «adulto» grazie al cioccolato portato dalle truppe americane. E come non ricordare i fichi 'mpaccati, nel Cilento, tagliati a metà e imbottiti di noci, mandorle, semi di finocchio e passati velocemente al forno. E poi le crocette calabresi, farcite di frutta secca e bucce d'arancia. Le cartellate, regine del Natale pugliese, o gli occhi di santa Lucia, tarallini forati al centro, che ricordano l'occhio umano. In Sardegna ecco la lorica chin ficu, pane dolce farcito con tutto quello che avanza tra orto e dispensa. Fichi versatili anche nella declinazione alcolica, con il vincotto pugliese, mosto sottoposto a lunghe cotture e filtrazioni, prevalentemente usato in pasticceria, ora sperimentato anche in abbinata con carne o pesce. Sfiziosa preparazione che, per arrivare a un litro di prodotto, richiede 20 chili di materia prima. Un tempo considerato elisir di lunga vita. Ma questo ben lo sapeva Arcel Keys.