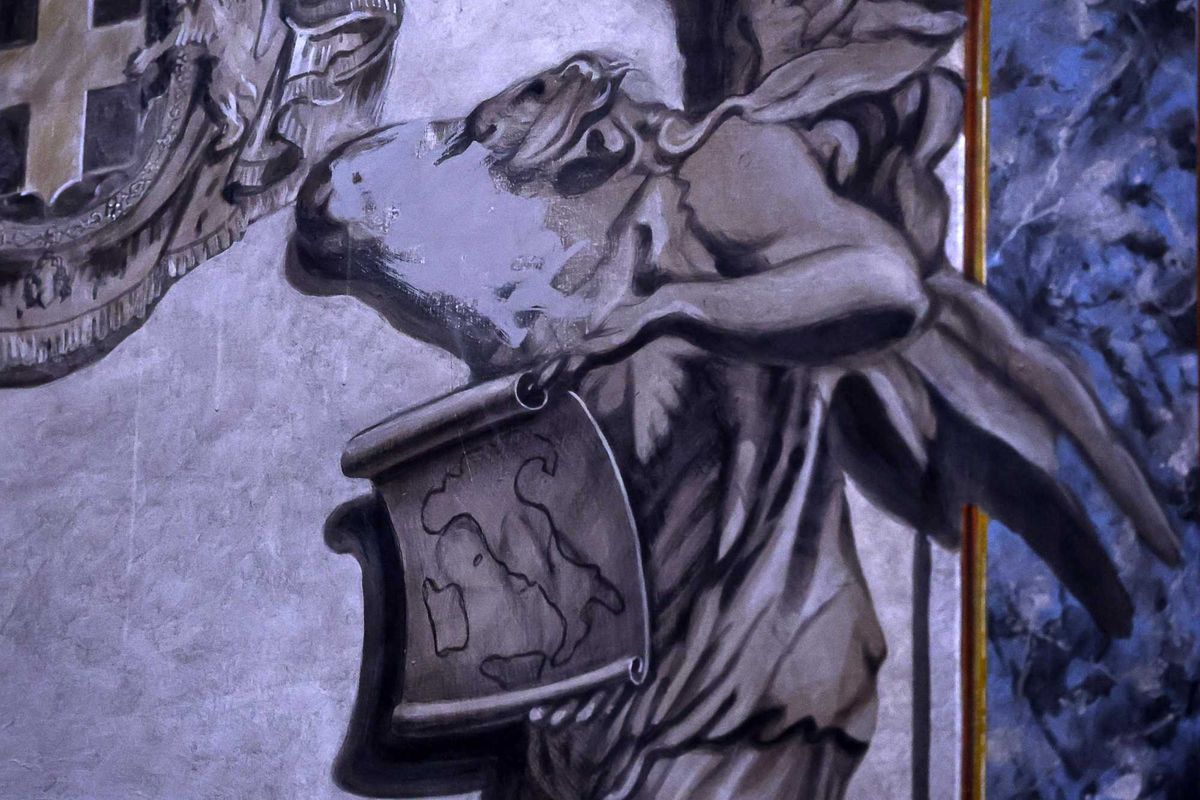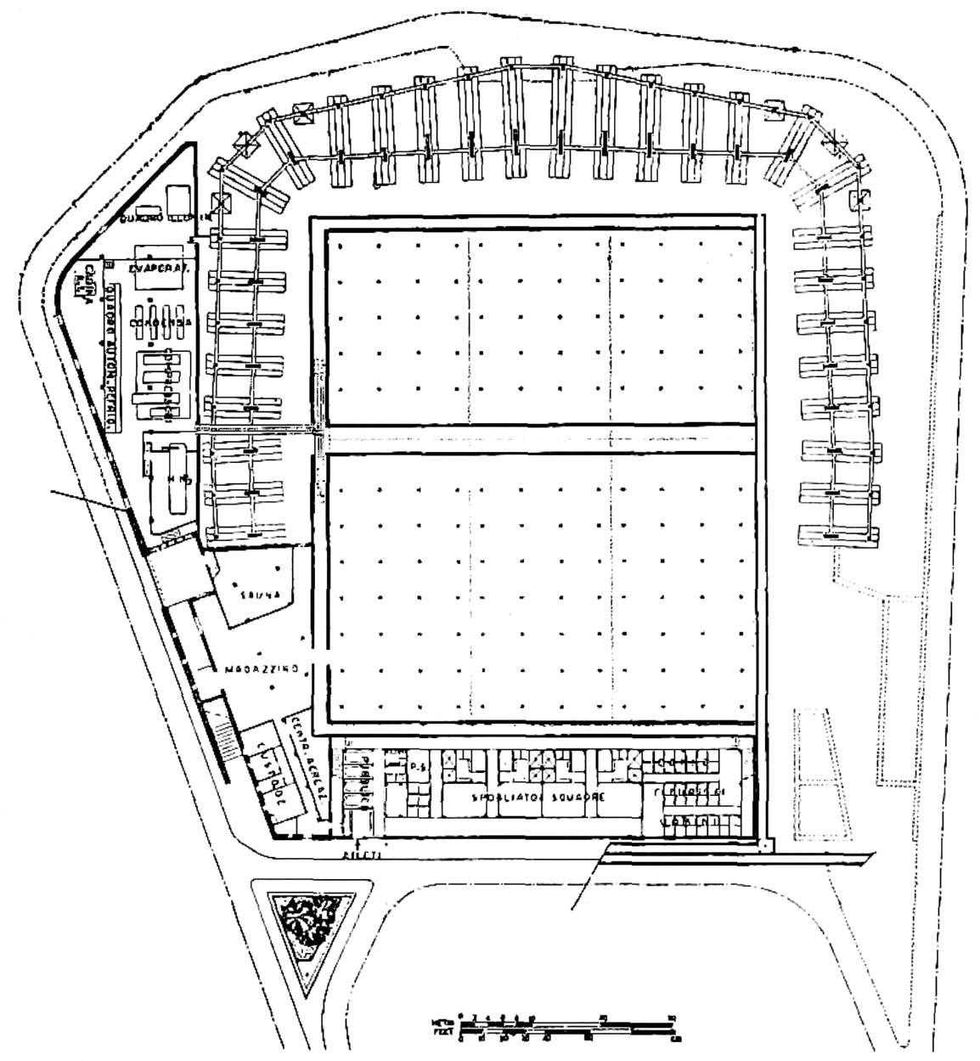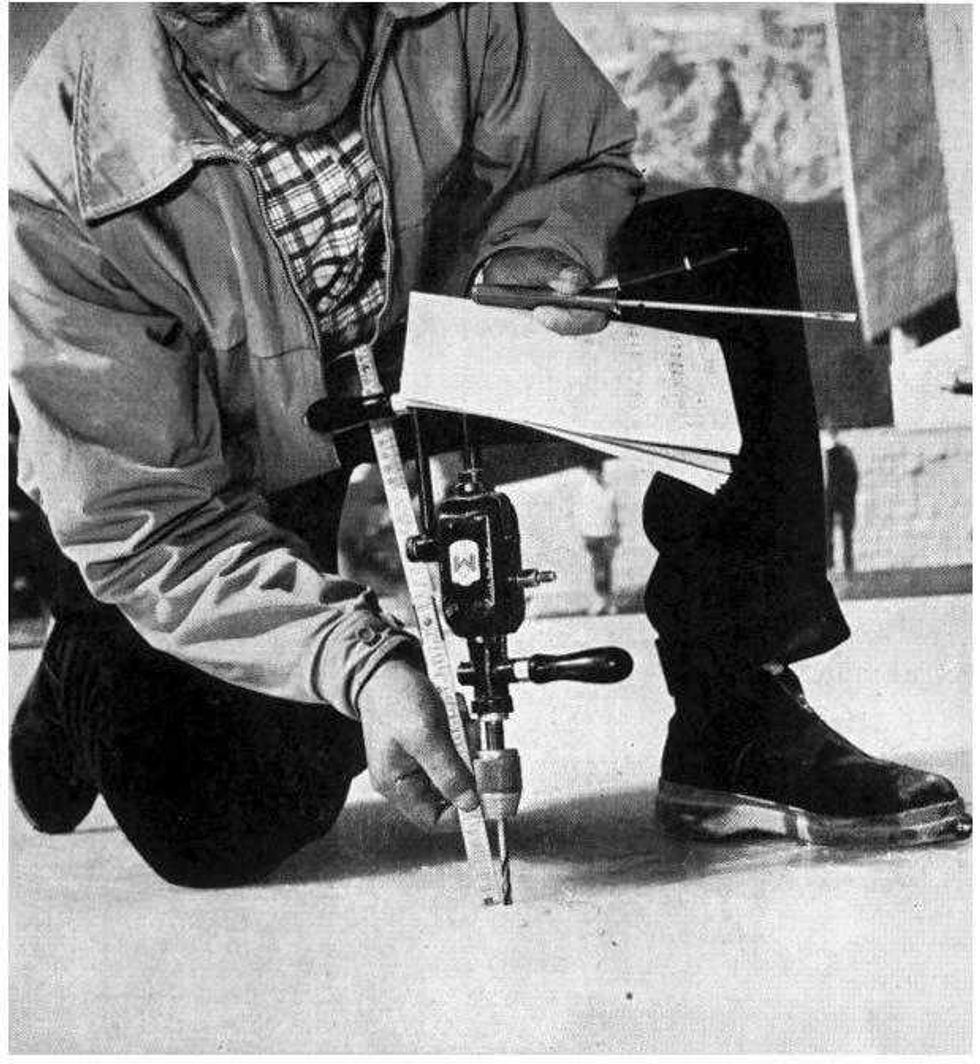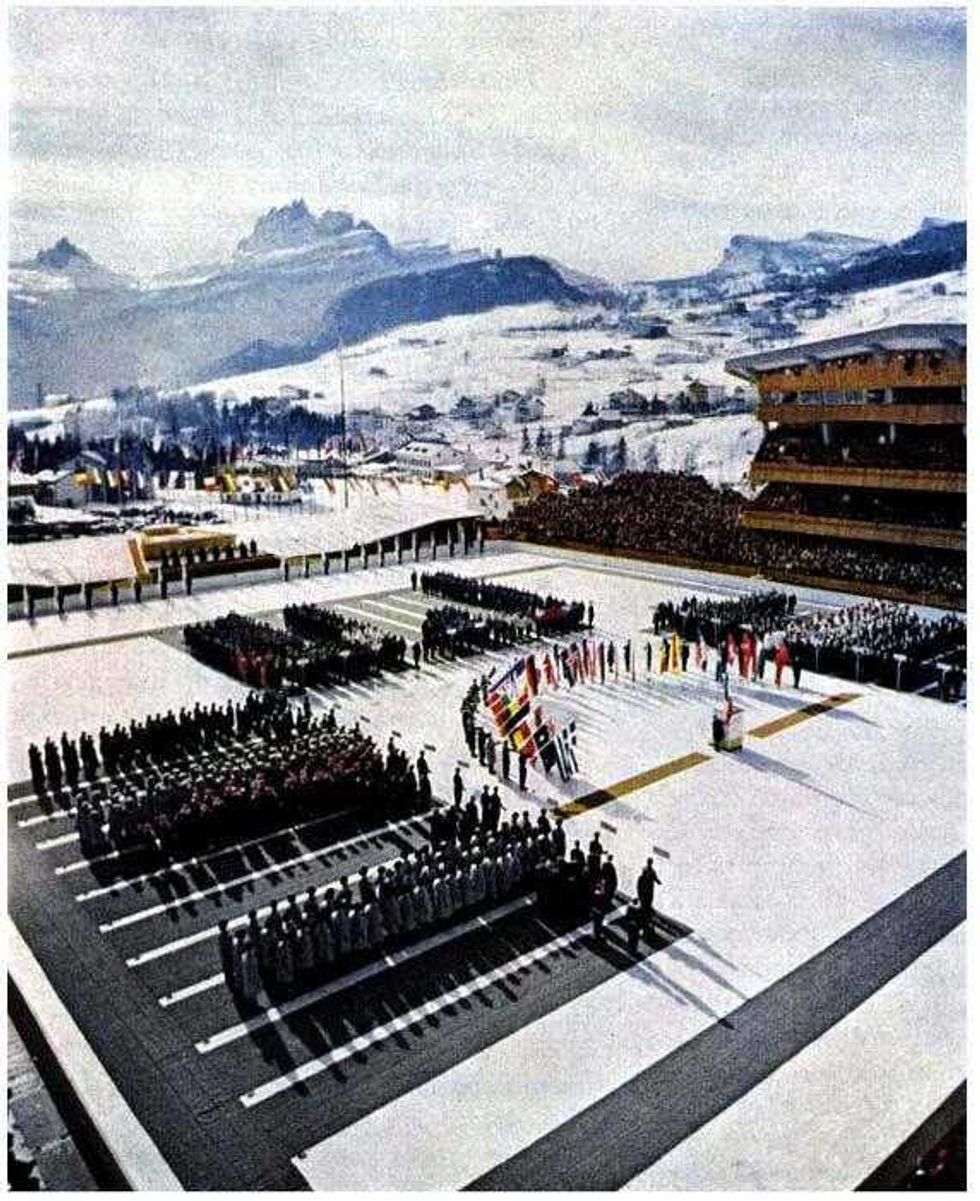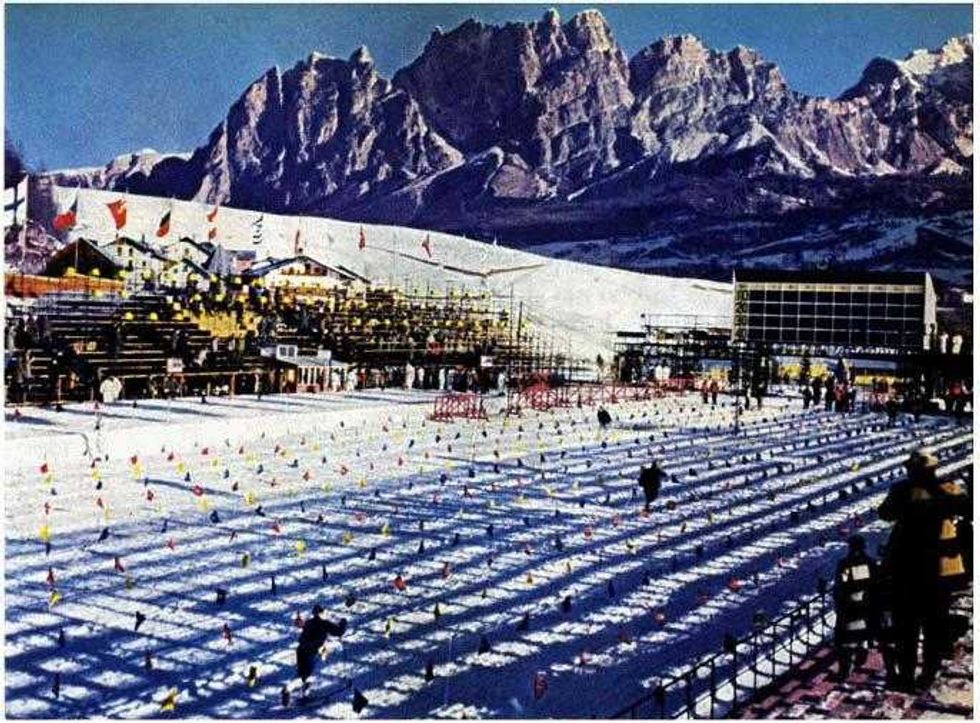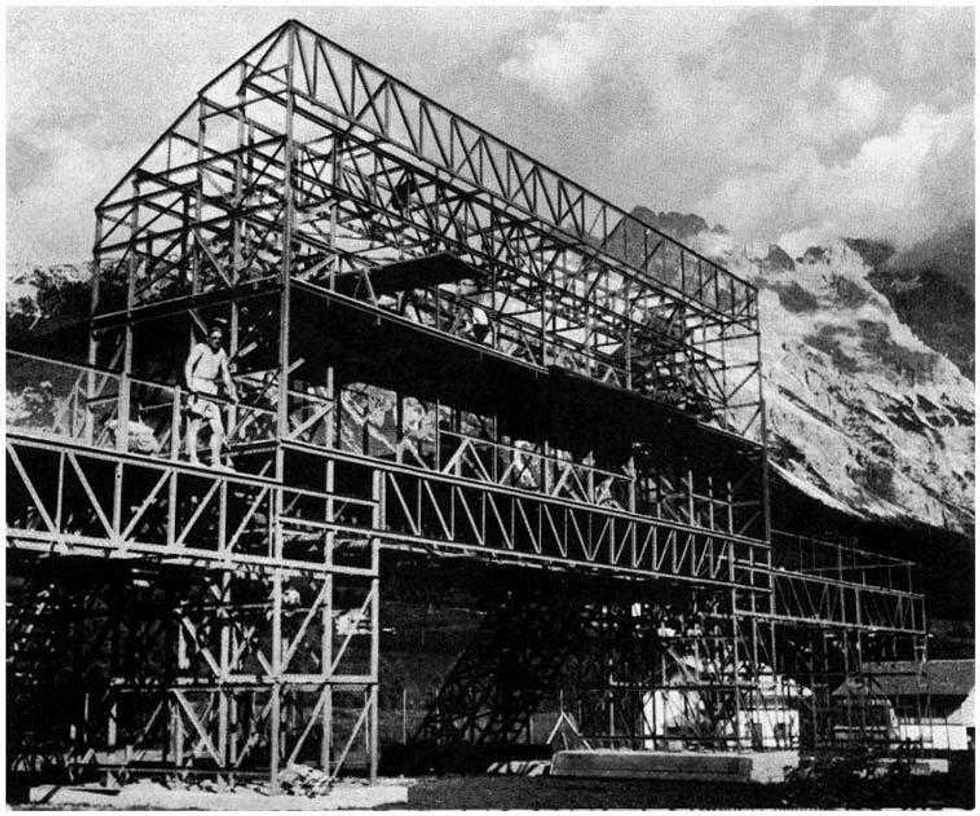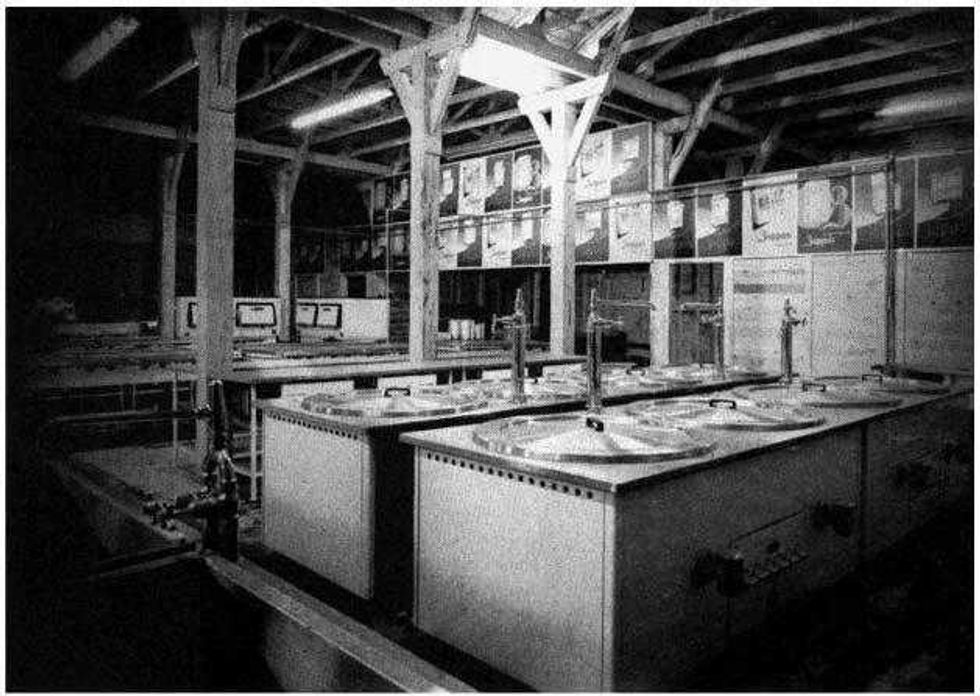È un sonoro doppio schiaffo quello inferto ieri dalla Corte suprema a Joe Biden. Innanzitutto la maggioranza dei togati ha cassato il maxi piano della Casa Bianca per condonare i prestiti studenteschi: annunciato l’anno scorso dal presidente, si trattava di un decreto significativamente costoso (oltre 400 miliardi di dollari). In sostanza, i giudici hanno dichiarato che il Dipartimento dell’Istruzione non disponeva dell’autorità per varare un piano così vasto. L’amministrazione Biden aveva sostenuto di poterlo fare sulla base dell’Heroes act: una legge del 2003, che consente al segretario all’Istruzione di concedere sgravi finanziari in caso di emergenza nazionale. In tal senso, l’amministrazione aveva vincolato il suo piano all’emergenza pandemica.
Una linea argomentativa che tuttavia non ha convinto la maggioranza dei togati. «Riteniamo oggi che la legge consente al segretario all’Istruzione di “revocare o modificare” statuti o regolamenti esistenti applicabili ai programmi di assistenza finanziaria ai sensi dell’Education act, non di riscrivere tale statuto da zero», recita la sentenza (tenendo presente che l’Education act è una legge del 1965 relativa anche ai prestiti studenteschi). «Il segretario non ha mai rivendicato in precedenza poteri di questa portata ai sensi dell’Heroes act. Come abbiamo già notato, le passate deroghe e modifiche emesse ai sensi della legge sono state estremamente modeste e di portata limitata», si legge ancora. In altre parole, secondo la maggioranza dei togati, l’amministrazione Biden si è arrogata un potere che non le competeva, aggirando indebitamente l’autorizzazione del Congresso. Per il presidente la situazione rischia di farsi scivolosa: contava infatti molto sul suo maxi piano relativo al debito studentesco per cercare di risalire nei sondaggi. Non a caso, ieri la Casa Bianca ha fatto sapere di voler adottare «nuove azioni» per tutelare i mutuatari.
Ma un’altra sentenza, sempre ieri, si è abbattuta sul capo del presidente. La maggioranza dei giudici supremi ha infatti dato ragione a una web designer cristiana che si rifiutava di creare siti Web per celebrare matrimoni omosessuali: una posizione che aveva portato la diretta interessata a fare ricorso, nel 2016, contro una legge antidiscriminazione vigente nel Colorado. In particolare, i togati hanno incentrato la loro decisione sul Primo emendamento, che tutela la libertà di espressione. «Il Primo emendamento immagina gli Usa come un luogo ricco e complesso in cui tutte le persone sono libere di pensare e parlare come desiderano, non come richiede il governo», recita la sentenza. In altre parole, «Il Primo emendamento vieta al Colorado di obbligare una web designer a creare progetti espressivi che veicolano messaggi con cui la web designer non è d’accordo». «In America, nessuna persona dovrebbe subire discriminazioni semplicemente a causa di chi è o di chi ama», ha commentato Biden in una nota. Andrebbe però sottolineato che la sentenza non consente alcuna discriminazione, dice semmai che una persona non può essere costretta ad agire in modo contrario alle sue convinzioni morali.
E intanto lo scontro politico infuria. I democratici hanno espresso disaccordo con le sentenze, mentre il Gop ha esultato. A schierarsi per abolire il piano di Biden sul prestito studentesco e per tutelare la ricorrente del Colorado sono stati i sei togati di nomina repubblicana, mentre le tre colleghe di designazione dem si sono pronunciate in modo diametralmente opposto. È in questo quadro, che il capogruppo al Senato dell’Asinello, Chuck Schumer, è andato all’attacco, accusando i togati considerati conservatori di «accettare ricchi regali». Una delegittimazione della Corte, che fa il paio con quella portata avanti da Biden l’altro ieri, quando - commentando la sentenza che aboliva de facto l’uso dell’etnia tra i fattori esaminati per valutare le ammissioni universitarie - aveva detto: «Questa Corte non è normale». D’altronde, questo tipo di attacchi si erano verificati già l’anno scorso, quando la maggioranza dei togati aveva ribaltato Roe vs Wade. Il che evidenzia un problema. Un conto è essere in legittimo disaccordo con una sentenza, altro conto è delegittimare la Corte suprema, determinando una pericolosa intrusione dei poteri esecutivo e legislativo in quello giudiziario. Le istituzioni si dovrebbero rispettare sempre, non solo quando si esprimono in linea con le proprie posizioni ideologiche.
Ma non è tutto. La narrazione dei «giudici conservatori» che vogliono mettere i bastoni tra le ruote a Biden non regge. Più di una volta i togati di nomina repubblicana si sono espressi contro gli interessi di quello che avrebbe dovuto teoricamente essere il loro partito di riferimento. Il punto riguarda semmai due filosofie giuridiche contrapposte. I giudici di designazione dem sposano un approccio storicista, secondo cui la Corte suprema dovrebbe garantire un presunto progresso sociale. Molti dei loro colleghi di nomina repubblicana sono invece di orientamento originalista: ritengono cioè che si debba cercare di interpretare la Costituzione in base al senso originario in cui fu scritta. Un metodo, quest’ultimo, che garantisce il rispetto dello stato di diritto, laddove l’approccio storicista è maggiormente opaco e soggetto a pressioni di vario di tipo. Capita inoltre che i togati originalisti siano spesso in dissenso tra loro: una circostanza invece più rara tra quelli di nomina dem. Insomma, più che i repubblicani, chi sta cercando di politicizzare la Corte suprema sembra essere Biden.