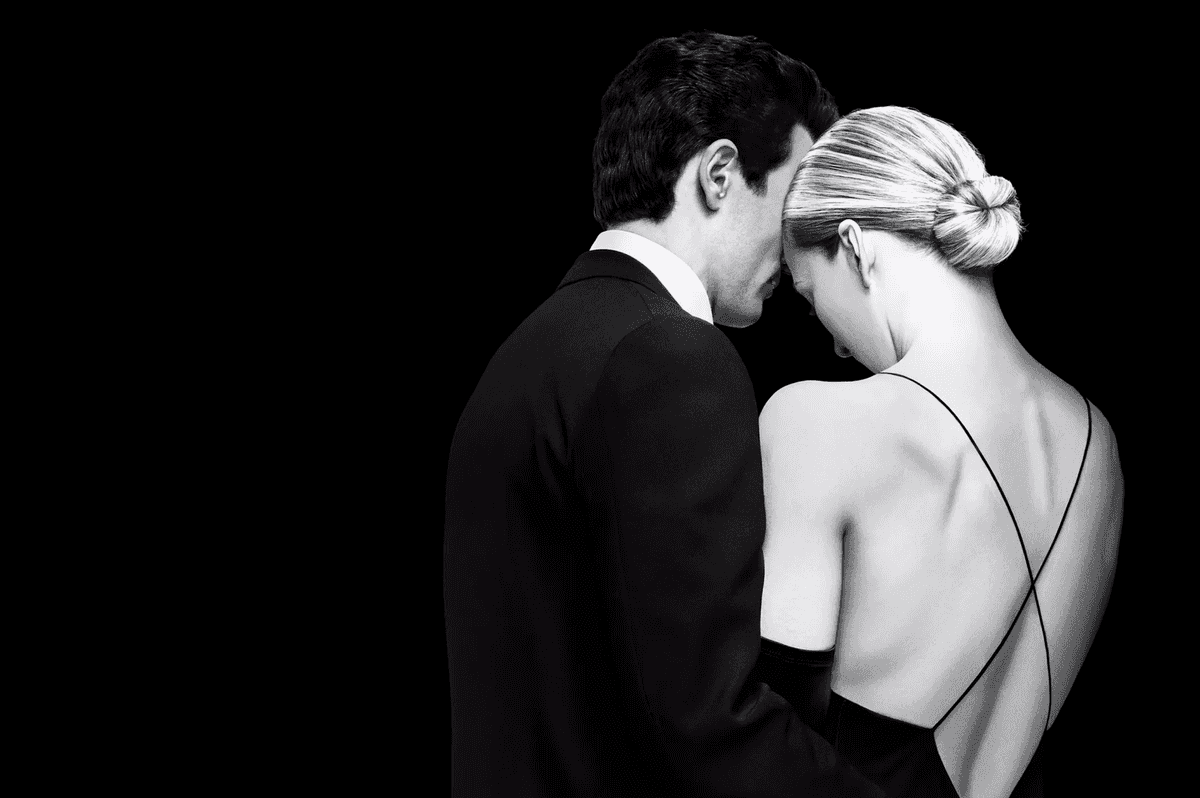True
2022-09-28
La Lega «assolve» Salvini: i suoi pm sarebbero finiti alla sbarra con lui
Da sinistra: Luca Zaia, Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana
Che la sindrome di piazzale Loreto sia tra le patologie più diffuse in Italia non lo scopriamo certo oggi: dalla fine della seconda guerra mondiale siamo abituati a vedere capi politici prima osannati anche oltre il limite della decenza e poi calpestati dagli stessi che prima li applaudivano. Scene di questo genere si ripetono, con varie gradazioni di violenza, da diversi decenni. In queste ore la deleteria malattia sta iniziando a contagiare anche alcuni settori della Lega, i cui portavoce hanno affilato i coltelli e si apprestano a conficcarli nella schiena o nel ventre (a seconda del coraggio dei singoli) di Matteo Salvini.
Al Capitano leghista viene imputato il deludente risultato alle elezioni, il che è anche abbastanza normale: a chi guida la baracca spettano oneri e onori. E non siamo così ingenui da credere che l’assalto degli (ex) amici al leader indebolito non rientri fra le specialità della casa dell’universo politico. Non è sicuramente piacevole, ma rientra nella normalità pure il fatto che gli avversari politici sguazzino nelle beghe interne, le alimentino e le facciano deflagrare a livello giornalistico, cosa che in queste ore sta accadendo attorno al «caso Salvini», come l’ha chiamato ieri in prima pagina Repubblica. Lo stesso quotidiano, sempre nel pomeriggio di ieri, ha sfoderato un titolo lisergico: «La rivolta della vecchia Lega contro Salvini. Bossi fuori dal Parlamento dopo 35 anni: “Il popolo del Nord va ascoltato”».
Appena sotto, appariva una robusta intervista a Roberto Maroni con un titolo altrettanto suggestivo: «Serve un nuovo segretario». Tutto prevedibile e financo comprensibile, chiaro. Ma suscita comunque uno strano miscuglio di sentimenti - un po’ pena e un po’ ilarità - vedere il giornale progressista appiccicarsi a due suoi nemici storici pur di azzannare Salvini. Ognuno si sollazza come può.
Al di là delle questioni emotive (provocano un filo di tristezza anche certi commendatori leghisti pronti a sfoderare il dente avvelenato), ci sono alcuni temi strettamente politici che meritano di essere affrontati con una certa serietà specie ora che il centrodestra unito si appresta a governare, e dagli equilibri interni ai partiti dipenderanno anche le dinamiche di coalizione.
Non c’è dubbio che una riflessione interna alla Lega si imponga, anzi è necessaria visto il calo dei consensi: al netto della tendenza a disamorarsi rapidamente spesso mostrata dall’elettorato in tempi di «likecrazia», come l’ha definita Daniele Capezzone, è ovvio che qualcosa non sia andata nel verso giusto. Già, ma cosa?
Tutti, manco a dirlo, puntano l’indice nodoso contro Matteo Salvini. E che il segretario abbia commesso vari errori sarebbe stupido negarlo. In alcuni casi, forse, è stato mal consigliato, ma un buon capo deve scegliersi buoni consiglieri. Su altre faccende si è trattato più che di peccati, di omissioni, ma comunque dolorose per una fetta di elettorato.
Ora gli viene rimproverato, per dire, di avere trascurato le istanze autonomiste. Ed è difficile negare che sia così, non a caso il malumore della componente indipendentista cova da tempo. Volti storici come Roberto Castelli lo hanno apertamente manifestato in queste settimane, ma non è che prima lo avessero nascosto, e non li si può rimproverare di essere incoerenti. Nel primo governo Conte, Salvini era vicepremier, e riuscì a piazzare anche un ministro per le Autonomie, Erika Castelli. Che cosa abbia portato a casa di notevole non è dato sapere. Nello stesso governo i leghisti esprimevano anche un ministro dell’Istruzione, il cui apporto è stato sinceramente deludente.
Detto questo, seriamente pensiamo che a tirare giù il partito dalle vette sia stata la scarsa attenzione alle richieste venetiste, come sostengono in parecchi adesso, specialmente fra gli esponenti più vicini a Luca Zaia? O forse vogliamo credere che la mancata elezione di Umberto Bossi possa giustificare un pubblico linciaggio del capo fallito? Dai. Si inchiodi pure Salvini alle sue colpe, gli si rinfaccino pure le uscite becere, la gestione un po’ ballerina di casi problematici (vedi Morisi), o la carenza d’attenzione ai temi etici pur dopo gli sventolamenti di rosari in favore di camera. Ma urge fissare un paio di punti. Il Capitano, quando stava sugli allori, di certo non passava le giornate a parlare di Padania. Magari si faceva troppi selfie, ma non è stata la questione autonomista a danneggiarlo così tanto (altrimenti i suoi seguaci delusi non avrebbero votato Fdi). Gli si può certo rinfacciare il Papeete, per carità, ma è inutile nascondersi che a provocare il crollo elettorale non siano stati i mojito. No, il disastro lo ha causato la scriteriata gestione della pratica Draghi. L’ingresso nel governo dei Migliori ha logorato Salvini, i voti sulle misure restrittive hanno fatto infuriare anche alcuni tra i più fedeli ammiratori, e hanno messo in difficoltà più d’uno nel partito.
Più in generale, potremmo dire che sia stato lo schiacciamento sulla narrazione prevalente (il famigerato mainstream) a favorire il tracollo. Sorte condivisa da Giuseppe Conte, che però non solo ha potuto sbandierare al Sud il reddito di cittadinanza (provvedimento inviso a tanti leghisti), ma è pure riuscito a vendersi con furbizia la fuoriuscita dall’esecutivo, cosa che Matteo non ha potuto fare.
Ed eccoci al punto: perché Salvini è apparso a tratti avere le mani legate? Perché i suoi supposti sodali remavano contro. Adesso Zaia, Fedriga e addirittura Fontana, pur con intensità differente e talvolta mandando avanti i propri scherani invocano il confronto interno. Ma quanti voti hanno fatto perdere con la loro gestione del Covid? Ricordiamo che i governatori si sono voluti vendere come poliziotti del regime sanitario, con intemerate continue e talvolta violente contro i dubbiosi e i critici. Che lo abbiano fatto per convinzione o calcolo poco cambia. Quanti voti hanno fatto perdere gli idranti sui portuali di Trieste? E quanti i voti malefici a favore del green pass? Chiediamo: chi ha spinto per questi voti? Chi ha insistito sulla fedeltà a Draghi? Facile: molti di quelli che stanno invocando la resa dei conti. I governatori, i giorgettiani entusiasti, gli ex compagni di strada come Maroni che ancora a novembre 2021 invocava un super governo a guida Draghi tramite Repubblica. Si facciano allora tutti i processi del mondo, e ben venga che i capi si prendano le loro responsabilità. Ma un esame appena più allargato potrebbe, se non riequilibrare i carichi di colpa, evitare ulteriori delusioni in un futuro non troppo lontano.
Nel Carroccio la minoranza si muove ma per ora il capo è saldo al comando
Matteo Salvini raduna i colonnelli della Lega in via Bellerio a Milano per il consiglio federale. E riparte, «con lo sguardo rivolto soprattutto al futuro» e «ai problemi da risolvere grazie al nuovo governo di centrodestra, di cui la Lega sarà parte fondamentale», dopo il risultato elettorale del 25 settembre, che ha visto il partito dimezzare i propri voti alle elezioni politiche: la Lega aveva ottenuto 17,3% nel 2018 mentre alle europee dell’anno dopo era arrivata addirittura fino al picco del 34,3%.
In questi cinque anni ne è passata molta di acqua sotto i ponti. In Lombardia e Veneto inizia a montare un certo malumore. C’è tensione, anche in vista delle regionali in Lombardia del prossimo anno, per un risultato elettorale che ha portato Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni a essere il primo partito nel Nord. Ma, al netto delle bordate arrivate soprattutto dagli ex dirigenti della Lega di Umberto Bossi, la leadership di Salvini non è in discussione. A ribadirlo, tra i primi a uscire da un consiglio federale durato più di quattro ore, è Marco Zanni. «Salvini è il leader della Lega e continuerà a esserlo», dice l’europarlamentare a chi gli domanda se durante l’incontro si è parlato della possibilità di sostituire il segretario federale. «Assolutamente no», è la risposta netta. Del resto, a parte quello del 5 aprile 2012 durante le inchieste sull’ex tesoriere Francesco Belsito con le storiche dimissioni di Bossi, non si ricordano consigli federali degli ultimi anni che abbiano sconvolto gli assetti del partito. Così è stato anche quello di ieri, alla presenza di tutti i big, dai governatori di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, Attilio Fontana, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, fino al neosenatore Claudio Durigon, al ministro Giancarlo Giorgetti e all’europarlamentare Lorenzo Fontana. Insomma, nonostante le sirene e i retroscena delle ultime ore, Salvini resta saldo al comando. Almeno per il momento. Di certo le truppe bossiane e vicine all’ex segretario Roberto Maroni stanno iniziando a riorganizzarsi. In ogni caso, «c’è rammarico per la percentuale raggiunta che si sperava migliore», dicono dalla segreteria leghista. Il motivo? La convivenza forzata con Partito democratico e 5 stelle al governo di Mario Draghi che ha allontanato l’elettorato da Nord a Sud, con uno spostamento evidente verso Fdi. In ogni caso, in Lega c’è «soddisfazione per i 95 parlamentari eletti (che Salvini riunirà giovedì pomeriggio a Roma), ma soprattutto c’è la richiesta unanime di vedere Salvini dentro il nuovo governo: la prossima settimana è previsto un nuovo consiglio per fare il punto sull’esecutivo.
La base nordista però ribolle. Paolo Grimoldi, ex storico colonnello leghista già segretario della Lega in Lombardia, è sulle barricate. Vuole un congresso della vecchia Lega Lombarda. «Abbiamo perso. Serve un momento di confronto per dare voce a tutti». C’è anche grande amarezza tra chi non è riuscito a entrare in Parlamento, tra cui il fondatore Bossi (dopo 35 anni) ma anche soprattutto il tesoriere, Giulio Centemero. «Non si è mai visto in Italia un partito senza un tesoriere eletto, con le dovute garanzie giuridiche», spiega un dirigente di vecchia data a microfoni spenti. I due, forse, potrebbero rientrare anche grazie alle complicate regole del Rosatellum.
C’è da dire che la giornata non era incominciata nel migliore dei modi in via Bellerio. Di prima mattina l’articolo sul Foglio firmato da Maroni, dal titolo «È l’ora di un nuovo leader della Lega», aveva dato inizio alle danze. Per Bobo ci vuole «un congresso straordinario. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma per adesso non faccio nomi». Poi aveva continuato lo stesso Bossi. «Il popolo del Nord esprime un messaggio chiaro e inequivocabile che non può non essere ascoltato», ha fatto sapere il Senatur. «Adesso Salvini dovrebbe cambiare nome al partito. Lega Salvini premier è démodé», gli ha fatto eco l’ex ministro leghista, Roberto Castelli.
A lato delle schermaglie, esterne e interne, restano i dati. La Lega, come fa notare l’istituto Cattaneo specializzato nelle analisi dei flussi elettorali, perde voti in tutte le direzioni. In particolare, c’è una perdita significativa di consensi proprio verso Fdi. Ma praticamente ovunque si registrano spostamenti di voti, anche verso Forza Italia (rilevanti verso il Sud) e verso l’astensione. In alcune città, per di più, si registrano flussi di voti verso Azione e il Partito democratico. Questi dati sembrano dunque mettere in luce che la mobilità elettorale tra il 2018 e il 2022 ha attraversato due fasi abbastanza diverse. Nella prima (tra il 2018 e il 2019) vi è stato un significativo travaso di voti dal centrosinistra (in particolare dal M5s) al centrodestra (di cui ha inizialmente beneficiato la Lega). Nella seconda (dal 2019 a oggi) gli schieramenti sono rimasti stabili mentre sono avvenuti importanti spostamenti di voti al loro interno: in particolare, il centrodestra ha visto Fdi «cannibalizzare» l’elettorato dei partner di coalizione, e in particolare quello - nel 2019 molto ampio - della Lega.
La ricetta di Salvini per rilanciare il partito è puntare subito sui provvedimenti contro il caro bollette, autonomia regionale e Quota 41. La Lega chiederà di inserire il tema dell’autonomia nel primo Consiglio dei ministri.
Continua a leggereRiduci
I governatori che guidano la fronda interna contro il Capitano sono gli stessi che hanno fatto scappare gli elettori. Per colpa del loro appiattimento sul disastro del Covid. Il leader ha le sue colpe e paga soprattutto l’appoggio a Mario Draghi (voluto pure dai detrattori).Nel Carroccio la minoranza si muove ma per ora il capo è saldo al comando. Roberto Maroni attacca Matteo Salvini sui giornali: «Serve un nuovo segretario». E le bordate arrivano pure dal Senatur e da Roberto Castelli. Al consiglio federale però la leadership non viene messa in discussione. Anche se la base ribolle.Lo speciale comprende due articoli.Che la sindrome di piazzale Loreto sia tra le patologie più diffuse in Italia non lo scopriamo certo oggi: dalla fine della seconda guerra mondiale siamo abituati a vedere capi politici prima osannati anche oltre il limite della decenza e poi calpestati dagli stessi che prima li applaudivano. Scene di questo genere si ripetono, con varie gradazioni di violenza, da diversi decenni. In queste ore la deleteria malattia sta iniziando a contagiare anche alcuni settori della Lega, i cui portavoce hanno affilato i coltelli e si apprestano a conficcarli nella schiena o nel ventre (a seconda del coraggio dei singoli) di Matteo Salvini. Al Capitano leghista viene imputato il deludente risultato alle elezioni, il che è anche abbastanza normale: a chi guida la baracca spettano oneri e onori. E non siamo così ingenui da credere che l’assalto degli (ex) amici al leader indebolito non rientri fra le specialità della casa dell’universo politico. Non è sicuramente piacevole, ma rientra nella normalità pure il fatto che gli avversari politici sguazzino nelle beghe interne, le alimentino e le facciano deflagrare a livello giornalistico, cosa che in queste ore sta accadendo attorno al «caso Salvini», come l’ha chiamato ieri in prima pagina Repubblica. Lo stesso quotidiano, sempre nel pomeriggio di ieri, ha sfoderato un titolo lisergico: «La rivolta della vecchia Lega contro Salvini. Bossi fuori dal Parlamento dopo 35 anni: “Il popolo del Nord va ascoltato”».Appena sotto, appariva una robusta intervista a Roberto Maroni con un titolo altrettanto suggestivo: «Serve un nuovo segretario». Tutto prevedibile e financo comprensibile, chiaro. Ma suscita comunque uno strano miscuglio di sentimenti - un po’ pena e un po’ ilarità - vedere il giornale progressista appiccicarsi a due suoi nemici storici pur di azzannare Salvini. Ognuno si sollazza come può.Al di là delle questioni emotive (provocano un filo di tristezza anche certi commendatori leghisti pronti a sfoderare il dente avvelenato), ci sono alcuni temi strettamente politici che meritano di essere affrontati con una certa serietà specie ora che il centrodestra unito si appresta a governare, e dagli equilibri interni ai partiti dipenderanno anche le dinamiche di coalizione. Non c’è dubbio che una riflessione interna alla Lega si imponga, anzi è necessaria visto il calo dei consensi: al netto della tendenza a disamorarsi rapidamente spesso mostrata dall’elettorato in tempi di «likecrazia», come l’ha definita Daniele Capezzone, è ovvio che qualcosa non sia andata nel verso giusto. Già, ma cosa? Tutti, manco a dirlo, puntano l’indice nodoso contro Matteo Salvini. E che il segretario abbia commesso vari errori sarebbe stupido negarlo. In alcuni casi, forse, è stato mal consigliato, ma un buon capo deve scegliersi buoni consiglieri. Su altre faccende si è trattato più che di peccati, di omissioni, ma comunque dolorose per una fetta di elettorato.Ora gli viene rimproverato, per dire, di avere trascurato le istanze autonomiste. Ed è difficile negare che sia così, non a caso il malumore della componente indipendentista cova da tempo. Volti storici come Roberto Castelli lo hanno apertamente manifestato in queste settimane, ma non è che prima lo avessero nascosto, e non li si può rimproverare di essere incoerenti. Nel primo governo Conte, Salvini era vicepremier, e riuscì a piazzare anche un ministro per le Autonomie, Erika Castelli. Che cosa abbia portato a casa di notevole non è dato sapere. Nello stesso governo i leghisti esprimevano anche un ministro dell’Istruzione, il cui apporto è stato sinceramente deludente. Detto questo, seriamente pensiamo che a tirare giù il partito dalle vette sia stata la scarsa attenzione alle richieste venetiste, come sostengono in parecchi adesso, specialmente fra gli esponenti più vicini a Luca Zaia? O forse vogliamo credere che la mancata elezione di Umberto Bossi possa giustificare un pubblico linciaggio del capo fallito? Dai. Si inchiodi pure Salvini alle sue colpe, gli si rinfaccino pure le uscite becere, la gestione un po’ ballerina di casi problematici (vedi Morisi), o la carenza d’attenzione ai temi etici pur dopo gli sventolamenti di rosari in favore di camera. Ma urge fissare un paio di punti. Il Capitano, quando stava sugli allori, di certo non passava le giornate a parlare di Padania. Magari si faceva troppi selfie, ma non è stata la questione autonomista a danneggiarlo così tanto (altrimenti i suoi seguaci delusi non avrebbero votato Fdi). Gli si può certo rinfacciare il Papeete, per carità, ma è inutile nascondersi che a provocare il crollo elettorale non siano stati i mojito. No, il disastro lo ha causato la scriteriata gestione della pratica Draghi. L’ingresso nel governo dei Migliori ha logorato Salvini, i voti sulle misure restrittive hanno fatto infuriare anche alcuni tra i più fedeli ammiratori, e hanno messo in difficoltà più d’uno nel partito.Più in generale, potremmo dire che sia stato lo schiacciamento sulla narrazione prevalente (il famigerato mainstream) a favorire il tracollo. Sorte condivisa da Giuseppe Conte, che però non solo ha potuto sbandierare al Sud il reddito di cittadinanza (provvedimento inviso a tanti leghisti), ma è pure riuscito a vendersi con furbizia la fuoriuscita dall’esecutivo, cosa che Matteo non ha potuto fare. Ed eccoci al punto: perché Salvini è apparso a tratti avere le mani legate? Perché i suoi supposti sodali remavano contro. Adesso Zaia, Fedriga e addirittura Fontana, pur con intensità differente e talvolta mandando avanti i propri scherani invocano il confronto interno. Ma quanti voti hanno fatto perdere con la loro gestione del Covid? Ricordiamo che i governatori si sono voluti vendere come poliziotti del regime sanitario, con intemerate continue e talvolta violente contro i dubbiosi e i critici. Che lo abbiano fatto per convinzione o calcolo poco cambia. Quanti voti hanno fatto perdere gli idranti sui portuali di Trieste? E quanti i voti malefici a favore del green pass? Chiediamo: chi ha spinto per questi voti? Chi ha insistito sulla fedeltà a Draghi? Facile: molti di quelli che stanno invocando la resa dei conti. I governatori, i giorgettiani entusiasti, gli ex compagni di strada come Maroni che ancora a novembre 2021 invocava un super governo a guida Draghi tramite Repubblica. Si facciano allora tutti i processi del mondo, e ben venga che i capi si prendano le loro responsabilità. Ma un esame appena più allargato potrebbe, se non riequilibrare i carichi di colpa, evitare ulteriori delusioni in un futuro non troppo lontano.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/dopo-i-voti-vogliono-perdere-anche-salvini-2658348995.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="nel-carroccio-la-minoranza-si-muove-ma-per-ora-il-capo-e-saldo-al-comando" data-post-id="2658348995" data-published-at="1664312679" data-use-pagination="False"> Nel Carroccio la minoranza si muove ma per ora il capo è saldo al comando Matteo Salvini raduna i colonnelli della Lega in via Bellerio a Milano per il consiglio federale. E riparte, «con lo sguardo rivolto soprattutto al futuro» e «ai problemi da risolvere grazie al nuovo governo di centrodestra, di cui la Lega sarà parte fondamentale», dopo il risultato elettorale del 25 settembre, che ha visto il partito dimezzare i propri voti alle elezioni politiche: la Lega aveva ottenuto 17,3% nel 2018 mentre alle europee dell’anno dopo era arrivata addirittura fino al picco del 34,3%. In questi cinque anni ne è passata molta di acqua sotto i ponti. In Lombardia e Veneto inizia a montare un certo malumore. C’è tensione, anche in vista delle regionali in Lombardia del prossimo anno, per un risultato elettorale che ha portato Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni a essere il primo partito nel Nord. Ma, al netto delle bordate arrivate soprattutto dagli ex dirigenti della Lega di Umberto Bossi, la leadership di Salvini non è in discussione. A ribadirlo, tra i primi a uscire da un consiglio federale durato più di quattro ore, è Marco Zanni. «Salvini è il leader della Lega e continuerà a esserlo», dice l’europarlamentare a chi gli domanda se durante l’incontro si è parlato della possibilità di sostituire il segretario federale. «Assolutamente no», è la risposta netta. Del resto, a parte quello del 5 aprile 2012 durante le inchieste sull’ex tesoriere Francesco Belsito con le storiche dimissioni di Bossi, non si ricordano consigli federali degli ultimi anni che abbiano sconvolto gli assetti del partito. Così è stato anche quello di ieri, alla presenza di tutti i big, dai governatori di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, Attilio Fontana, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, fino al neosenatore Claudio Durigon, al ministro Giancarlo Giorgetti e all’europarlamentare Lorenzo Fontana. Insomma, nonostante le sirene e i retroscena delle ultime ore, Salvini resta saldo al comando. Almeno per il momento. Di certo le truppe bossiane e vicine all’ex segretario Roberto Maroni stanno iniziando a riorganizzarsi. In ogni caso, «c’è rammarico per la percentuale raggiunta che si sperava migliore», dicono dalla segreteria leghista. Il motivo? La convivenza forzata con Partito democratico e 5 stelle al governo di Mario Draghi che ha allontanato l’elettorato da Nord a Sud, con uno spostamento evidente verso Fdi. In ogni caso, in Lega c’è «soddisfazione per i 95 parlamentari eletti (che Salvini riunirà giovedì pomeriggio a Roma), ma soprattutto c’è la richiesta unanime di vedere Salvini dentro il nuovo governo: la prossima settimana è previsto un nuovo consiglio per fare il punto sull’esecutivo. La base nordista però ribolle. Paolo Grimoldi, ex storico colonnello leghista già segretario della Lega in Lombardia, è sulle barricate. Vuole un congresso della vecchia Lega Lombarda. «Abbiamo perso. Serve un momento di confronto per dare voce a tutti». C’è anche grande amarezza tra chi non è riuscito a entrare in Parlamento, tra cui il fondatore Bossi (dopo 35 anni) ma anche soprattutto il tesoriere, Giulio Centemero. «Non si è mai visto in Italia un partito senza un tesoriere eletto, con le dovute garanzie giuridiche», spiega un dirigente di vecchia data a microfoni spenti. I due, forse, potrebbero rientrare anche grazie alle complicate regole del Rosatellum. C’è da dire che la giornata non era incominciata nel migliore dei modi in via Bellerio. Di prima mattina l’articolo sul Foglio firmato da Maroni, dal titolo «È l’ora di un nuovo leader della Lega», aveva dato inizio alle danze. Per Bobo ci vuole «un congresso straordinario. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma per adesso non faccio nomi». Poi aveva continuato lo stesso Bossi. «Il popolo del Nord esprime un messaggio chiaro e inequivocabile che non può non essere ascoltato», ha fatto sapere il Senatur. «Adesso Salvini dovrebbe cambiare nome al partito. Lega Salvini premier è démodé», gli ha fatto eco l’ex ministro leghista, Roberto Castelli. A lato delle schermaglie, esterne e interne, restano i dati. La Lega, come fa notare l’istituto Cattaneo specializzato nelle analisi dei flussi elettorali, perde voti in tutte le direzioni. In particolare, c’è una perdita significativa di consensi proprio verso Fdi. Ma praticamente ovunque si registrano spostamenti di voti, anche verso Forza Italia (rilevanti verso il Sud) e verso l’astensione. In alcune città, per di più, si registrano flussi di voti verso Azione e il Partito democratico. Questi dati sembrano dunque mettere in luce che la mobilità elettorale tra il 2018 e il 2022 ha attraversato due fasi abbastanza diverse. Nella prima (tra il 2018 e il 2019) vi è stato un significativo travaso di voti dal centrosinistra (in particolare dal M5s) al centrodestra (di cui ha inizialmente beneficiato la Lega). Nella seconda (dal 2019 a oggi) gli schieramenti sono rimasti stabili mentre sono avvenuti importanti spostamenti di voti al loro interno: in particolare, il centrodestra ha visto Fdi «cannibalizzare» l’elettorato dei partner di coalizione, e in particolare quello - nel 2019 molto ampio - della Lega. La ricetta di Salvini per rilanciare il partito è puntare subito sui provvedimenti contro il caro bollette, autonomia regionale e Quota 41. La Lega chiederà di inserire il tema dell’autonomia nel primo Consiglio dei ministri.
Michela Moioli posa con la sua medaglia di bronzo durante la cerimonia di premiazione della finale femminile di snowboard cross ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, a Livigno (Ansa)
La quiete dopo la tempesta. Dopo la sbornia di giovedì, con gli ori che ancora luccicano al collo di Federica Brignone e Francesca Lollobrigida e l’argento di Arianna Fontana, la decima giornata dei Giochi invernali in corso a Milano-Cortina ha portato all’Italia una sola nuova medaglia, la diciottesima di questa Olimpiade casalinga, e qualche delusione.
L’emozione più grande l’ha regalata Michela Moioli, protagonista di una vera e propria impresa che rispetto a quelle firmate dalla Tigre di La Salle o dalla Freccia bionda - per chi non lo sapesse sono i soprannomi da battaglia di Brignone e Fontana - ha da invidiare soltanto il colore del metallo. Perché anche qui siamo in presenza di qualcosa di epico. La trentenne di Alzano Lombardo ha conquistato un bronzo insperato nello snowboard cross, completando con coraggio una rimonta che resterà nella memoria, non solo della disciplina che si svolge sulla tavola, ma dello sport in generale. Sulla pista di Livigno, Moioli ha dovuto recuperare dallo svantaggio nei confronti delle avversarie ben due volte: prima in semifinale, superando la francese Lea Casta e l’austriaca Pia Zherkhold, poi nella big final, dove ha ripreso e superato la svizzera Noemie Wiedmer negli ultimi metri, fino a scavalcarla sul terzo gradino del podio. Podio completato dall’australiana Josie Baff, medaglia d’oro, e dalla ceca Eva Adamczykova, argento. E dire che l’avventura olimpica della campionessa azzurra non era iniziata sotto i migliori auspici. Una caduta in allenamento, pochi giorni prima della gara, aveva messo a rischio la sua partecipazione. «Quando sono stata portata in elicottero a Sondalo ho pensato che i miei Giochi fossero finiti perché ero bella rintronata dalla caduta. Ieri che c’era la gara dei maschi sono stata tutto il giorno sul divano morta. E mi sono detta «Io domani come cacchio faccio», però ho una capacità di recupero notevole. Ho una squadra fortissima che mi ha aiutato in tutto e anche il Coni e l’Esercito. Comunque, è sempre la forza del cuore quella che fa la differenza ogni volta», ha raccontato Moioli mostrando le ferite ancora fresche sul suo volto a causa del trauma facciale riportato. «Sono così, tocco il fondo e risorgo come una fenice. Stavolta l’ho fatto con la faccia distrutta».
Se la gioia dell’atleta bergamasca ha illuminato la giornata di ieri, il biathlon maschile ha riservato invece una delusione per Tommaso Giacomel. Il trentino, tra i favoriti della 10 chilometri sprint, ha chiuso ventiduesimo a 1’43» dall’oro vinto dal francese Quentin Fillon Maillet. «Ho fallito, credo che questa fosse la gara più adatta a me e ho fallito. Sono molto deluso. Arrivare qui da favorito o comunque tra i favoriti e poi performare così male è una cosa che mi fa molto arrabbiare. Sinceramente non ho idea di cosa ho sbagliato. Non è finita, però la gara di domenica è già compromessa con il risultato di oggi», ha commentato Giacomel, visibilmente provato. I compagni di squadra Lukas Hofer, Nicola Romanin ed Elia Zeni hanno chiuso rispettivamente tredicesimo, sedicesimo e oltre la cinquantesima posizione, mentre le altre due posizioni sul podio restano saldamente nelle mani dei norvegesi Vetle Sjåstad Christiansen e Sturla Holm Laegreid. L’altra amarezza per i nostri colori è arrivata nel tardo pomeriggio dal pattinaggio di velocità maschile, dove i due azzurri Riccardo Lorello e Davide Ghiotto hanno chiuso la gara dei 10.000 metri fuori dal podio. Una delusione soprattutto per Ghiotto, che si avvicinava alla «gara dei re - così viene definita la competizione più combattuta e ambita del panorama del ghiaccio olimpico - da favorito e recordman mondiale su questa distanza, oltre che vincitore di tre titoli iridati consecutivi.
Dal ghiaccio della pista lunga di Rho Fiera, dove si svolgono le gare di pattinaggio di velocità, a quello dell’Arena Santa Giulia. Nemmeno l’hockey maschile può gioire: la nazionale allenata dal ct finlandese Jukka Jalonen ha affrontato alla pari la Slovacchia, ma ciò non è bastato per evitare la seconda sconfitta (3-2) nel torneo olimpico dopo quella patita all’esordio contro la Svezia.
In una giornata «povera» di medaglie, uno dei momenti più suggestivi per il pubblico italiano presente sugli spalti è arrivato nel corso della 10 chilometri sprint di biathlon. Il francese Emilien Jacquelin, grande tifoso di Marco Pantani, ha corso con l’orecchino che gli era stato regalato dalla famiglia del campione romagnolo e, in uno dei passaggi più intensi della gara, ha lanciato la bandana proprio come faceva il Pirata prima delle sue volate in salita.
Continua a leggereRiduci
Ansa
Il processo non è recente. Già nel 1963, sei anni prima del Sessantotto, l’Università di Stanford abolì il corso di Storia della civiltà occidentale. In Italia, il disastro è cominciato nel Sessantotto, che però è eterno, sembra non essere mai finito. L’idea del professore politicamente neutrale appare da decenni una delicata contraddizione in termini: «professore di sinistra» non è più una categoria sociologica, ma una normalità data per scontata. Antonio Gramsci teorizzò la necessità di occupare i gangli del potere - magistratura, scuola, spettacolo, giornalismo - e Palmiro Togliatti lavorò perché quella strategia diventasse realtà. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: l’egemonia culturale si è trasformata in senso comune e il dissenso è percepito come una colpa morale. Anche come colpa mortale.
Sergio Ramelli è stato ucciso e ancora si irride la sua morte. La storia di Sergio Ramelli è una di quelle che mettono a disagio perché non si lasciano archiviare con una formula. Non è una «tragica fatalità», non è un «clima di tensione», non è nemmeno un «errore». È una storia semplice e proprio per questo intollerabile: un ragazzo di 18 anni ucciso a colpi di chiave inglese per un tema scolastico scritto «male», o forse scritto troppo bene, o semplicemente scritto. Ramelli non era un personaggio con un qualche peso politico, non era un capo, non era nulla di particolarmente pericoloso. Era uno studente. Ma negli anni Settanta nell’Italia che custodiva il più potente Partito comunista del mondo occidentale, bastava poco per diventare colpevoli: bastava non essere dalla parte giusta. La sua colpa fu di pensare fuori dal perimetro consentito. Il suo tema esprimeva concetti su cui si poteva e si può essere d’accordo o meno, ma era senza dubbio un tema molto ben argomentato.
Nei tempi decenti i temi potevano essere solo sull’analisi de L’Infinito di Giacomo Leopardi o sulla figura di don Abbondio. In tempi ignobili i temi sono di «attualità», vale a dire di politica, vale a dire di indottrinamento, perché il tema di Ramelli era comunque un ottimo tema e prese un’insufficienza, dimostrando che la libertà di opinione millantata dalla nostra costituzione è, insieme a «La legge è uguale per tutti», uno spettacolare esempio di umorismo involontario. E l’insufficienza è ancora il meno. La scuola, che avrebbe dovuto proteggerlo, lo segnalò. La politica, che avrebbe dovuto ignorarlo, lo marchiò. La violenza, che non aveva bisogno di molte giustificazioni, fece il resto. Sergio Ramelli morì dopo settimane di agonia. Ne dà una dolente testimonianza sua madre, che giorno dopo giorno gli tenne la mano sperando in un miracolo che non venne, mentre sui muri e sui ciclostili si sghignazzava per l’agonia e la morte del suo ragazzo. E per molto tempo, più della sua morte, fece rumore il silenzio. Un silenzio educato, responsabile, quasi morale, quello degli educati moralmente superiori, quello dei responsabili, perché alcune vittime disturbano l’educato e sempre etico arredamento ideologico. E allora si preferisce non nominarle, come certi parenti imbarazzanti alle cene di famiglia.
La storia di Sergio Ramelli non insegna nulla, dicono. Ed è proprio questo che fa paura. Insisto: un buon professore - come un buon magistrato - dovrebbe essere qualcuno di cui è impossibile indovinare le idee politiche. Non perché non ne abbia, ma perché non le manifesta nel suo lavoro e rinuncia persino a esibirle nello spazio pubblico, consapevole che la sua imparzialità, come la virtù della moglie di Cesare, deve essere al di sopra di ogni sospetto. Dove l’imparzialità è al di sotto di ogni sospetto, prendiamo atto che la moglie di Cesare è di facili costumi. Magistrati ufficialmente schierati arricchiscono la giurisprudenza di sentenze indubbiamente creative, mentre professori apertamente schierati stigmatizzano e deridono non solo idee politiche diverse dalle loro, ma anche posizioni etiche e religiose tradizionali. Il cristianesimo «forte» viene trattato come un residuo imbarazzante: dalla condanna dell’aborto come omicidio alla considerazione dell’cosiddetta omosessualità come peccato, ogni visione non conforme viene liquidata come segno di spregevole arretratezza morale. Per inciso: anche in epoca di pandemia Covid non pochi professori hanno manifestato pubblicamente la loro perplessità per gli studenti non inoculati e li hanno indicati al pubblico ludibrio come potenziali untori. I professori che non si sono inoculati sono stati sospesi senza stipendio e i loro colleghi lo hanno trovato giustissimo, vista la mancanza di una qualsiasi forma di solidarietà. Quando poi sono rientrati, questi docenti non hanno potuto subito insegnare: c’era il rischio che insegnassero la libertà e il coraggio. Sono stati rinchiusi negli sgabuzzini e nei sottoscala a contare i ragni. Così la scuola, da luogo del sapere, diventa spazio di rieducazione. E il professore imparziale resta, appunto, una creatura mitologica.
A chiarire la natura profonda di questo processo è stato il filosofo francese Jacques Ellul. Nel suo libro Propaganda, Ellul spiega che il mezzo più potente di indottrinamento nelle società moderne non è la propaganda esplicita dei regimi totalitari, bensì quella silenziosa e pervasiva delle democrazie avanzate, una propaganda che «educa». Secondo Ellul, la scuola rappresenta lo strumento privilegiato di questo meccanismo, perché non solo in non pochi casi arrotondi la realtà, per cui, ad esempio, le decine di milioni di vittime del comunismo sono scomparse, ma perché seleziona i quadri mentali attraverso cui le nozioni vengono interpretate. L’indottrinamento moderno non consiste nel dire cosa pensare, bensì nel delimitare ciò che è pensabile. Una volta interiorizzati certi presupposti morali e ideologici, il soggetto crede di ragionare liberamente, mentre in realtà si muove all’interno di un recinto invisibile. Ellul sottolinea come l’educazione sia particolarmente efficace proprio perché rivolta ai giovani, quando le difese critiche non sono ancora formate e l’autorità dell’istituzione scolastica gode di una legittimazione quasi sacrale. Ciò che viene insegnato a scuola non viene percepito come opinione, ma come evidenza, non come ideologia, ma come neutralità scientifica. È in questo modo che la propaganda diventa totalizzante: quando smette di apparire come tale. Applicata al contesto contemporaneo, l’analisi di Ellul illumina con precisione inquietante il funzionamento della scuola odierna. Non si tratta più di discutere la storia, ma di giudicarla; non di comprenderla, ma di condannarla. L’Occidente non è studiato come civiltà complessa, contraddittoria e plurale, bensì come colpevole originario da decostruire. E lo studente non è chiamato a formarsi un’opinione, ma a espiare. Solo odiando l’Occidente e spaccando la testa di Sergio Ramelli o del poliziotto che cerca di proteggere Torino guadagnerà l’innocenza. In questo quadro, il pluralismo non è assente per caso: è strutturalmente incompatibile con l’obiettivo. Perché, come Ellul avvertiva, la propaganda più riuscita è quella che riesce a presentarsi come educazione morale. E la scuola, da luogo del sapere, diventa così il più efficiente laboratorio di conformismo spietato. Sia coloro che hanno spaccato le ossa del cranio di Sergio Ramelli, che quelli che hanno tentato di spaccare quelle del poliziotto aggredito a Torino, sono studenti: frutti di una scuola ideologizzata, quindi, per definizione, una scuola cattiva, anzi pessima, l’ultimo baluardo della mai veramente defunta Unione sovietica. È la scuola che ha armato con la chiave inglese o il martello.
Continua a leggereRiduci
«Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» (Disney+)
Allora, si dice la passione fosse ormai sopita, logorata da un'esposizione mediatica eccessiva, da incomprensioni e battibecchi, da un chiacchiericcio che, a distanza di oltre venticinque anni, ancora non ha perso veemenza. Cosa sia successo dentro quell'amore da filma, tra persone che sembravano essersi scelte senza riserve, sole tra mille, nessuno lo ha mai saputo con certezza. La cerchia di John F. Kennedy Jr. riferisce di sensibilità diverse, cuori distanti. Voleva figli, l'erede della dinastia Kennedy. Si avvicinava ai quaranta e avrebbe voluto la moglie gli consentisse di allargare la famiglia.
Ma Carolyn non avrebbe avuto alcun istinto materno. Carolyn, ex commessa con un lavoro nella moda. Carolyn, che le cronache descrivono cocainomane. Carolyn, che nei racconti degli amici voltava la testa dall'altra parte, ogniqualvolta il marito toccava l'argomento.Gli affetti più cari di John John sostengono lui stesse per chiedere il divorzio. Prima, però, sarebbe andato al matrimonio della cugina, portando con sé la moglie, un abito nero di Yves Saint Laurent comprato da Saks, e la cognata. Guidava lui il Piper Saratoga che, il 16 luglio 1999, è decollato alla volta di Martha's Vineyard, senza mai arrivarvi. Quel piccolo aereo è caduto nel mare, John e Carolyn sono morti, con loro la sorella di lei. L'amore da film s'è interrotto quel giorno, è finito prima che un giudice lo rendesse carta straccia, prima che i giornali facessero a pezzi il ricordo di quel che erano stati. La coppia più bella degli Stati Uniti d'America è morta, e - venticinque anni più tardi - è una serie tv a ritrovarla.
Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, su Disney+ a partire da venerdì 13 febbraio, vuole ricostruire quell'amore da film. Dagli inizi, dal primo incontro all'interno di Calvin Klein, quando Carolyn, bionda ed etera, si era ormai affrancata dal ruolo di commessa per diventare dirigente e confidente di CK. Lo show, che alla regia porta la firma di Ryan Murphy, racconta come la coppia si sia innamorata, come lo scapolo d'oro sia diventato marito, gli americani pazzi di quel duo-gioiello. Ma racconta altresì come i media, la sovraesposizione, abbiano pian piano minato la serenità della coppia. Di Carolyn, in particolare, una donna della porta accanto che non avrebbe mai voluto essere oggetto della bulimia dei rotocalchi.
Continua a leggereRiduci
A spiegarci di che cosa si tratti è stato anche il Corriere della Sera, che giovedì così titolava la recensione: «Gestazione per altri, storia di solidarietà». Ovvero, come far passare la pratica dell’utero in affitto per «una storia d’amore, solidarietà, rispetto, al di là di ogni ideologia». Potenza artistica della rappresentazione, di e con Rossella Fava, autrice e attrice, che sui social racconta di aver «preso spunto dalle interviste che ho realizzato nel giro di un anno, a uomini e donne che hanno affrontato percorsi di Pma e Gpa».
Sulla piattaforma del Teatro della Cooperativa lo spettacolo viene presentato come «un testo importante e necessario che affronta un tema complesso e ancora troppo poco conosciuto, di estrema delicatezza, e che nel nostro Paese, a differenza di altri, fatica ancora a trovare una legislazione più giusta e più umana».
Senza mezzi termini, si definisce dunque disumana la legge italiana che vieta la surrogata e la rende reato universale. Non bastasse, viene lanciata questa provocazione: «Oggi chi è madre? Chi un bambino lo partorisce o chi lo desidera e lo cresce?».
E per togliere anche l’ultimo dubbio sulla collocazione ideologica dell’iniziativa, il pubblico è informato che domenica 15 febbraio «al termine dello spettacolo, ci sarà un incontro con Francesca Re, avvocato e consigliere generale dell’Associazione Luca Coscioni Aps», che vuole la legalizzazione dell’eutanasia, la gestazione per altri e le tecniche di fecondazione assistita per le coppie dello stesso sesso. Venerdì prossimo, 20 febbraio, sempre al termine dello spettacolo «ci sarà un incontro con l’Associazione Famiglie Arcobaleno», composta da genitori Lgbt.
«Non conosco questo spettacolo ma il modo in cui viene presentato è sufficientemente eloquente. C’è un continuo, tenace tentativo di presentare l’utero in affitto come un gesto solidale, mentre è una organizzazione commerciale, sempre regolata da un contratto e da passaggi di denaro», interviene con fermezza Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità. «È una pratica che lede nel profondo la dignità delle donne e i diritti dei bambini. Nonostante la ricerca spasmodica di storie che dimostrino il contrario, la verità è che dietro l’utero in affitto c’è un mercato transnazionale che commercializza i corpi, i bambini, la genitorialità. Ci sono dei contratti molto rigidi, delle penali, uffici legali e clausole durissime, cataloghi di ovociti come fossero merce da banco, giri vertiginosi di denaro, del quale di norma alle donne bisognose che portano avanti le gravidanze vanno le briciole».
Il ministro sottolinea: «In Italia l’organizzazione, la realizzazione e anche la pubblicizzazione di queste pratiche è reato da più di vent’anni, e la legge approvata in questa legislatura, che impedisce di aggirare il divieto e rende l’utero in affitto punibile per i cittadini italiani anche se vanno all’estero a praticarlo, pone il nostro Paese all’avanguardia nella lotta per i diritti delle donne e dei bambini. Siamo un esempio per il mondo, e stiamo lavorando per costruire un’alleanza internazionale contro questa barbarie. Nessun tentativo di “normalizzarla” o spacciarla per una pratica solidale potrà cambiare la realtà».
Invece, in questi giorni la maternità surrogata viene spacciata come un gesto altruistico lanciando un messaggio devastante dal palcoscenico di un teatro che riceve contributi statali e regionali. L’associazione, fondata nel 2002 dal drammaturgo, regista e attore Renato Sarti e che ha come obiettivo «fin dalla sua fondazione, la promozione dei valori della memoria storica e dell’antifascismo», mostra la contabilità solo fino al 2024. In quell’anno aveva ricevuto dal ministero della Cultura 113.838 euro; dalla direzione Cultura area spettacolo del Comune di Milano 52.898,18 euro; dalla Regione Lombardia, direzione generale cultura, tre acconti per complessivi 20.800 euro. Gli anticipi 2025 del ministero della Cultura sono di 63.555,76 euro; dalla Regione Lombardia di 27.000 euro. L’acconto contributo per le attività 2026 è di 18.900 euro, 18.900 euro l’importo per quelle del 2027. Sicuramente le cifre liquidate saranno ben superiori. Nella graduatoria Next - Laboratorio delle idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo 2025/2026, «M(Other)» era stato selezionato con il punteggio 73 su 100. E aveva ricevuto un «rimborso spese» di 10.500 euro.
Alla trasmissione Il Suggeritore Night Live di Radio Popolare, a cura di Ira Rubini, Rossella Fava ha spiegato di essere cresciuta «con l’immagine della donna con il pancione e che partorendo sarebbe stata lei la mamma del bambino ma oggi, grazie al progresso della scienza e della tecnica in maniera di procreazione, grazie alla gestazione per altri, di madri tra virgolette ce ne possono essere fino a tre. La donna che partorisce il bambino, la donna che fornisce il materiale genetico e la donna che invece lo desidera e lo crescerà. La mamma diventa doppia o trina». Ecco, con quale atteggiamento si affronta a teatro un reato universale. Sempre a Radio Popolare, il regista Sarti (che a settembre era tra coloro che manifestavano «giù le mani dal Leoncavallo»), ha definito «bella l’dea di tre donne in un unico corpo, soprattutto in un periodo di maschilismo esasperato».
Continua a leggereRiduci