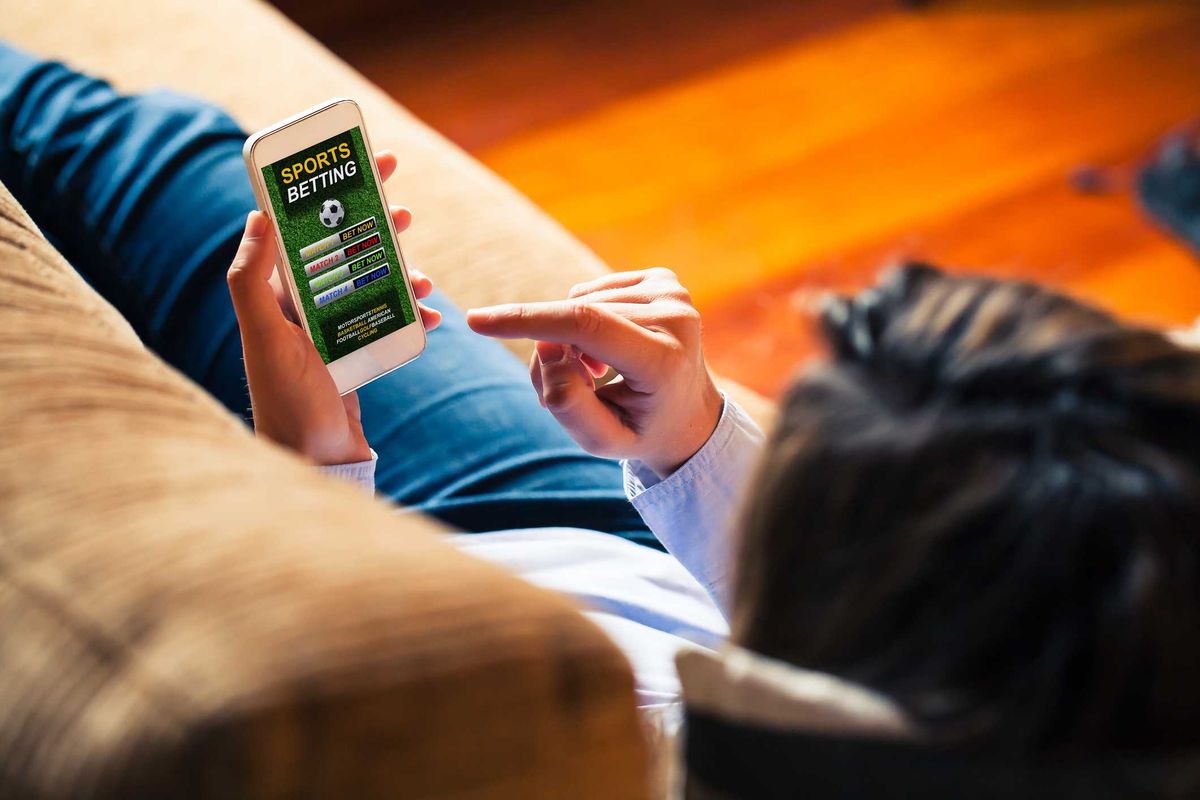Un tempo chiunque le teneva a portata di mano, poi è scattata la guerra alle calorie. Ma una (e basta) al giorno può avere effetti benefici sulla salute.Un tempo chiunque ne aveva in tasca, in borsa, in casa. Oggi, non sono più un elemento imprescindibile perché viviamo in un'epoca che demonizza «i dolci» cioè lo zucchero visibile, seppure poi rimpinzi di zucchero pressoché tutti i cibi prodotti industrialmente, dall'hamburger ai cibi in scatola e precotti. Quello zucchero invisibile ha molti nomi (sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio Hcfs, zucchero di canna, glucosio, destrosio, fruttosio, saccarosio, maltosio, dolcificante, edulcorante, idrato di carbonio, levulosio, saccaride eccetera). Ma tornando allo zucchero visibile, dovremmo ritornare ad apprezzare la sua applicazione più iconica e minimalista. Cioè le caramelle, nate come «zuccherini» curativi, poi per lo più diventate zuccherini e basta: beh, dovremmo recuperarle in entrambe le modalità. La storia della caramella non permette una ricostruzione fatta di certezze, come molti altri percorsi alimentari, ma di ipotesi. Per molto tempo, gli unici dolcificanti puri nel paniere dei cibi a disposizione furono miele e canna da zucchero. In Europa, conoscemmo la canna da zucchero grazie alle Crociate del XII secolo che condussero gli europei nelle terre mediorientali dove gli Arabi avevano imparato dai Persiani (che già dal III secolo lo avevano a loro volta imparato dall'India, importando da lì la coltura) la coltivazione della dolce canna e la fabbricazione del suo sciroppo zuccheroso in forma solida, particolari panetti conici che poi venivano grattugiati detti calamellus. Erano, diremmo oggi, una specie di «maxi caramella» e in effetti la parola «caramella» probabilmente deriva da quel calamellus, che a sua volta è diminutivo di calămus cioè canna, con la quale si indicava la canna da zucchero, chiamata anche canna mellis, cioè «tubo di miele».una spezia per ricchiNel dodicesimo secolo, dunque, si impianta la canna da zucchero in Europa, principalmente Grecia, Italia e Francia, ma resta una spezia per ricchi, venduta in farmacia a prezzo altissimo. Con la scoperta dell'America la canna da zucchero delle Canarie arriva a Santo Domingo tramite Cristoforo Colombo e da lì si espande in gran parte delle terre conquistate, ma neanche questo trasforma lo zucchero in un bene a disposizione di tutti com'è oggi. Questo avviene qualche secolo dopo, in concomitanza innanzitutto con la Rivoluzione industriale, quando, da una parte, lo zucchero di canna proveniente dalle colonie inglesi diventa abitudine alimentare anche per i proletari, i quali, braccia dell'industrializzazione, iniziano ad assumere energizzanti come zucchero, caffè, tè, alcol e tabacco. Come spiega Sidney Mintz in Storia dello zucchero, sono «sostanze trasformate dal capitalismo britannico da lussi delle classi ricche in necessità delle classi lavoratrici». Quella democratizzazione non era un regalo: «L'introduzione di alimenti come il saccarosio rese possibile l'aumento del contenuto calorico nelle diete dei proletari senza aumentare proporzionalmente la quantità di carne, di pesce, di pollame e di latticini». Dall'altra parte, diventa disponibile uno zucchero europeo, derivante dalla barbabietola da zucchero, la cui coltivazione e lavorazione Napoleone Bonaparte volle fortemente (nel 1812 conferì la Legione d'Onore a a Benjamin Delessert, realizzatore del primo panetto di zucchero di bietola). Tutti così divennero grandi consumatori di zucchero: se la decolonizzazione in corso aumentò i prezzi dello zucchero di canna determinando il semi fallimento di chi lo importava in Europa, non v'era problema, perché ora c'era quello europeo da barbabietola. All'inizio del ventesimo secolo i tre quarti dello zucchero consumato nel mondo provenivano dalla barbabietola da zucchero; nel ventunesimo su 111 produttori mondiali, 73 coltivano canna da zucchero rifornendo i tre quarti del consumo. Nelle due Guerre mondiali l'approvvigionamento di zucchero diventa difficile e, spiega Mintz, «al tempo della Prima guerra mondiale il razionamento forzato di zucchero era ormai considerato come la più seccante delle piccole privazioni quotidiane causate dal conflitto - privazioni che naturalmente erano sentite molto più acutamente dai cittadini britannici più poveri e meno privilegiati. Tra i poveri, infatti, la passione per il tè dolce, per il pasticcio di melanzane, per la crema di latte condensato, per i biscotti, per il pane e marmellata, per le caramelle e per il cioccolato fu una passione acquisita molto presto e fin troppo bene».barbabietola e cannaCome spiega Caramelle che curano. Dalla tradizione tutte le tecniche per realizzare in casa piccole delizie che fanno bene alla salute della collana I ricettari del frate, era da poco che la maggiore quantità di materia prima disponibile con l'avvento dello zucchero da barbabietola, di foggia diversa da quello di canna anche perché bianco e perfettamente solubile, aveva permesso di produrre sempre più tondini di zucchero aromatizzati oltre alle pasticche di orzo, note per l'effetto di «mollificare la tosse», cioè mucolitico. Sono le due anime della caramella che ancora esistono: piacere per il palato, «pillola» per l'organismo. In tanti casi, sono anime presenti contemporaneamente, perché tante caramelle sono concepite per essere buone e al contempo curare piccole problematiche e forse anche per questo motivo sono molto nominate nei ricettari. Nel libro Il confetturiere piemontese: che insegna la maniera di confettare frutti in diverse maniere far biscottini, marzapani, canestrelli, acquavita, sorbetti, e molte altre cose appartenenti a tal arte del 1790, si spiega come preparare «caramelle d'ogni sorta» mettendo a «cuocere il zucchero alla cottura detta caramel». Pur senza termometri elettronici (lo zucchero caramellizza per le caramelle dure a circa 145-150 gradi, è il livello di cottura detto gran cassé) o, per dire, il cannello caramellatore che oggi va per la maggior per caramellare lo zucchero in cima alla creme brulé, si usavano i dati empirici: «Si bagna il dito nel zuccaro e subito si mette nell'acqua fresca, indi si mette sotto i denti, e se non si attacca ai medesimi, e che sii alquanto croccante, allora sarà cotto, e si versa poco per volta, sopra una pietra, indi si mette cadun pezzetto in carta. Se volete dargli qualche gusto, od odore, bisogna metterlo nel zuccaro quando bolle».boom industrialeFino alla Seconda guerra mondiale, i metodi di preparazione delle caramelle non erano poi così mutati. Erano sempre più diffuse, ma non ancora un prodotto alimentare così quotidiano. Lo diventano dopo quel conflitto, quando con la produzione industriale del cibo e il boom economico cambia tutto e anche il settore delle caramelle presenta un vero e proprio exploit, che scodella sugli scaffali dei consumatori caramelle in ogni foggia e colore: restano residuali preparazioni artigianali e curative, come quelle dei monaci, ma anche quelle di piccole aziende oppure di grandi aziende che però optano per la concezione artigianale e medicamentosa della caramella. Sempre Mintz ci spiega che poi, «tra 1955 e 1965 l'uso pro capite di certi dolci e zuccheri, come per esempio le caramelle, diminuì di fatto del 10%. Durante lo stesso periodo, però, il consumo pro capite di dessert a base di latte congelato salì del 31%, quello di dolci sfornati del 50% e quello di bibite gassate del 78%». Pur registrando oscillazioni di consumo e una sempre maggiore diffusione della caramella come zuccherino di piacere per il palato, più che come ovulo terapeutico, la caramella non passa mai di moda. Sono i dolciumi per eccellenza, d'altronde sono composte di quasi solo zucchero, comune denominatore di qualunque caramella: quelle senza zucchero, indicate per diabetici o persone a dieta, contengono edulcoranti alternativi come sorbitolo, xilitolo e maltitolo (i cosiddetti polialcoli). Allo zucchero si addizionano, oggi, non soltanto gli ingredienti per «gusto e odore» del nostro confettiere piemontese che probabilmente, vedendo quali livelli ha raggiunto oggi la caramelleria, resterebbe esterrefatto. Si aggiungono aromi, acidificanti, addensanti, conservanti, coloranti e chi più ne ha più ne metta. La caramella di oggi deve durare di più e soddisfare non solo olfatto e palato, anche la vista e il tatto. Si pensi, per esempio, al gran successo delle caramelle gommose, comprese le rotelle e i tubicini di liquirizia. La produzione industriale delle caramelle è molto diversa da quella casalinga. Si prepara lo sciroppo di acqua e zucchero che poi si riscalda tra i 130 e i 170 gradi (più la temperatura è alta, più la caramella sarà dura e croccante, perché evaporerà maggiore acqua, infatti nelle dure c'è un massimo di 3% di acqua, nelle semidure fra 3 e 7%, nelle morbide abbiamo il 7% di acqua), poi si aggiungono gli additivi, poi si «raffredda» l'impasto a 80 gradi e lo si cola negli stampi, poi lo si confeziona. Per ottenere caramelle diverse da quelle dure, si aggiunge all'impasto marmellata, pasta di nocciole, cioccolato, caffè o miele, per quelle ripiene crema al latte, grassi per le caramelle mou, gomme o gelatina per le gelées. ricompensa occasionaleAnche la caramella concepita per puro piacere ha la sua funzione nell'ambito della salute e del benessere, perché anche il buonumore è fonte di benessere e non vi è dubbio che la caramella lo attivi perché il gusto dolce piace. Il cervello, quando riceve zuccheri, attiva i meccanismi tipici della «ricompensa» e produce ormoni legati a sensazioni di benessere come la dopamina. Il problema del consumo di zucchero sorge quando lo zuccherino non è occasionale e si crea una dipendenza non differente da quella da sostanze psicoattive, dall'alcol alla nicotina. A ben vedere, però, una caramella, che pesa pochi grammi e contiene pochi grammi di zucchero, è uno zuccherino, appunto, ben più gestibile, per fare solo un esempio, di una fetta di pan di Spagna. Se prendiamo la ricetta di questo classico della pasticceria da Il grande manuale del pasticciere, abbiamo 200 grammi di uova, cioè 286 calorie, 125 grammi di farina che sono 455 calorie, 125 grammi di zucchero che sono 483 calorie. Un totale di 1.222 calorie per una teglia da 24 centimetri, che sono 12 porzioni, quindi 102 calorie a porzione. Ha più senso fare attenzione agli zuccheri, anche complessi, che consumiamo in grande quantità e magari concederci una caramella piuttosto che evitare la caramella ma prepararsi piatti di pasta da 2 etti a pranzo e a cena e in più ingollare fette di torte come se fossero noccioline. Non bisogna esagerare con gli zuccheri perché attivare questi sistemi di ricompensa in maniera incontrollata provoca un incremento della tolleranza verso gli zuccheri stessi, con il risultato di aver bisogno di sempre maggiori zuccheri, di rinunciare ai dolci con crescente difficoltà, di aumentare di peso, dell'obesità, della carie, dei problemi cardiocircolatori, del diabete. sotto controlloMa con una caramella al giorno, per esempio, ciò non può avvenire. Ce lo conferma anche il calcolo calorico: una caramella zuccherata fornisce almeno 20 calorie, che aumentano in dipendenza degli altri ingredienti. Una caramella dura ne ha circa 24, una mou 20, una caramella al latte 25, una rotella alla liquirizia 75 e una caramella senza zucchero tra le 2 e le 7 calorie. Concediamoci, quindi, una caramella quando ci sentiamo stanchi o abbiamo la pressione bassa, ma ricordiamoci anche che l'altro campo di salute nel quale la caramella veramente primeggia sono le malattie da raffreddamento: «Fino all'Ottocento quasi tutti i monasteri avevano una propria spezieria, riservata ai frati oppure aperta al pubblico. Il monaco addetto, perfetto conoscitore del mondo vegetale, si incamminava ogni giorno, con una cesta sotto il braccio, verso l'orto dei semplici o la campagna circostante alla ricerca di erbe e radici. Poi, in un laboratorio colmo di alambicchi e mortai, essiccava e conservava le piante officinali, preparava medicamenti, infusi e misture. Era il farmacista dell'epoca preindustriale». Naturalmente, anche di caramelle balsamiche - o di altra funzione salubre - non bisogna fare scorpacciate: in quel caso, infatti, oltre agli zuccheri, abbiamo anche principi attivi che vanno assunti secondo i dosaggi indicati nelle confezioni. In generale, soprattutto per quelle che realizzerete con le vostre mani grazie alle ricette che abbiamo tratto da Caramelle che curano, la giusta «porzione» di caramelle giornaliere è 4-5 al massimo.
Nadia e Aimo Moroni
Prima puntata sulla vita di un gigante della cucina italiana, morto un mese fa a 91 anni. È da mamma Nunzia che apprende l’arte di riconoscere a occhio una gallina di qualità. Poi il lavoro a Milano, all’inizio come ambulante e successivamente come lavapiatti.
È mancato serenamente a 91 anni il mese scorso. Aimo Moroni si era ritirato oramai da un po’ di tempo dalla prima linea dei fornelli del locale da lui fondato nel 1962 con la sua Nadia, ovvero «Il luogo di Aimo e Nadia», ora affidato nelle salde mani della figlia Stefania e dei due bravi eredi Fabio Pisani e Alessandro Negrini, ma l’eredità che ha lasciato e la storia, per certi versi unica, del suo impegno e della passione dedicata a valorizzare la cucina italiana, i suoi prodotti e quel mondo di artigiani che, silenziosi, hanno sempre operato dietro le quinte, merita adeguato onore.
Franz Botrè (nel riquadro) e Francesco Florio
Il direttore di «Arbiter» Franz Botrè: «Il trofeo “Su misura” celebra la maestria artigiana e la bellezza del “fatto bene”. Il tema di quest’anno, Winter elegance, grazie alla partnership di Loro Piana porterà lo stile alle Olimpiadi».
C’è un’Italia che continua a credere nella bellezza del tempo speso bene, nel valore dei gesti sapienti e nella perfezione di un punto cucito a mano. È l’Italia della sartoria, un’eccellenza che Arbiter celebra da sempre come forma d’arte, cultura e stile di vita. In questo spirito nasce il «Su misura - Trofeo Arbiter», il premio ideato da Franz Botrè, direttore della storica rivista, giunto alla quinta edizione, vinta quest’anno da Francesco Florio della Sartoria Florio di Parigi mentre Hanna Bond, dell’atelier Norton & Sons di Londra, si è aggiudicata lo Spillo d’Oro, assegnato dagli studenti del Master in fashion & luxury management dell’università Bocconi. Un appuntamento, quello del trofeo, che riunisce i migliori maestri sarti italiani e internazionali, protagonisti di una competizione che è prima di tutto un omaggio al mestiere, alla passione e alla capacità di trasformare il tessuto in emozione. Il tema scelto per questa edizione, «Winter elegance», richiama l’eleganza invernale e rende tributo ai prossimi Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, unendo sport, stile e territorio in un’unica narrazione di eccellenza. A firmare la partnership, un nome che è sinonimo di qualità assoluta: Loro Piana, simbolo di lusso discreto e artigianalità senza tempo. Con Franz Botrè abbiamo parlato delle origini del premio, del significato profondo della sartoria su misura e di come, in un mondo dominato dalla velocità, l’abito del sarto resti l’emblema di un’eleganza autentica e duratura.
iStock
A rischiare di cadere nella trappola dei «nuovi» vizi anche i bambini di dieci anni.
Dopo quattro anni dalla precedente edizione, che si era tenuta in forma ridotta a causa della pandemia Covid, si è svolta a Roma la VII Conferenza nazionale sulle dipendenze, che ha visto la numerosa partecipazione dei soggetti, pubblici e privati del terzo settore, che operano nel campo non solo delle tossicodipendenze da stupefacenti, ma anche nel campo di quelle che potremmo definire le «nuove dipendenze»: da condotte e comportamenti, legate all’abuso di internet, con giochi online (gaming), gioco d’azzardo patologico (gambling), che richiedono un’attenzione speciale per i comportamenti a rischio dei giovani e giovanissimi (10/13 anni!). In ordine alla tossicodipendenza, il messaggio unanime degli operatori sul campo è stato molto chiaro e forte: non esistono droghe leggere!
Messi in campo dell’esecutivo 165 milioni nella lotta agli stupefacenti. Meloni: «È una sfida prioritaria e un lavoro di squadra». Tra le misure varate, pure la possibilità di destinare l’8 per mille alle attività di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti.
Il governo raddoppia sforzi e risorse nella lotta contro le dipendenze. «Dal 2024 al 2025 l’investimento economico è raddoppiato, toccando quota 165 milioni di euro» ha spiegato il premier Giorgia Meloni in occasione dell’apertura dei lavori del VII Conferenza nazionale sulle dipendenze organizzata dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui Meloni ha rivolto i suoi sentiti ringraziamenti, il premier ha spiegato che quella contro le dipendenze è una sfida che lo Stato italiano considera prioritaria». Lo dimostra il fatto che «in questi tre anni non ci siamo limitati a stanziare più risorse, ci siamo preoccupati di costruire un nuovo metodo di lavoro fondato sul confronto e sulla condivisione delle responsabilità. Lo abbiamo fatto perché siamo consapevoli che il lavoro riesce solo se è di squadra».