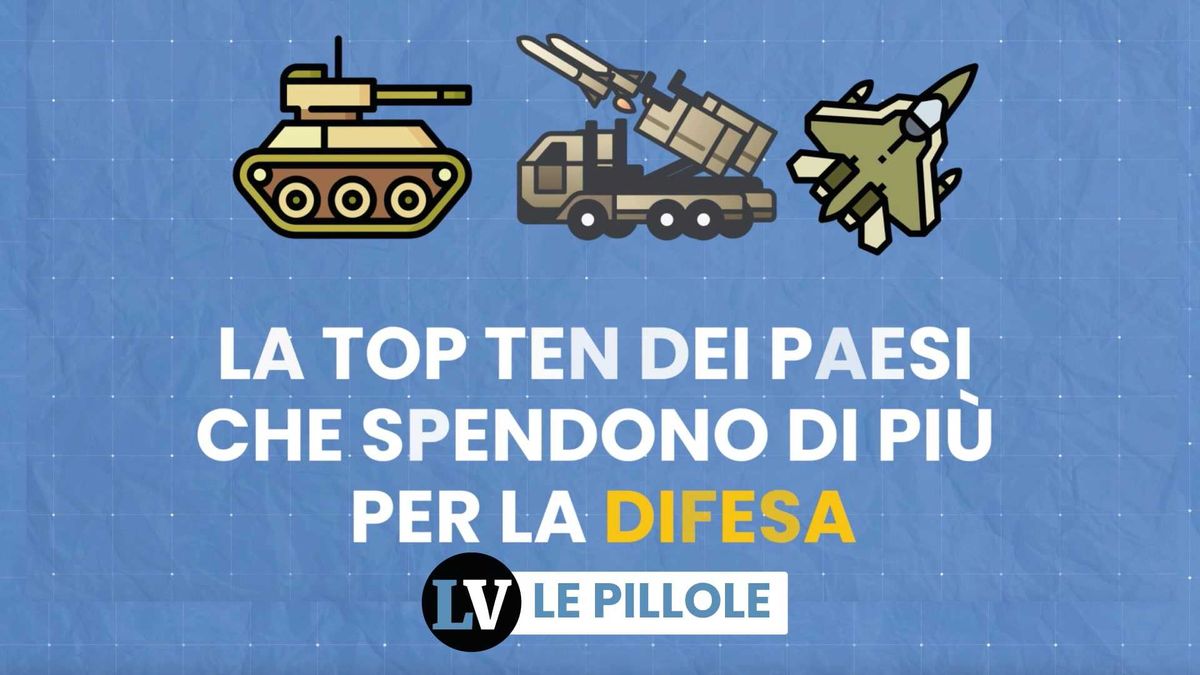Quando l’8 aprile del 1630 John Winthrop salpò dall’isola di Wight a bordo della nave Arbella aveva in mente di raggiungere la Terra promessa. Uomo di legge e politico britannico, egli guidava la prima grande ondata di colonizzazione puritana del Nordamerica. Agli altri fedeli che si apprestavano a lasciare l’Inghilterra anglicana – considerata ancora troppo corrotta dall’influenza cattolica - Winthrop regalò un sermone con i fiocchi: «Saremo come una città sulla collina. Gli occhi di tutte le genti saranno su di noi», disse. Era esattamente ciò che lui e i suoi compagni di viaggio desideravano: non tanto un luogo in cui praticare liberamente la propria fede, quanto una nuova Gerusalemme in cui dare vita alla società ideale retta dai puri secondo le leggi di Dio. O, meglio, secondo la versione delle leggi fornita dai loro predicatori.
La traversata fu rapida: nel giugno dello stesso anno i puritani sbarcarono a Salem, Massachusetts. Come scrisse Sacvan Bercovitch, essi erano passati «da un vecchio mondo depravato a una nuova terra di Canaan». Una terra da «far fiorire come una rosa»: quello era il compito degli eletti. Il progetto, insomma, era piuttosto ambizioso. E in effetti mostrò qualche piccola pecca nella realizzazione: il paradiso in Terra rivelò presto il proprio lato oscuro. Già nel 1692 ebbe inizio il processo alle streghe di Salem, che si concluse con una ventina di impiccagioni e centinaia di accuse di stregoneria rivolte a cittadine e cittadini di vari insediamenti della Nuova Inghilterra.
Letteratura e cinema si sono largamente occupati di queste vicende, consegnate all’immaginario popolare come una sorta di angolo buio della storia, una manifestazione di intolleranza e bigottismo dovuta agli eccessi della religione, e certo non replicabile nel radioso universo liberale contemporaneo. In realtà, non è difficile ritrovare nel pensiero attualmente dominante tratti dello stesso fanatismo, transitati facilmente dal piano religioso a quello politico.
Tracce rilevanti di puritanesimo si ritrovano nell’ideologia neoliberale, e negli ultimi anni sono divenute sempre più evidenti, anche al di fuori del mondo angloamericano. Dal Canada che ragiona sulla limitazione del consumo di bevande alcoliche alla Nuova Zelanda che vieta la vendita di sigarette ai nati dal 2009 in poi arriviamo alle discussioni - vagamente caricaturali - in corso in Italia sugli stessi argomenti: la lotta al fumo lanciata dal ministro Schillaci si accompagna alla campagna contro gli alcolici sostenuta da virostar come Antonella Viola.
Direte: che c’entra tutto ciò con l’entusiasmo religioso del Seicento? A un livello superficiale, le intemerate contro i vizi rimandano a una vecchia battuta di H. L. Mencken: «Il puritanesimo è l’ossessiva paura che qualcuno, da qualche parte, possa essere felice». Ma c’è pure un livello di analisi più profondo, secondo cui i recenti deragliamenti su vino e sigarette sono le manifestazioni estreme di una tendenza in corso da tempo, e che negli anni della pandemia è affiorata con particolare vigore.
Non c’è nemmeno bisogno di richiamare gli scritti di Max Weber per ricordare quanto il successo mondano fosse considerato, nel mondo calvinista, un segno evidente di elezione divina. Un successo che andava ottenuto anche tramite una forma d’ascesi. Tale concezione, nei giorni nostri, ritorna con prepotenza, purgata dell’elemento religioso. Uno stile di vita sobrio garantisce migliori prestazioni, rende l’uomo più efficiente. Da qui la straordinaria attenzione che la nostra civiltà riversa sul cosiddetto «fitness». Non si tratta di un richiamo a una sobrietà utile a garantire una salute migliore, e nemmeno di una continenza motivata da esigenze spirituali: ciò che importa è il funzionamento.
Non è un caso che questa «ascesi capitalista» sia imposta attraverso divieti e non tramite un percorso educativo o di crescita personale (come invece avveniva nei momenti più luminosi del puritanesimo). Si deve essere performanti, e chi non si adegua allo standard è considerato colpevole. Un po’ come accadeva, in tempi di pandemia, ai giovinastri che si concedevano un aperitivo sui Navigli a Milano o s’intignavano a frequentare le discoteche o addirittura volevano andare in vacanza: in un lampo furono accusati di voler spargere il virus, di non avere a cuore gli interessi della collettività.
Troviamo, qui, il carattere prettamente gnostico del puritanesimo. Come spiegava Eric Voegelin, i puritani «si considerano degli eletti e questa esperienza porta a una netta separazione tra costoro e il resto dell’umanità, con l’ovvia conseguenza che il genere umano sarà diviso nelle due categorie dei confratelli e della massa». L’eletto è illuminato dalla luce divina, ha successo, ottiene risultati. La massa, al contrario, è destinata alla perdizione. E l’unico modo che essa ha per salvarsi consiste nell’adattarsi con rigore e spirito di sacrificio alle norme di comportamento imposte dai leader: le «guide spirituali» sanno ciò che è meglio, e sono in grado di istruire adeguatamente le folle. «Tutto ciò non ha nulla a che fare con il cristianesimo», scriveva ancora Voegelin. A suo dire, non doveva trarre in inganno il costante riferimento che i puritani facevano ai testi sacri: «La mascheratura biblica non può annullare il fatto di ridurre Dio all’uomo. Il santo è uno gnostico che non lascia la trasfigurazione del mondo alla grazia di Dio al di là della storia, ma che vuol compiere lui l’opera di Dio stesso, qui e ora, nella storia».
Oggi il mondo occidentale trabocca di questi presunti santi pronti a diffondere il verbo del sistema dominante. Ci sono i profeti della Cattedrale Sanitaria, certo. Ma anche i nuovi custodi della morale sessuale. I quali sostengono di portare libertà e felicità, ma impongono una burocratizzazione dell’erotismo senza pari (dietro la cosiddetta fluidità, ad esempio, si cela una marea di categorie in cui ciascuno deve essere inserito: cisgender, transgender, asessuale eccetera). Potremmo citare poi i nuovi invasati dell’ecologismo, più intransigenti che mai. O i vari movimenti «antirazzisti». Ciascuno ha le sue norme di condotta da imporre, la sua sterilizzazione del linguaggio da applicare. Come nel Seicento si passa in un lampo dall’approdo nella Terra promessa alle impiccagioni di Salem; dalla costruzione dell’utopia alla persecuzione dei dissenzienti.
Esiste, certo, un’apparente contraddizione. Se questa è una forma perversa di puritanesimo, come si concilia con la dissipazione istituzionalizzata della società dei consumi? Il cortocircuito non deve trarre in inganno, poiché il sistema produce la legge e pure la sua violazione, sono due facce della stessa medaglia. Ascesi e spreco si alimentano a vicenda, si danno reciproco impulso: nel mercato c’è spazio per il fanatico del fitness e per il grande obeso a cui vanno comunque garantiti «diritti» cioè prodotti su misura.
Tocca concluderne, forse, che il puritanesimo antico era migliore di quello attuale. Quello, almeno, prevedeva una rinuncia consapevole alle seduzioni del mondo: si rivolgeva agli adulti e pretendeva da loro un’adesione intima e convinta. Ora, invece, tutto è calato dall’alto: il comando di una mamma cattiva ai bambini incapaci di governarsi da soli.