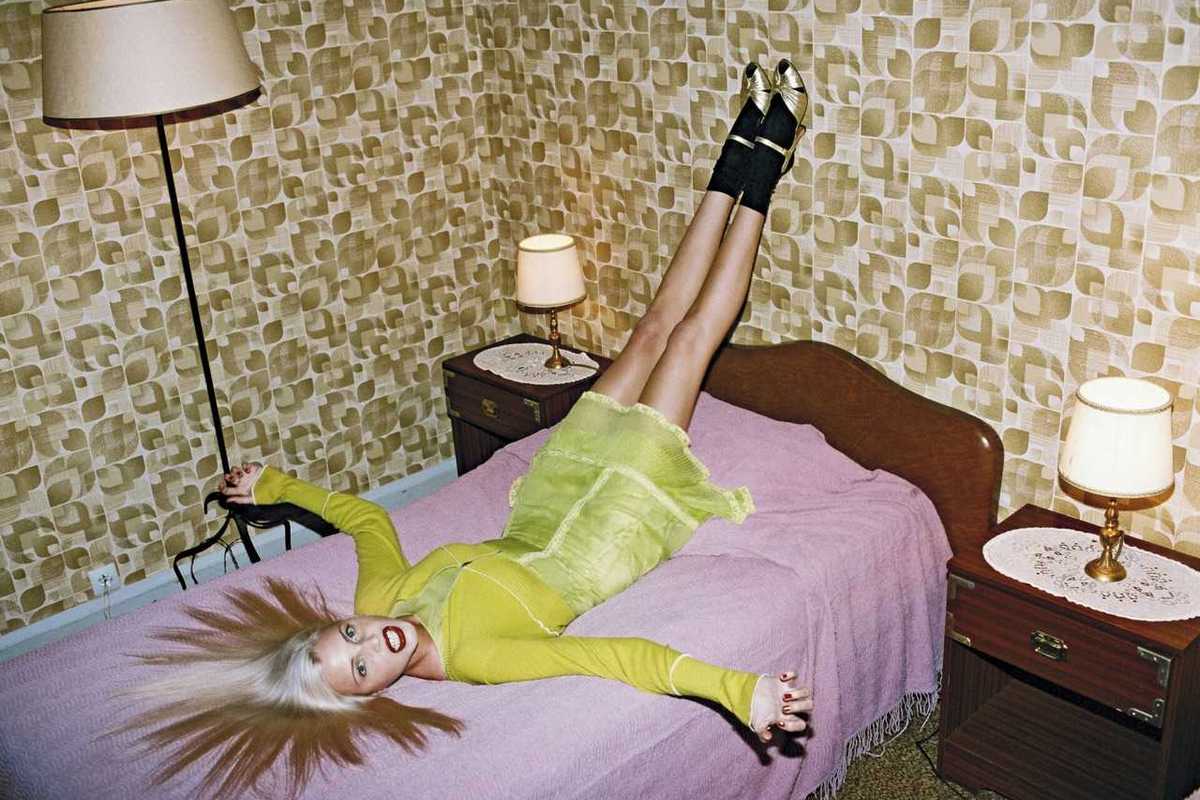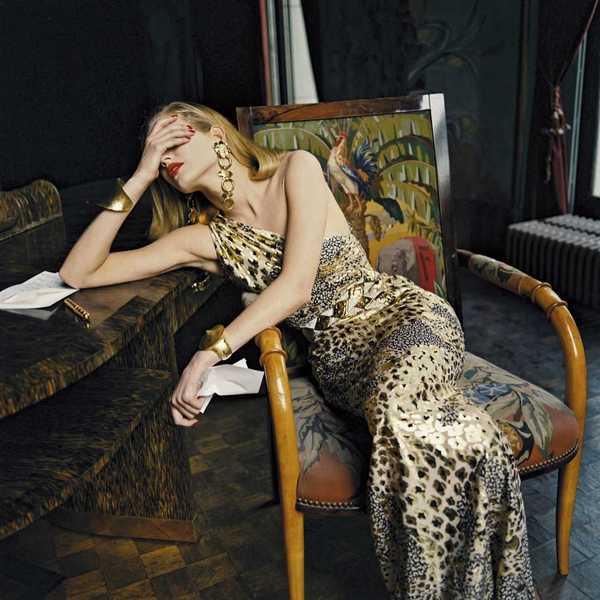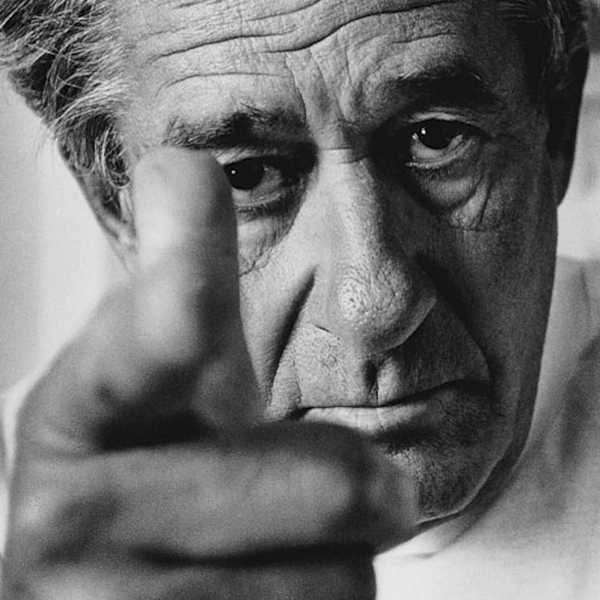Correva l’anno 2009. Barack Obama si insediava alla Casa Bianca per il suo primo mandato presidenziale. L’Italia, governata dall’esecutivo di centrodestra Berlusconi quater, si svegliava nel cuore della notte del 6 aprile per le scosse del terremoto che devastò l’Aquila. Il mondo inaugurava la prima lotta pandemica del XXI secolo e, diversamente da quanto è successo di recente con il Covid-19, la stampa italiana aveva un atteggiamento più che tollerante nei confronti di chi preferiva astenersi dalle vaccinazioni.
Il virus H1N1 è una variante del più comune virus dell’influenza A, che combina segmenti genetici di virus influenzali suini - da cui il nome gergale «influenza suina» -, aviari e umani. Sorto nell’area di Veracruz, città del Golfo del Messico, a circa 300 chilometri a Est dalla Capitale, l’H1N1 si era diffuso rapidamente, prima nelle Americhe e successivamente in Europa, costringendo l’Oms a dichiarare lo stato di massima allerta pandemica, in giugno. La trasmissione avveniva attraverso le vie respiratorie e la sintomatologia differiva di poco, se non nulla, da quella dell’influenza stagionale, con febbre, tosse, mal di gola, dolori muscolari, emicrania, brividi e affaticamento. Talvolta, poteva portare a complicazioni come la polmonite, specialmente nei gruppi vulnerabili: anziani, individui immunodepressi e persone con condizioni cliniche preesistenti. I governi e le organizzazioni sanitarie di tutto il mondo adottarono misure per contenere la diffusione del virus che includevano campagne di vaccinazione e prescrizioni igieniche.
Com’è noto, vaccini e campagne vaccinali sono da sempre argomenti di per sé divisivi: chi non crede nell’efficacia totale del siero; chi ne teme, anzi, gravi controindicazioni; chi, ancora, vi si consegna con incondizionata fiducia. Al di là del Covid, il fronteggiarsi di opposte visioni sul tema rimonta alle origini medesime della scoperta scientifica; e, senza sottoporre il lettore allo strazio cronologico della disputa «vaccino sì - vaccino no», sia sufficiente pensare che le posizioni sono molteplici. Del resto, nel lontano autunno 2009 - solo 15 anni fa - i maggiori giornali italiani avevano la premura di allertare la popolazione sugli sviluppi e i rischi di una malattia che andava diffondendosi, con analisi e interviste a medici e specialisti; ma avevano anche sì cura di sollevare le giuste domande e dare voce a quelli che, allora come oggi, un dubbio sul vaccino se lo ponevano. E chi era restio era semplicemente «restio» e non entrava nella pericolosa categoria dei no vax, neologismo anglofono entrato nell’uso comune durante l’epidemia americana di morbillo del 2014-2015, e inflazionato con il recente e illustre Covid-19.
Il 27 ottobre 2009, a pagina 7, La Stampa titolava: «I mille dubbi del vaccino. Parte l’immunizzazione di massa, ma pochi medici partecipano. E, nel clima di incertezza, le famiglie non sanno scegliere». L’articolo è un lungo reportage, con cronaca e interviste sulla mole di dati, spesso contraddittori, legati all’influenza A. «Quanta paura e quanti interrogativi attorno al vaccino contro l’influenza A», si legge. «Proprio nei giorni in cui, in tutta Italia, aumentano i casi nelle scuole, la percentuale di medici che ha scelto di essere vaccinata è bassissima. [...] Scelta che tanti vedono come un suggerimento implicito alla prudenza, se non addirittura un allarme: «Meglio non fidarsi, è stato realizzato troppo in fretta». Il pezzo continua poi con un intervento del dottor Domenico Crisarà, un medico che allora aveva oltre 1.000 mutuati, 350 dei quali ultrasessantacinquenni. «Con i miei assistiti ho un rapporto di fiducia e non mi sentirei di consigliare nulla di non abbastanza sperimentato», aveva dichiarato al quotidiano, sul quale si legge ancora: «Spaventano i possibili rischi collaterali, certo non aiuta la richiesta di firmare il consenso informato: «Pratica insolita», commenta Crisarà».
Il 2 novembre lo stesso giornale torinese, che sul tema pandemico aveva investito molta attenzione, a pagina 6 stampava due interviste a eminenti personalità della sfera medica, il cardiologo Antonio Spagnolo, direttore dell’Istituto di bioetica dell’università Cattolica, e Giuseppe Del Barone, presidente del Sindacato medici italiani, i quali, interrogati sull’opportunità di chiudere le scuole a scopo preventivo, respingevano con fermezza l’idea, etichettata come «inutile allarmismo» e «catastrofismo». Così affermava infatti il professor Spagnolo: «Chiudere le scuole diffonde il panico ed è un modo sbagliato di reagire alla sensazione di pericolo dell’opinione pubblica. Negli anni scorsi per l’influenza stagionale non veniva dato l’allarme e, malgrado fosse un dovere, i medici non segnalavano i casi alle autorità sanitarie [...]. Adesso vengono segnalati tutti i casi, anche non di influenza A. Le indicazioni contro le malattie diffusive restano le stesse». A queste dichiarazioni faceva eco la voce del professor Del Barone, che aggiungeva le considerazioni sul vaccino: «Innanzitutto bisogna sapere che il vaccino non offre protezione nei 15 giorni immediatamente successivi. E, poi, devo constatare che anche fra i miei colleghi sono tanti quelli che si mostrano scettici nei confronti del vaccino, e quindi tendono a non farlo. [...] C’è stata un po’ di fretta, non è stato testato in tutti i suoi passaggi. Si temono reazioni non controllate, con allergie o intolleranze».
Ancora La Stampa, l’11 novembre mostrava a pagina 19 un servizio che indagava i retroscena del pregiudizio contro la scienza.
«Vaccino sì o no? Italia divisa». In calce al pezzo, un sondaggio molto degno di interesse sull’opinione che gli italiani avevano sul vaccino contro l’influenza A: «Solo uno su due si dice favorevole», titolava il grafico. E tra gli scettici l’opinione maggiore era che il vaccino non fosse ancora stato testato a sufficienza.
I mesi passavano, la malattia si diffondeva, qualcuno moriva (come segnalava La Stampa il 3 novembre 2009 a pagina 2: «Normale ci siano vittime». Circa 400.000 persone nel mondo a fine pandemia), e con il virus crescevano anche i dubbi legati al vaccino e alla narrativa ad esso legata. Tant’è vero che sempre La Stampa, il 7 giugno 2010, un anno dopo che l’Oms aveva dichiarato lo stato di massima allerta pandemica, rilanciava lo scoop pubblicato su Le Monde: «La grande truffa della “suina”. Il British medical journal: l’Oms ha gonfiato i rischi dell’influenza A per favorire l’industria» (pagina 19). Troppa fretta, scarsa trasparenza, conflitto di interessi. Esperti delle commissioni per la valutazione del pericolo erano a libro paga delle grandi case farmaceutiche e secondo il Consiglio d’Europa il livello di pandemia era stato dichiarato con tempi sospetti.
A quello del Bmj hanno fatto seguito altri studi. Il 12 novembre 2013 La Repubblica seguiva le orme di chi aveva denunciato gli allarmi pompati dell’influenza A per favorire le industrie e sulla testata compariva il titolo «Influenza: esperti legati a industria farmaci più propensi a parlare di rischi pandemia. Una ricerca pubblicata online sul Journal of epidemiology and community health ha analizzato gli articoli sulla stampa legati alla pandemia di influenza suina H1N1 del 2009 e le dichiarazioni del conflitto di interessi degli scienziati».
Pare proprio che quelli che oggi passano per antivaccinisti pericolosi ed eretici - tra cui anche dei medici - avessero ragione a sospettare anomalie nella velocità di sviluppo del vaccino e in possibili conflitti di interesse legati alle case farmaceutiche.