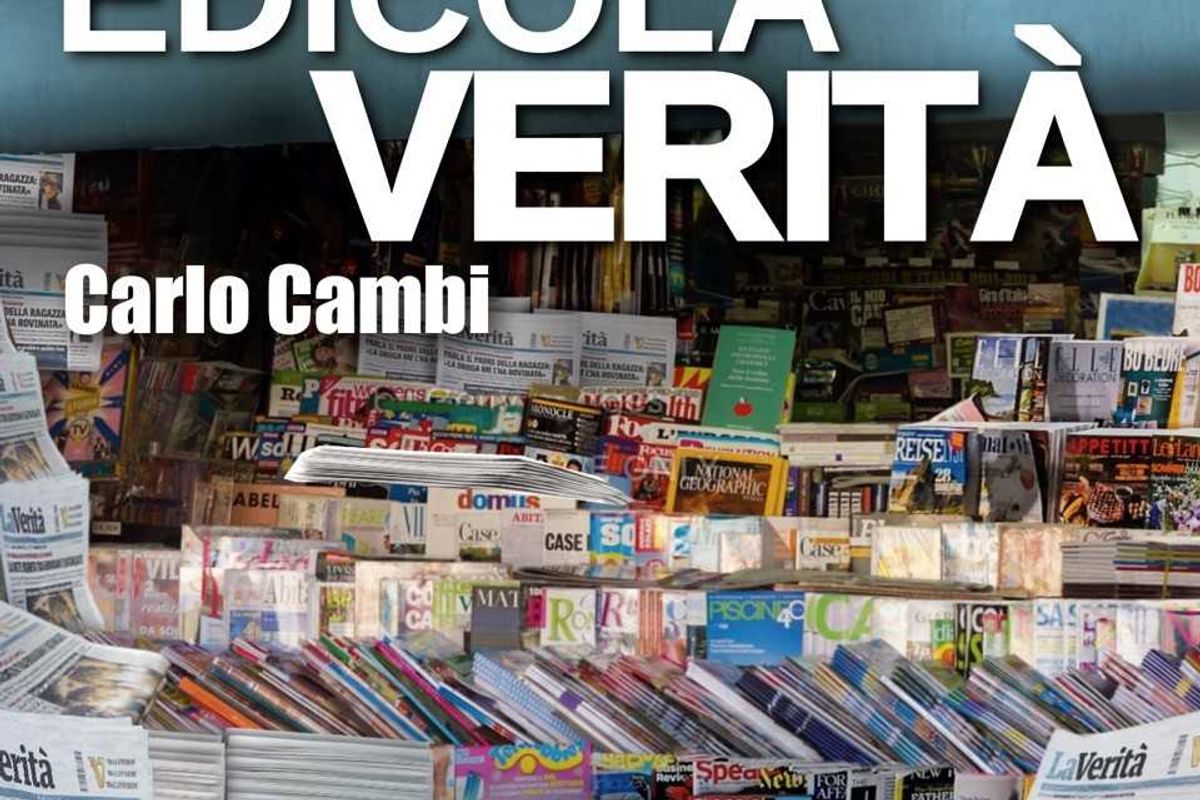La Corte dei conti si «dimentica» che i soldi del Pnrr vanno restituiti
Se di un documento si leggono solo i titoli, la notizia di ieri è che la Corte dei conti ha certificato che l’Italia non è più «contributore» ma percettore netto dei fondi Ue. Se invece si avesse la pazienza di leggersi almeno le prime 82 pagine (delle 647 complessive) della Relazione annuale 2022 sui rapporti finanziari con la Ue, si scoprirebbe che l’onestà intellettuale e la precisione dei nostri magistrati contabili non è in discussione, perché l’Italia continua a essere contributore netto. E non di poco. Nel settennio 2015-2021 il saldo netto a nostro sfavore è pari a 33,7 miliardi. Tuttavia è vero che, anche per effetto di nuovi criteri di classificazione contabile, nel 2021 abbiamo dovuto contribuire per «soli» 2 miliardi, contro una media annua dell’intero periodo pari a 4,8 miliardi. Siamo altresì ben lontani dal saldo negativo record del 2018 per 6,9 miliardi.
Allora perché la Corte ha titolato nel suo comunicato stampa Ue, Corte conti: con fondi Pnrr Italia passa da contributore a percettore netto? Perché ad agosto 2021 l’Italia ha incassato la prima rata (a titolo di prefinanziamento) del Pnrr per complessivi 24,9 miliardi. Di cui 15,9 di prestiti e 9 di sussidi. E questi ultimi 9 (che diventano 10,2 con altri fondi minori) sono stati considerati dalla Corte un ulteriore contributo della Ue. Il bilancio del 2021 è così passato da un saldo negativo di 2 miliardi a un saldo positivo di 8 miliardi.
Ma basterebbe non fermarsi ai titoli e prestare attenzione alla puntuale precisazione del comunicato stampa che accompagna la relazione per leggere che «la nuova posizione dell’Italia andrà valutata solo all’esito del programma di investimento legato ai Piani nazionali di ripresa e resilienza e, più in generale, alla realizzazione degli strumenti espansivi presenti nel Quadro finanziario pluriennale vigente fino al 2027».
In altre parole, questi saldi sono provvisori e da prendere con le pinze perché in Europa è cambiato molto negli ultimi due anni. E i conti si potranno fare solo alla fine del periodo di esecuzione degli investimenti finanziati dal Pnrr e delle altre spese finanziate con il Quadro finanziario pluriennale (Qfp).
Infatti, il saldo negativo di 2 miliardi del 2021 deriva dalla somma algebrica di versamenti della Ue all’Italia (16 miliardi) e di versamenti dell’Italia alla Ue (18 miliardi). Si tratta della quota annuale del bilancio ordinario della Ue 2021-2027 pari a 1.214 miliardi, di cui 148 erogati nel 2021 ai 27 Stati membri. Questo bilancio viene interamente finanziato, anno per anno, dai contributi degli Stati membri, prevalentemente proporzionati al reddito nazionale lordo (aggregato un po’ diverso dal Pil). Ben 15,4 miliardi dei 18 versati nel 2021 dall’Italia vanno sotto questa voce, a cui si aggiungono Iva e dazi doganali.
È quindi sensato concludere che ogni anno la Ue incassa e redistribuisce agli Stati membri il denaro che essi stessi versano e si originano dei contributori (o percettori) netti perché la base di ripartizione di incassi e versamenti non è la stessa. C’è chi contribuisce di meno alla torta degli incassi, ma riceve di più dalla torta dei versamenti di Bruxelles.
Poi è arrivato il NextgenerationEu che è un fondo aggiuntivo rispetto al Qfp, con altri 10,2 miliardi per l’Italia. Vale 807 miliardi tra prestiti e sussidi e, come noto, i versamenti agli Stati membri sono scaglionati in rate semestrali fino al primo semestre 2026, in relazione al conseguimento di obiettivi e target concordati tra Commissione e governo.
La differenza tra NextgenEu e Qfp sta nella modalità con cui la Ue finanzia questi fondi. Il primo non riceve contributi dagli Stati ma, poiché il denaro non cresce sotto l’albero del campo dei miracoli, si finanzia con le emissioni di titoli sui mercati. La Ue ha dovrà cominciare a rimborsare quei titoli a partire dal 2026 e lo farà chiedendo contributi agli Stati membri o imponendo nuove tasse, i cui progetti continuano per il momento a vagare in alto mare.
Fino a quando non cominceranno questi versamenti da parte degli Stati è normale e, totalmente illusorio, che Paesi come Italia e Spagna siano momentaneamente etichettati come percettori netti. Anche chi incassa un mutuo dalla banca è percettore netto, ma non dimentica certo che ci saranno delle rate da pagare.
Il NextgenUe, separando nel tempo il momento in cui gli Stati incassano e versano, ha creato questa pericolosa illusione. Va doverosamente sottolineato che i magistrati contabili riportano più volte questa essenziale differenza. Basta solo volerla leggere.
Che la materia sia ancora molto magmatica è stato confermato dagli eventi di ieri. La cabina di regia del Pnrr in vista del ha visto coinvolti gli amministratori delegati delle principali partecipate del settore energetico (Enel, Terna, Snam, Eni) perché il fondo RepowerUe (la nuova appendice del NextgenUe) destina nuovi fondi proprio agli investimenti in rinnovabili. «Il nuovo piano» RepowerEu, ha commentato Giorgia Meloni, «consentirà all’Italia di dare un forte contributo alla realizzazione del piano Mattei».
Nelle stesse ore il ministro Raffaele Fitto ha ribadito che l’Italia chiede nell’immediato flessibilità nell’uso dei fondi Ue, in particolare Pnrr e coesione e, in tempi rapidi, la creazione di nuovi strumenti come un fondo comune per la sovranità europea. A tal proposito anche il commissario Paolo Gentiloni ha capito che ormai dei vecchi piani restano solo macerie e ha solo invitato gli Stati a presentare le modifiche rapidamente e tutti insieme.
Il prossimo Consiglio europeo dovrebbe fornire qualche prima indicazione sull’esito di una partita davvero complessa, i cui conti si faranno non prima del 2026. La Ue non regala nulla, nel migliore dei casi restituisce ciò che riceve.