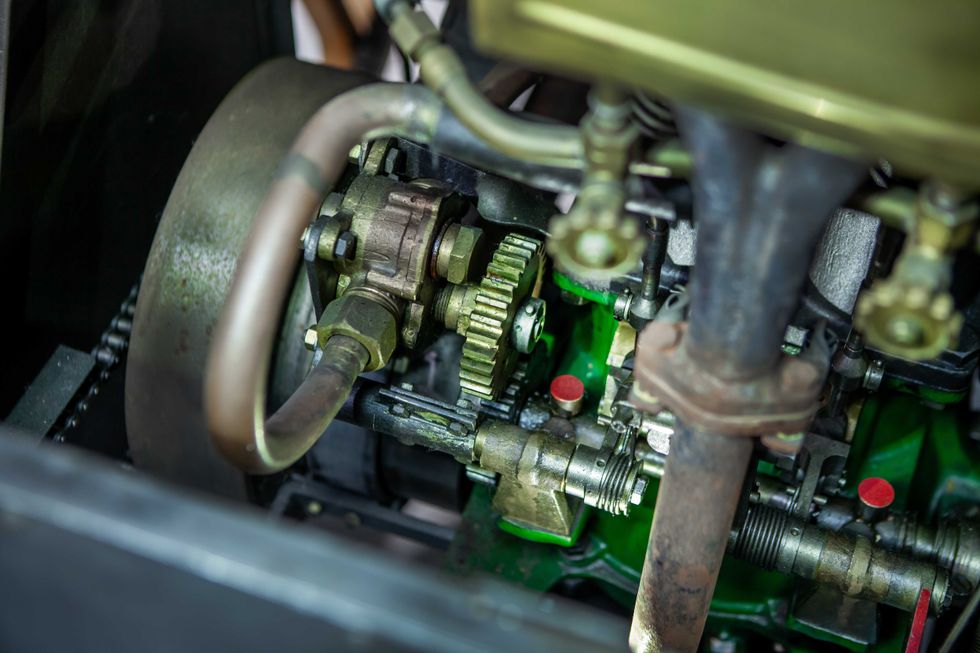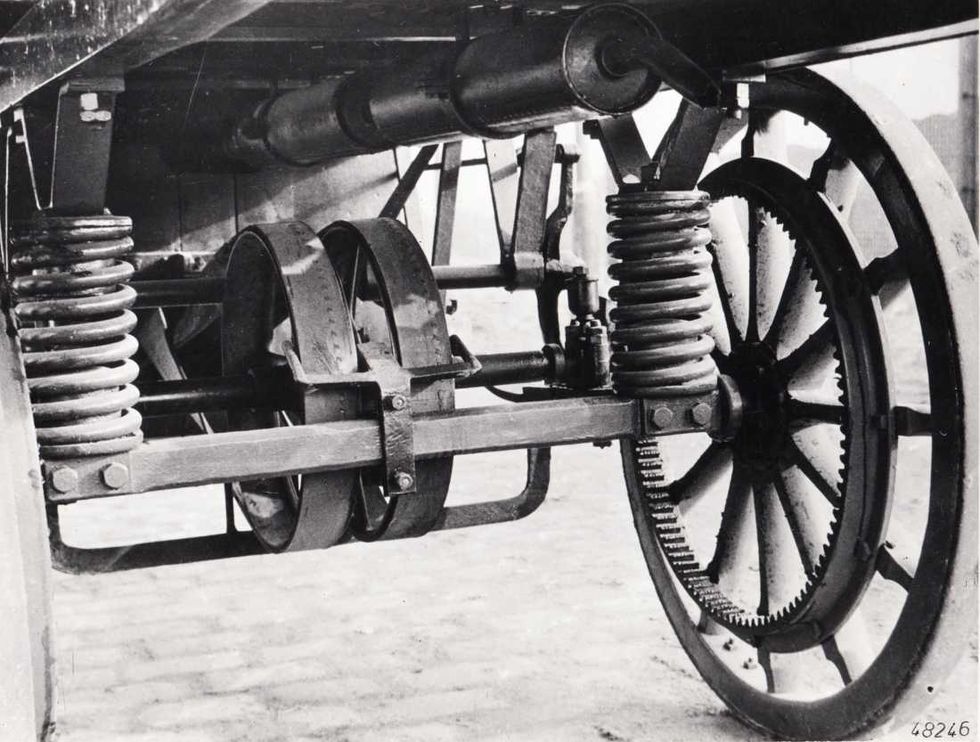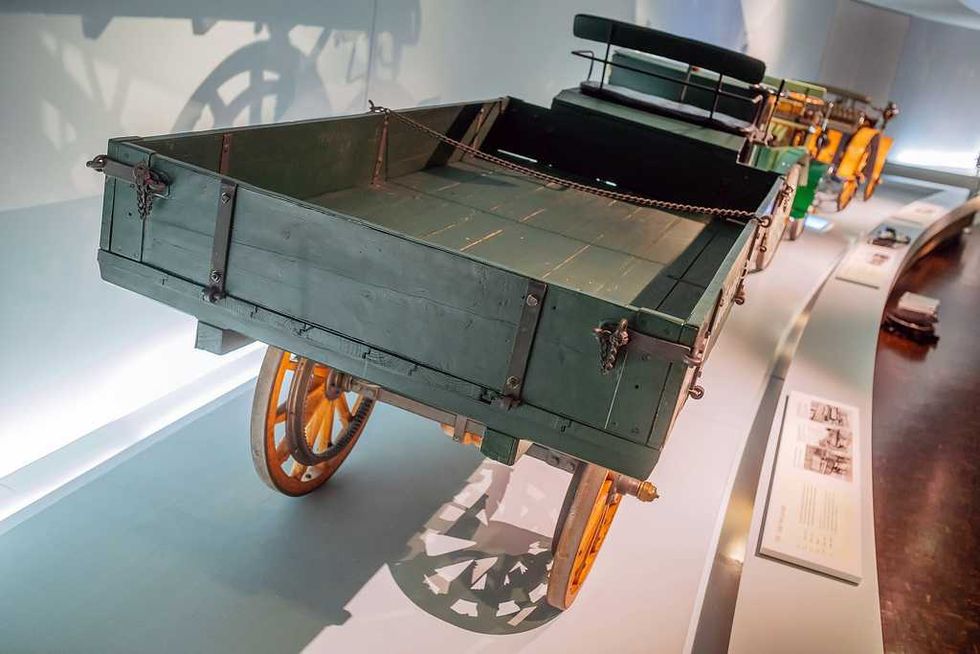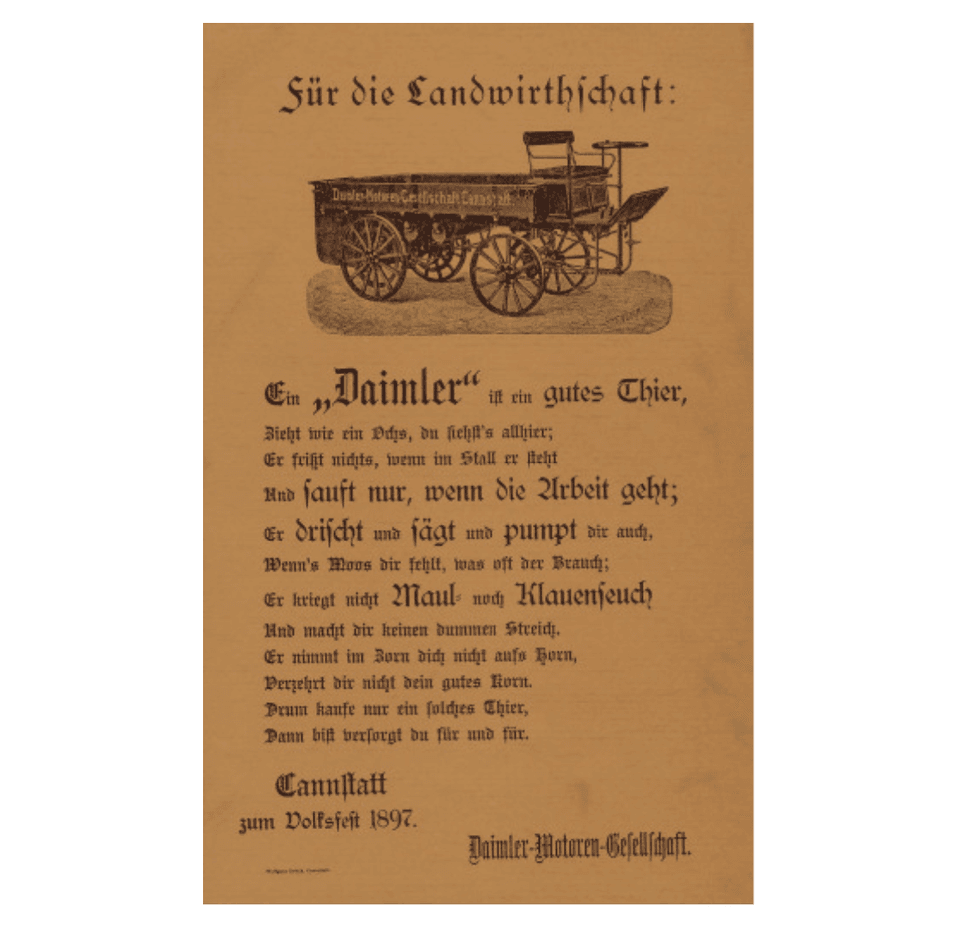Vieni avanti, decretino. I dpcm come le nespole, vanno via che è un piacere: non fai in tempo a commentarne uno, che è già in arrivo il successivo. Dpcm. Un acronimo cui, obtorto collo, abbiamo fatto il callo. Alla vigilia dell'ultimo decreto (al momento della stampa di questa edizione non è ancora stato firmato) parliamo con Giuseppe Cricenti, magistrato dal 1994, autore di Non è vero ma ci credo-Come le fake news inquinano la democrazia, oggi consigliere della corte di Cassazione. «Dell'ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, quello del 24 ottobre, si può dire ciò che valeva anche per i precedenti: si tratta di una burocratica versione del potere che si esercita sulla “nuda vita". Una disciplina pedante di quasi ogni aspetto della nostra esistenza quotidiana» è il suo esordio.
Scritto come?
«Malissimo. È subito balzato evidente il “raccomandare fortemente" certi comportamenti: una norma vieta o permette, non “raccomanda". Anche perché la sua violazione non è sanzionabile. Secondo una tecnica legislativa scadente e reiterata, c'è poi dentro di tutto, compreso l'ovvio dei popoli: all'interno del chilometrico articolo 1 c'è per esempio il divieto per chi accompagna pazienti in pronto soccorso di sostare nelle sale d'attesa. Bastava un cartello fatto mettere dall'ospedale».
Siamo alla normademia, l'epidemia prescrittiva. Il dpcm che da eccezione si fa regola.
«Si è detto che il Parlamento, causa Covid, era di fatto impotente, che non poteva riunirsi e quindi si è dichiarato uno stato di emergenza che ha consentito al governo di decidere da solo. Con un decreto legge, poi convertito in legge, che di fatto era una delega in bianco: “Caro governo, fai un po' quello che ti pare". Negli altri Paesi invece il Parlamento ha dettato la linea e l'esecutivo l'ha eseguita. Ma non basta di per sé la calamità per costituire stato di eccezione: deve impedire il normale funzionamento delle istituzioni, condizione mai verificatasi in questi mesi (perché altrimenti, con la reduction ad absurdum, avremmo avuto una specie di “golpe bianco")».
Si può ricorrere contro i decreti di Conte o dei presidenti di Regione?
«Certo. Sono atti impugnabili davanti al giudice amministrativo. Un'altra singolarità: una sorta di potere assoluto del governo soggetto al controllo dei Tar».
Rapporto Stato-Regioni: non si capisce più chi abbia il potere di decidere cosa.
«Il caos è dovuto principalmente proprio all'iniziale decreto legge, citato prima, il quale ha previsto che le misure di contenimento dell'emergenza spettano al presidente del Consiglio. Ma anche che, in mancanza di dpcm o comunque in casi di necessità e urgenza, possono essere adottate misure da Comuni e Regioni: quali siano non si è specificato, così che il perimetro delle rispettive competenze si è confuso».
La magistratura è stata scossa dal caso di Luca Palamara. Giustizia è stata fatta, con la sua radiazione?
«Le responsabilità personali di Palamara sono in corso di accertamento. Il fatto è che il sistema ha rifiutato di processare sé stesso. Si è agito come se ci trovasse davanti a un'anomalia isolata, un fatto individuale, anziché prendere atto che il funzionamento dell'ordinamento giudiziario è condizionato totalmente dalle correnti. Sono pochi i magistrati che nella loro carriera non hanno tratto beneficio da un qualche accordo tra le medesime. Imperano i moralisti senza morale: si chiamano fuori dal sistema cui hanno partecipato, additando il capro espiatorio di turno».
La famosa «degenerazione del sistema correntizio». La riforma della magistratura non è più procrastinabile.
«All'orizzonte non se ne vedono di efficaci. Io sono da sempre per il sorteggio, e non solo dei membri del Csm, ma anche degli altri organi elettivi, come ad esempio i Consigli giudiziari. Non è però solo un problema ordinamentale, ma soprattutto deontologico ed etico. Siamo noi magistrati a dover porre rimedio a questa deriva, altrimenti saremo travolti. Taluni si ostinano a sostenere che le correnti sono gruppi culturalmente utili alla magistratura, ma non è chiaro quale crescita culturale abbia avuto quest'ultima grazie ad esse. Il loro ruolo, ormai da oltre un ventennio, è la spartizione delle nomine ai diversi incarichi, e stop».
Andrebbero sciolte?
«Non si può. Sono associazioni private formalmente lecite. Rimane la distorsione istituzionale: un organo a rilevanza costituzionale, quale il Csm è, condizionato da associazioni private, senza che ci sia delibera che non risponda a un interesse correntizio».
Per Sabino Cassese le Procure sono ormai un quarto potere indipendente dalla stessa magistratura.
«L'autonomia di azione dei Pm è certamente molto ampia: dispongono di mezzi di coercizione o comunque di limitazione dei diritti personali, che possono utilizzare con margini di discrezionalità dovuti a una serie di fattori che nel tempo si sono accumulati, non ultimo regole penali sempre meno garantiste, che a loro volta condizionano il controllo da parte del Gip. Oggi il diritto penale è molto più illiberale di quello di qualche decennio fa. Poi c'è il tema del rapporto tra “popolo" e pubblici ministeri, sottovalutato anche dall'Anm».
In che senso?
«A volte il consenso popolare è cercato. Alcuni Pm si muovono con una certa attenzione all'ambiente, e anche se di fatto rimangono imparziali (ma a volte se ne può dubitare) se si mettono ad annunciare propositi da demiurghi, del tipo -“rivoltare l'Italia come un calzino" oppure “smontarla come un Lego" - perlomeno imparziali non appaiono».
Allude a Nicola Gratteri (la frase sul Lego è sua), calabrese come lei e icona della guerra alla 'ndrangheta.
«La 'ndrangheta va combattuta come ogni fenomeno di criminalità organizzata endemico: con una lotta senza quartiere. L'attenzione verso il risalto mediatico che il proprio lavoro può avere è però una costante per una minoranza di magistrati. Non che ciò renda le inchieste infondate, ma di certo alimenta nel pubblico visioni simboliche e attese messianiche che sarebbe meglio evitare».
Separazione delle carriere: favorevole o contrario?
«Chi è contrario obietta: così facendo, separando i Pm dall'ordine giudiziario, li si assoggetta al potere esecutivo. Argomento infondato e anacronistico. Basta creare un organo di autogoverno apposito».
Quindi separazione sì?
«Con le opportune cautele direi di sì, perché la separazione delle carriere è una misura di garanzia: la terzietà del giudice passa anche attraverso l'appartenenza di questi a un ordine diverso da quello della parte pubblica, l'accusa. Altrimenti sono favoriti contiguità e «appiattimenti» del gip/gup al pm. E poi è una misura di logica adeguatezza istituzionale: si tratta di mestieri e ruoli diversi».
Caso Davigo: dal 20 ottobre è in pensione, il Csm l'ha estromesso ma lui annuncia ricorso al Tar perché il mandato dura 4 anni, e il cessare dal servizio «nel mentre» non rientra tra le cause di non eleggibilità ex ante, o di decadenza ex post.
«Il mandato dura quattro anni sul presupposto che si rimanga magistrati in servizio, ossia che si mantenga la condizione che ha consentito l'elezione. Non v'era bisogno che la legge lo dicesse espressamente tanto era scontato. Il caso pone quindi un problema generale, Csm o non Csm. Se un magistrato aspira a un incarico direttivo deve avere davanti a sé almeno quattro anni di servizio: se scatta la pensione, non ha diritto di continuare a ricoprirlo. Regola che suona conferma dell'azzeramento determinato dalla pensione».
La fiducia dei cittadini nei vostri confronti è ai minimi termini.
«Purtroppo. Ma bisogna distinguere se la sfiducia deriva da condotte non proprio corrette di singoli magistrati o dal modo in cui si atteggia oggi la giurisdizione. Sono sempre più numerose le sentenze formalmente corrette ma che possono sembrare ingiuste. Ma il problema, e questo non vuol essere un alibi, è nel contesto. L'ordinamento si è involuto. Un complesso eterogeneo di disposizioni, non tutte opera del legislatore, il cui rispetto determina un eccesso di formalismo. Come se il sistema mirasse a risultati autoreferenziali. Che però disorientano il cittadino».
Per Cicerone «summum ius, summa iniuria»: l'applicazione meccanica del diritto produce un'ingiustizia.
«Secondo la tradizione liberale, la garanzia sta nella forma e non nel contenuto della regola. Solo che oggi la forma è diventata un dispositivo fine a se stesso. Per contro, ci sono settori della magistratura inclini all'idea che la giustizia coincida con l'accusa, in ciò supportati dai media “manettari". Si tratta di populismo giudiziario: il magistrato si fa interprete delle esigenze e degli interessi del popolo. La piazza vuole giustizia dei corrotti? La semplice accusa soddisfa quel bisogno».
Già: «Chi volete voi libero, Gesù o Barabba?», e si sa com'è finita. Fake news: pseudoverità ufficiali o controverità manipolate ci sono sempre state.
«Per anni si è ripetuto che la Casta imponeva le sue verità, così è nato uno storytelling per cui si possono legittimamente contrapporre «versioni alternative dei fatti». Chi pensava di emanciparsi dalle narrazioni “opache" ha trovato contro-narrazioni ancora più oscurantiste, agevolate dai social che si nutrono di analfabetismo funzionale».
Coronavirus e fake news: chi ne ha diffuse di più, i negazionisti o gli apocalittici?
«Ricorda lo spazio accordato ai novax, e alla loro campagna sulla dannosità dei vaccini, e a come ora anche loro stiano aspettando l'arrivo di quello anti Covid? Sì? Allora ho risposto alla sua domanda. L'importante è che a spacciare fake news non siano gli scienziati. Se solo si mettessero d'accordo...».