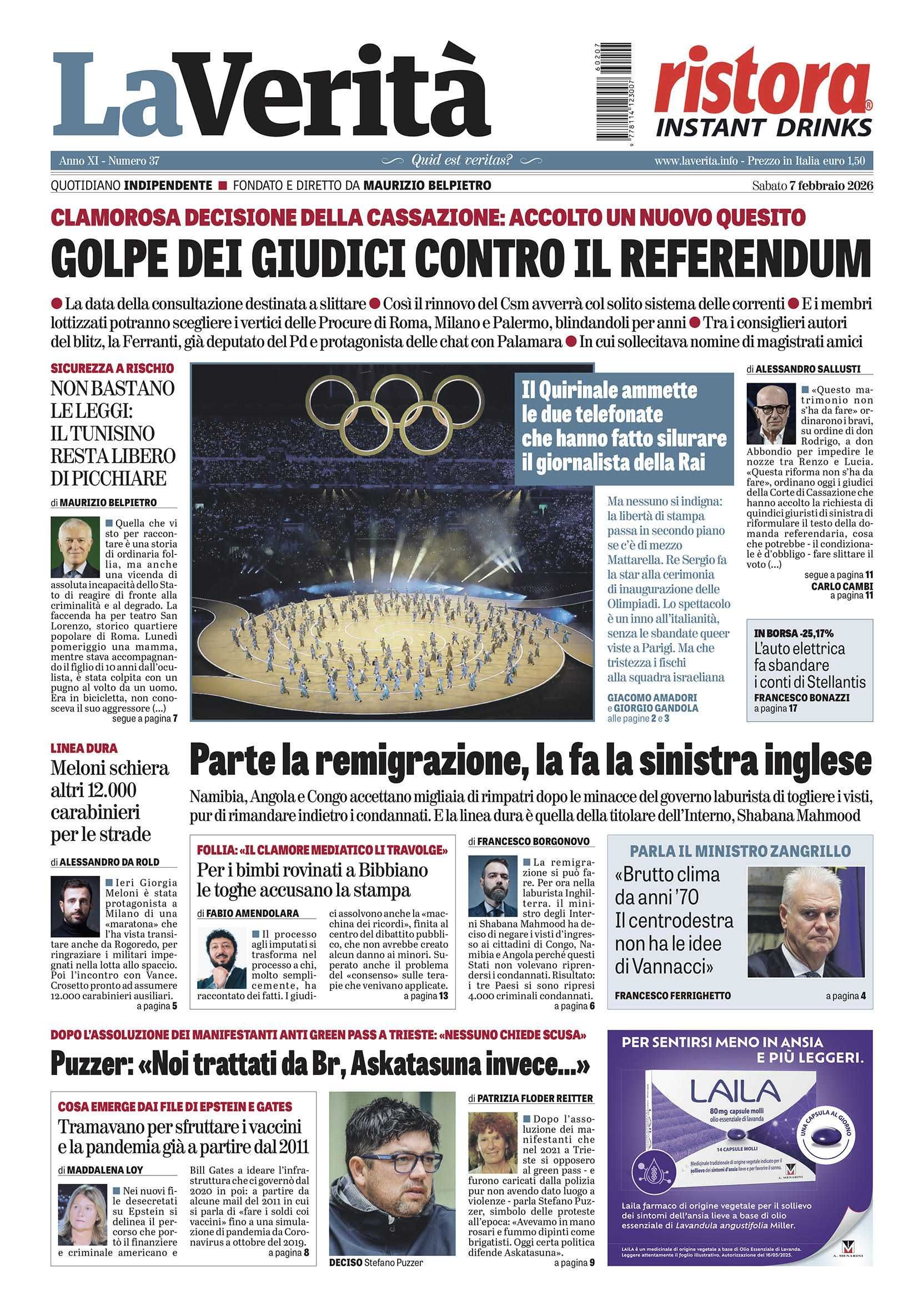Conoscere il mondo comporta fatica. La realtà virtuale è solo una truffa

Nel 1995 pubblicai presso Mondadori un libro intitolato Giocare per forza. Il gioco è sempre stato per me uno strumento fondamentale per comprendere l’essere umano (e non solo) e in particolare attività quali l’arte, la letteratura e la mia amata filosofia, che definisco giochi intellettuali. L’uso corrente della parola «gioco», però, e i cosiddetti giochi che circolavano fra il pubblico, causavano in me perplessità e inquietudine, perché sostituivano le caratteristiche ludiche essenziali (la natura esplorativa, sovversiva e profondamente educativa del gioco) con noia, ripetitività e imbecillità conclamata. In quel libro, dunque, compivo un viaggio nel continente gioco, che mi apparve trasformato «in una sordida deriva urbana costellata di rifiuti, povera di struttura, priva di bellezza». Talvolta il mio fu un viaggio reale, nello spazio, e talvolta un viaggio metaforico, che mi portò a contatto non con luoghi ma con argomenti diversi. «Visitai» Las Vegas, regina dei giochi d’azzardo, i giochi televisivi, i giocattoli commerciali, i videogiochi, la teoria dei giochi; e anche Disneyworld, a Orlando, dove la World Showcase offre, intorno a un lago artificiale, dieci «nazioni» ridotte a copie di monumenti famosi, ristoranti tipici e negozi di chincaglieria. Lì il turista può fare quel che sembra fare comunque: scattare foto, mangiare e comprare ricordini. E può farlo a condizioni vantaggiosissime: un solo spostamento per arrivare a Orlando, un solo biglietto d’entrata, dieci nazioni in un giorno (come recita la pubblicità). All’epoca di questa Vetrina del mondo (oltre a cercare di comprenderne l’attrattiva) avevo detto il peggio possibile; oggi, forse, dovrei ricredermi sul fatto che vi si fosse toccato il fondo.
Ricominciamo da capo. Da anni, ogni settimana, leggo religiosamente il New Yorker. È una rivista ricca di contenuti informativi, con articoli ben ricercati (di solito per mesi) e ben scritti. Negli ultimi tempi, ho dovuto storcere il naso vedendola adattarsi (con maggior classe della media) alla propaganda mainstream sul Covid e sulla guerra in Ucraina; ma c’è sempre abbastanza, su altri temi, che merita attenzione.
Recentemente il New Yorker ha dedicato un numero monografico ai viaggi, e il servizio di apertura mi ha riportato a Disneyworld, dove l’azienda, che nel 2012 aveva speso quattro miliardi di dollari per acquistare Lucasfilm, e con esso i diritti alla serie di film e programmi televisivi Star Wars, ha inaugurato una sua nuova «avventura»: Galactic Starcruiser, una «navicella spaziale» che conduce gruppi di entusiasti al Black Spire Outpost, sul pianeta Batuu, dove possono avere una totale immersione nel Larp (live-action role-play) di incontrare personaggi delle loro fantasie preferite.
Al Black Spire Outpost i pionieri delle galassie hanno una cabina (stando stretti, ci si può dormire in cinque, con letti che spuntano un po’ dappertutto) per due notti, pasti (l’alcol non è compreso) e la frequentazione interattiva di mostri interplanetari a volontà. Per due persone, il costo è 4800 dollari; per quattro nella stessa cabina, scende (in proporzione) a circa 6000. Ma volete mettere: familiarizzare con Luke Skywalker, Han Solo e tutti quegli altri eroi?
Nel 1973 vidi lo straordinario film d’animazione franco-cecoslovacco Il pianeta selvaggio e mi convinsi che quello era il modo giusto di raccontare la fantascienza al cinema. Purtroppo le cose andarono diversamente: nel 1977 uscì Star Wars e furono gli esseri umani a trasformarsi in cartoni animati. C’è dunque una giustizia storica nel fatto che oggi sia la Disney a governare questa impresa. Ma, reprimendo a fatica gli sbadigli nella lettura dell’articolo del New Yorker come li avevo repressi durante la visione del film originario, è bene trarre una morale da questi sconci sviluppi.
I visitatori della Vetrina del mondo si dichiaravano spesso colpiti dalla fedeltà con cui erano state riprodotte le varie «nazioni». Era un commento, notai, stupefacente. Al di là del fatto che l’«Italia» non somigliava affatto all’Italia, come potevano saperlo loro, non essendosi in massima parte mai mossi dagli Stati Uniti? O, per metterla in altri termini, fedeltà a che cosa? Non certo agli originali, per quanto io potessi giudicare, e allora? Fedeltà, conclusi, all’immagine finta che di quegli originali se ne erano fatti, guardando fotografie e forse video ma senza mai essere in presenza degli oggetti reali.
Il delirio pseudopandemico ha accelerato un processo che era in corso da anni, nel quale la realtà è stata gradualmente sostituita da una sua versione virtuale. Siete invitati a visitare musei senza muovervi di casa, a lavorare, insegnare e imparare, o dialogare con amici, guardando uno schermo, e vi si vuole convincere che è la stessa cosa, anzi la stessa cosa a condizioni più vantaggiose, perché costa meno tempo e fatica. Ma non è così, perché quel tempo e quella fatica sono parti integrali dell’esperienza: mettersi al passo con un ambiente o una persona, scegliere che cosa ne consideriamo rilevante (per noi, non in assoluto) entro una massa di dettagli che decidiamo invece di trascurare, trovare un nostro percorso nel mondo o in una sua porzione. Questo vuol dire adattarsi alla realtà; quando questo non c’è più, la realtà scompare, diventa un sogno come un altro, «fedele» solo a sé stesso. E incombe il prossimo passo: se anche Venezia è diventata un luogo immaginario, tanto vale imbarcarsi per il pianeta Batuu. Dove non saremo noi a giocare: a esplorare, a sovvertire, a imparare. Ha pensato a tutto la Disney.