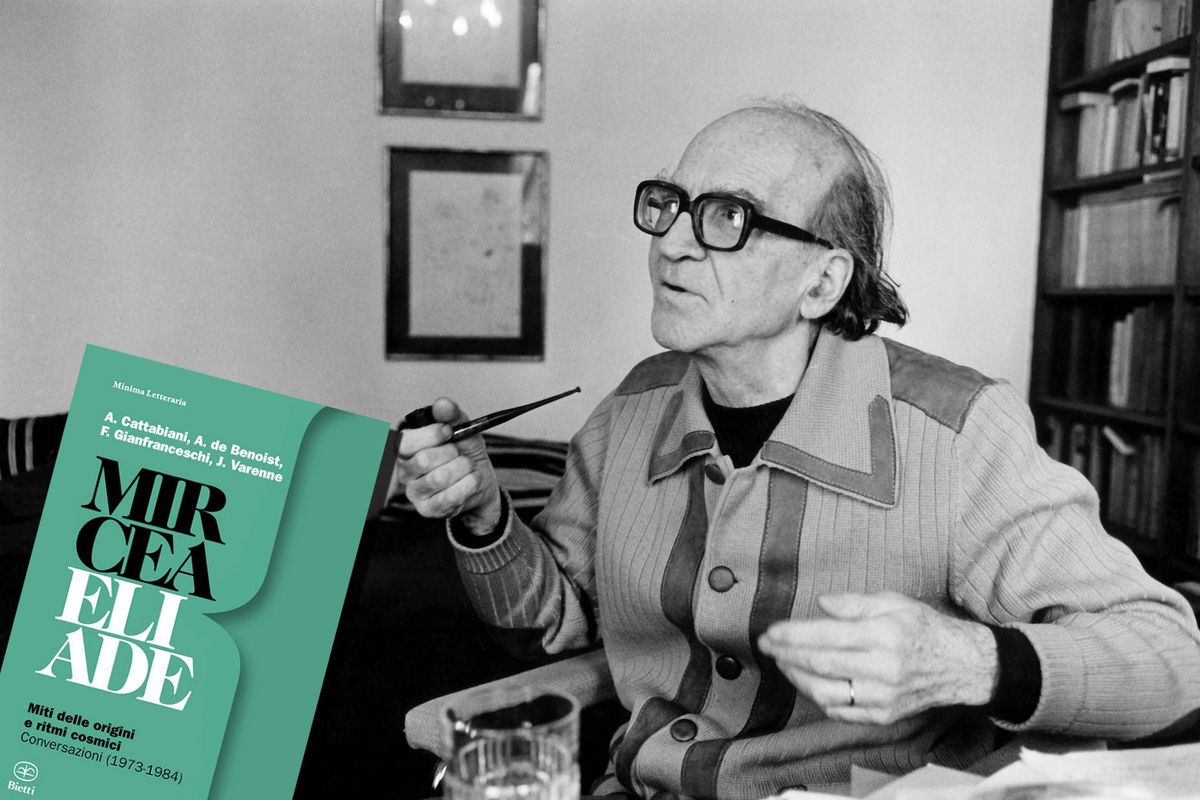
Comparando miti o elementi di credenze avulsi dalla struttura organizzatrice che conferisce loro un senso, è possibile giungere a conclusioni ingannevoli. Qual è esattamente la portata dell'interpretazione universale dei miti?
«Provare a evidenziare i punti di contatto o di somiglianza non implica affatto eliminare le differenze! Anzi, è proprio il contrario, poiché al tempo stesso si vede come, a partire da un tema comune, appaiano sempre nuovi valori e nuovi simbolismi. Prendiamo l'esempio dell'Albero cosmico, mito presente in civiltà molto differenti tra loro. Nel Medio Oriente - in particolare, presso i Babilonesi - si trova un Albero cosmico a sette rami, identificati alle sette sfere planetarie. Ma nel cristianesimo questo Albero cosmico diventa la Croce, autentico “albero di Vita piantato sul Calvario", attraverso il quale si opera la comunicazione con il cielo e la salvezza del mondo. […]»
Qual è il vero valore del folklore come elemento ausiliario dello studio delle religioni?
«È un ambito appassionante, ancora male esplorato. Finora, è stato fatto solo un inventario sistematico del contenuto di tradizioni e leggende. Ma deve ancora venire lo storico delle religioni che classificherà questa documentazione folklorica secondo le scoperte della propria disciplina. Credo che sarà lo scopo della prossima generazione. Nel corso dei secoli, nel folklore sono state integrate credenze risalenti a epoche molto diverse fra loro. Alcune risalgono al Paleolitico, altre al Neolitico! Vi sono anche elementi di religioni anteriori al cristianesimo, che l'arrivo della nuova fede ha relegato allo spazio infimo dei costumi popolari. Altri ancora, infine, rimandano a eresie come gnosticismo e manicheismo. Tutto ciò corrisponde a lotte d'influenza, durate talvolta interi millenni. Respinta dal giudaismo, la religiosità cosmica esiste sempre. A sua volta il cristianesimo ha ripreso numerose credenze antecedenti. Si trattava di omologare universi religiosi diversi, al fine di uniformare culturalmente l'ecumene. Così, ad esempio, i numerosi eroi e dèi uccisori di draghi della tradizione indoeuropea sono stati identificati con San Giorgio. Analogamente, in Grecia, dopo l'incendio del santuario di Eleusi nel 396, evento che simboleggia la fine del paganesimo, un san Demetrio, sacro patrono dell'agricoltura, prende in modo del tutto naturale il posto della dea Demetra...».
Ha scritto che «il mito narra una storia sacra; riferisce un avvenimento che ha avuto luogo nel tempo primordiale». D'altra parte, sostiene che può costituire un mito solo quanto si riallaccia ad «archetipi» (nel senso di modelli esemplari, paradigmatici). Vi sono strutture mitiche moderne?
«Credo che il solo esempio moderno che si possa citare è il mito marxista-comunista della fine dei tempi. In modo piuttosto rigoroso la filosofia marxista della storia traspone la concezione giudeo-cristiana di un inizio e una fine della storia assoluti. Vi si ritrova l'idea di una grande “battaglia finale" escatologica, seguita da uno stato paradisiaco (la “società senza classi") e chiamata a ricostituire l'Eden originario. In questo caso, è il proletariato ad assumere il ruolo messianico del Giusto sofferente. L'idea che sia necessario annientare tutto affinché appaia un mondo nuovo non è ovviamente nuova. Il “mito" del comunismo può così essere interpretato come una sorta di parodia profana del mito dell'Età dell'Oro. E il motivo dell'attrazione che esercita risiede probabilmente nel suo aver raccolto il testimone del profetismo millenarista giudeo-cristiano».
Nell'intervista con Claude-Henri Rocquet racconta di aver scoperto, in India, l'«uomo neolitico», vale a dire l'importanza del passato più remoto, e il modo in cui può inscriversi nel presente, tramite miti e simboli. Ciò mette in luce l'importanza della memoria collettiva - quella memoria a cui Platone e Cicerone attribuivano un valore spirituale. Oggi le società moderne non la stanno forse perdendo?
«In una certa misura, sì. Solo un secolo fa, un contadino romeno, cinese, portoghese o indiano, sapeva che la natura esprimeva il sacro a modo suo. Ma è forse qui che subentra il ricercatore. La storia delle religioni ha una funzione catartica: ci aiuta a vincere le inibizioni che ci impediscono di amare la nostra storia e tutto quanto l'ha preceduta».
Nel suo Diario, lei evoca l'idea di una prossima «fine della civiltà occidentale». Ma, al tempo stesso, afferma di avere una «fiducia senza limiti nella potenza creatrice dello spirito». Come stanno le cose, esattamente?
«Non sono pessimista, poiché non credo a un determinismo assoluto. Oggi la civiltà occidentale si sta trasformando in modo considerevole. Gli europei hanno perso il proprio complesso di superiorità. Spero che questo non ci faccia cadere, viceversa, in un complesso d'inferiorità. Da un certo punto di vista, al giorno d'oggi la nostra civiltà ha più possibilità di rinnovarsi di quante non ne abbia mai avute prima. E poi, non si esce mai dalla storia. È possibile evadere da essa solo tramite lo spirito».
In fin dei conti, è l'«uomo eterno» a trionfare?
«Proprio così. Credo che vi siano delle tappe, ma anche una ri-creazione, una eterna ri-creazione».






