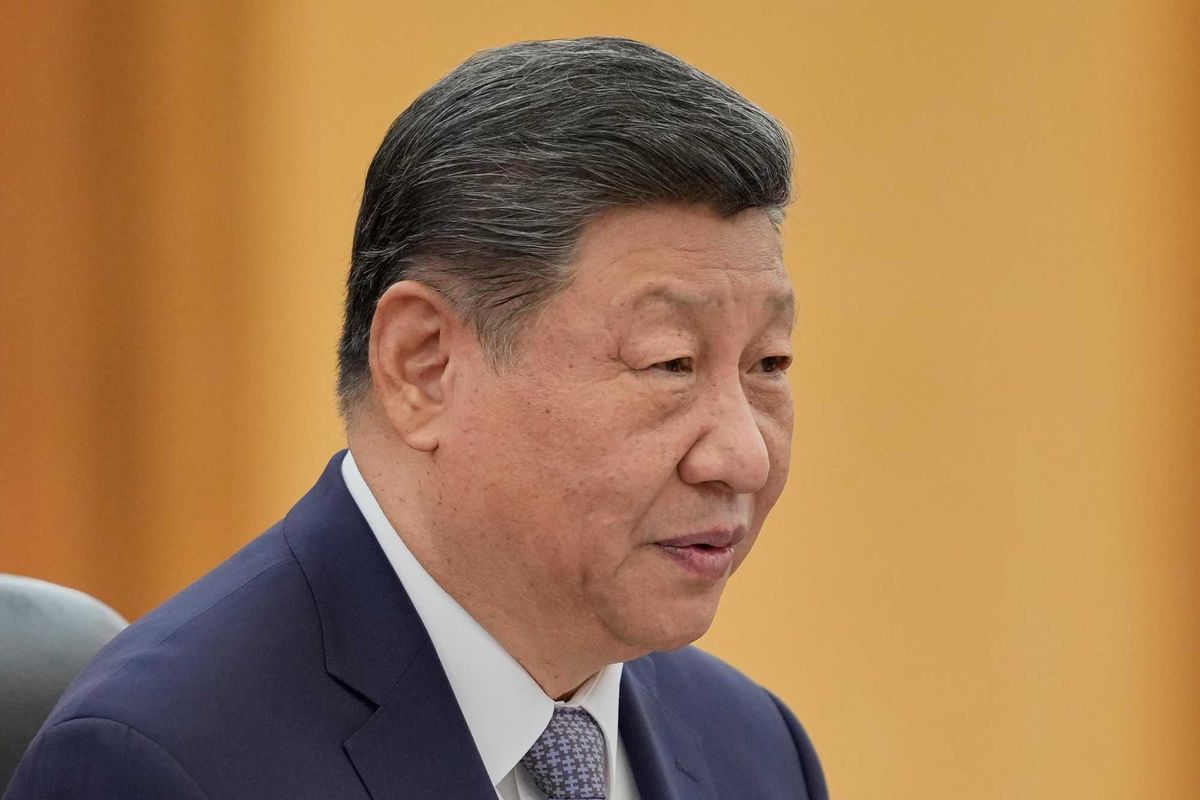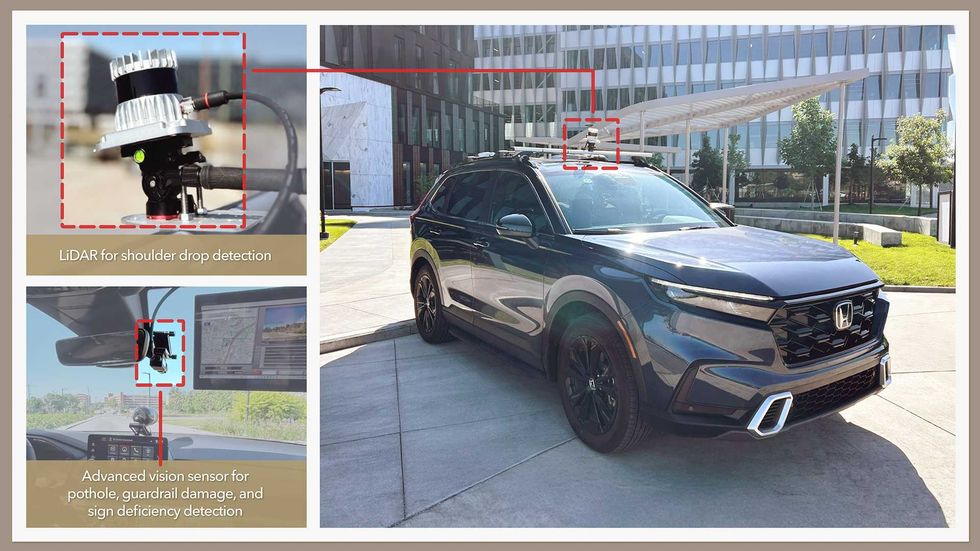- I cassonetti straripanti, l'invasione di roditori, la Tari in aumento. Ma per imprenditori avvoltoi ed ecomafie dei roghi la monnezza è un affare.
- «Senza impianti di smaltimento facciamo un favore ai criminali». Il magistrato Roberto Pennisi: «A delinquere sono aziende dal volto apparentemente pulito. Per contrastarle servono termovalorizzatori. Spedendo all'estero l'immondizia disperdiamo una ricchezza».
Lo speciale comprende due articoli.
Cassonetti che esplodono di rifiuti, battaglie quotidiane tra animali di ogni tipo per il controllo dei bidoni. Perfino macabre sorprese, come i denti umani che sono stati ritrovati nel quartiere romano di Montesacro. Ogni giorno, un nuovo capitolo si aggiunge al voluminoso libro nero dei rifiuti. E mentre ai cittadini viene spiegato che quello della spazzatura è un problema senza soluzione, c'è chi ha trasformato l'emergenza in opportunità. Chi ha fatto della monnezza un'enorme ricchezza.
Già, perché dietro ai sacchi dell'immondizia accatastati uno sull'altro si nasconde un business che vale oro. I numeri li fornisce la Banca d'Italia in uno studio pubblicato nel dicembre del 2018: «La Tari», la tassa sui rifiuti, «fornisce un gettito di quasi 10 miliardi di euro (di cui si può stimare che all'incirca il 60% sia prelevato sulle famiglie), corrispondente a quasi un quinto delle entrate comunali». Dieci miliardi l'anno, vale a dire circa 19.000 euro al minuto.
E pensare che dal 2015, secondo le stime del Servizio politiche territoriali della Uil, la tassa sui rifiuti aumenta puntualmente, con una crescita media dell'1,6% annuo. Rispetto al 2018, 44 capoluoghi italiani hanno stabilito un aumento delle tariffe. Quest'anno, le famiglie italiane verseranno nelle casse comunali una cifra media che si aggira intorno ai 302 euro, con picchi di 550 euro a Trapani e 492 a Benevento. Se spostiamo l'attenzione dalle utenze familiari alla spesa pro capite, Roma supera, e non di poco, le altre città: 597 euro di spesa annua contro i 151 euro di Palermo, secondo le stime Openpolis.
Eppure, cosa ha chiesto ai romani Ama - la municipalizzata partecipata dal Campidoglio - nell'ennesima emergenza rifiuti in cui è sprofondata la capitale? Di produrre meno. «È mio preciso dovere appellarmi al senso civico di tutti per fare innanzitutto prevenzione, contenendo al massimo la produzione di rifiuti», si legge nella nota scritta dalla presidente di Ama, Luisa Melara. Facile, non vi pare? La spazzatura invade le strade, le tariffe arrivano alle stelle e la soluzione è ridurre la produzione. Compito non facile in una città che produce circa 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti l'anno, più della metà di tutta la spazzatura prodotta dalla Regione Lazio. Si produce tanto, si smaltisce poco o nulla: come si legge nelle linee guida del piano rifiuti della Regione Lazio, «il 100% dei rifiuti destinati allo smaltimento è inviato fuori Comune e fuori Regione. Per trasportare i rifiuti fuori città, Roma spende 90.000 euro al giorno, quasi 40 milioni di euro l'anno».
Quello del «turismo dei rifiuti», del resto, è un fenomeno sistemico, che non riguarda solo Roma, ma che coinvolge l'intera penisola: secondo gli ultimi dati disponibili forniti da Unioncamere e aggregati dal deputato M5s Alberto Zolezzi, da una Regione all'altra si sposta una quantità di rifiuti pari a 42 milioni di tonnellate. «La Lombardia e l'Emilia Romagna», spiega Zolezzi, «sono le Regioni che importano più rifiuti in assoluto. La quantità non dipende tanto dalla produzione, ma dalla capacità impiantistica: più impianti ci sono, più rifiuti saranno attratti».
È in questo flusso continuo di spazzatura che viaggia da Nord a Sud che si possono annidare gli «avvoltoi», quelli che con la spazzatura ci guadagnano. A spese dei cittadini, ovviamente. Secondo l'ultimo rapporto Ecomafia di Legambiente, in Italia vengono accertati più di tre reati ambientali ogni ora. Quasi 22 al giorno, gli illeciti legati al ciclo illegale dei rifiuti. «Quello dei rifiuti è un settore altamente regolato: chi decide di non rispettare le norme può arrivare a guadagnare cifre importanti in pochi giorni», raccontano gli ex trafficanti, che del business conoscono ogni meccanismo. «Se viaggio regolare prendo 18-20.000 euro a settimana!», spiegava, intercettato, uno degli imprenditori coinvolti nell'ultima inchiesta della Dda di Milano, condotta dai carabinieri del Noe, che ha portato alla luce un sistema di smaltimento illecito dei rifiuti, che dalla Campania venivano stoccati nei capannoni del Nord, tra Lombardia e Veneto.
Come si legge nell'ordinanza di custodia cautelare, «queste società», che fanno perno sulla Winsystem group srl di Cornaredo, «reperiscono capannoni industriali, che vengono stipati di rifiuti senza alcuna autorizzazione e senza alcuna precauzione per la salute e l'incolumità pubblica». Insomma, gli affari prima di tutto. «La merda è diventata miniera! La merda è oro!», si dicevano commentando i guadagni ottenuti.
Come scrive il giudice per le indagini preliminari, Giuseppina Barbara, gli imprenditori coinvolti sono «totalmente accecati dalla prospettiva di realizzare in tempi molto ristretti ingentissimi guadagni, che lo smaltimento dei rifiuti con modalità illecite garantisce con rischi penali tutto sommati contenuti». Già, le conseguenze penali. Sapete quanto rischia chi viene scoperto a trafficare illecitamente rifiuti? Da uno a 6 anni, che scendono a 3 o 4 anni in caso di rito alternativo. E allora è chiaro, come si legge ancora nell'ordinanza, «che i trafficanti ritengono vantaggioso correre il rischio».
Pochi problemi, resa assicurata: così si spiega l'interesse che le imprese hanno nell'acquisire la maggior quantità di rifiuti possibile. Peccato che poi debbano essere trattati, messi in sicurezza, smaltiti secondo le norme di riferimento. E invece, molto spesso, vengono abbandonati all'interno di vasti capannoni. E quando non si riesce più a gestirli o a trasferirli in altri siti, che si fa? Si dà fuoco.
Come si legge nella relazione della commissione speciale Antimafia, anticorruzione e legalità della Regione Lombardia, «la volontà di sbarazzarsi di enormi quantitativi di rifiuti acquisiti illegalmente, oppure da sottoporre a costose procedure di trattamento dopo aver intascato i proventi relativi alla raccolta, rende il ricorso al fuoco la soluzione più opportuna per le organizzazioni criminali».
Dalla fine del 2017, il fenomeno dei roghi divampati nei pressi dei siti di gestione dei rifiuti ha assunto dimensioni inquietanti: secondo il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, sentito in audizione davanti alla commissione Ecomafie, in un anno si sono verificati 262 incendi, quasi uno ogni tre giorni.
Il 45,5% degli incendi, secondo la commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite collegate al ciclo dei rifiuti, si concentra al Nord, disseminato ormai di tante piccole terre dei fuochi.
In Lombardia, per esempio, negli ultimi due anni si contano più di 30 roghi, molti dei quali dalle caratteristiche simili. Milano, 14 ottobre scorso: un capannone dell'azienda di stoccaggio rifiuti di via Chiaasserini - zona Bovisasca - va in fiamme, 16.000 metri cubi di rifiuti vanno a fuoco, scatta l'allarme diossina, i cittadini vengono invitati a tenere chiuse le finestre, per giorni l'aria è appesantita dalla nube di fumo che avvolge la città.
Un caso isolato? Macché. «Lainate, Bruzzano, Cinisello Balsamo, Novate Milanese, Cornaredo: in regione si sta combattendo una “guerra dei rifiuti", che le amministrazioni locali, spesso lasciate da sole, faticano a fermare», scrive Monica Forte, relatrice dell'indagine conoscitiva sullo stoccaggio e il traffico illecito di rifiuti in Regione Lombardia.
Situazione simile anche in Veneto, dove sono 26 gli incendi appiccati negli ultimi due anni, la maggior parte dei quali concentrati nelle province di Venezia, Verona e Padova.
E pensare che i rifiuti potrebbero essere un'opportunità: all'estero, per esempio, lo smaltimento della spazzatura è una fonte di guadagno notevole. In Italia, invece, si preferisce correre dietro all'emergenza. Non riusciamo a trattare i rifiuti come si dovrebbe e allora, per tamponare le falle, finiamo per spedirli oltreconfine, pagando perché gli altri si arricchiscano con quello che produciamo noi.
Ad esempio, nel 2017, secondo l'Ispra, l'Italia ha esportato 355.000 tonnellate di rifiuti all'estero, verso Austria, Ungheria, Svezia e Portogallo, per una spesa complessiva che si aggira intorno ai 150 milioni di euro.
Capite? All'estero aspettano a braccia aperte i nostri rifiuti, mentre noi restiamo a mani vuote. Inermi di fronte a chi con la monnezza fa affari, anche a scapito della nostra salute.
«Senza impianti di smaltimento facciamo un favore ai criminali»
«Negli ultimi anni si è creata un'elite di trafficanti molto forte. Vediamo spesso gli stessi imprenditori, le stesse aziende che ricorrono nelle svariate inchieste avviate lungo tutto il territorio nazionale».
Roberto Pennisi, magistrato della Direzione nazionale antimafia, da oltre 30 anni lotta contro ecomafie e crimini ambientali. E oggi spiega alla Verità come gli avvoltoi dei rifiuti siano quasi sempre imprese dal volto apparentemente pulito, aziende formalmente in regola che si mettono a operare in modo illegale. E come l'assenza di impianti di smaltimento, in particolare i termovalorizzatori, finisca con il favorire gli affari loschi di chi, nei rifiuti, ha trovato un'inesauribile fonte di guadagno.
Dottor Pennisi, a che punto è il contrasto alla criminalità ambientale?
«Per decenni, in Italia, è mancata una seria legislazione in materia di contrasto al crimine ambientale. Pensi che fino al 2001, la legislazione penale in materia ambientale non prevedeva neppure un delitto. Erano tutte contravvenzioni».
Oggi il Codice prevede il delitto di «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti».
«Credo sia il migliore strumento per il contrasto alla criminalità ambientale. Migliore anche dei reati di inquinamento e disastro ambientale, introdotti nel 2015».
Per chi traffica illecitamente rifiuti il Codice prevede una pena che va da uno a sei anni. Non le sembra un massimo edittale troppo basso per essere considerato un vero deterrente?
«L'imprenditore non teme tanto il carcere, quanto le conseguenze patrimoniali. Per chi traffica illecitamente rifiuti sono previsti il sequestro e poi la confisca dell'impresa e dei proventi realizzati. Per questo credo che il 452 quaterdecies sia un ottimo strumento sul quale costruire la strategia di contrasto alla criminalità ambientale».
Come è cambiata la strategia delle Procure in questi anni?
«Si è cominciato a comprendere il vero senso del crimine ambientale, che non fa più capo a strutture di tipo mafioso, bensì alle imprese deviate».
Il crimine ambientale oggi ha la faccia pulita, verrebbe da dire.
«A svolgere questa attività non sono strutture criminali, sono strutture legali che deviano dal percorso previsto dalla legge. Ciò le rende ancor più pericolose: se imboccano la strada dell'illegalità, è molto più facile che si avvalgano anche del supporto delle strutture criminali tradizionali».
Nel 2018, secondo il Rapporto ecomafia di Legambiente, sono stati accertati quasi 22 illeciti al giorno nel ciclo illegale di rifiuti.
«Il rifiuto è qualcosa che nessuno vuole avere tra le mani. Per disfarsene bisogna affrontare un costo. L'imprenditore, se non è virtuoso, tenderà ovviamente a spendere meno rispetto a quanto preventivato. Il rifiuto meno lo tocchi e più guadagni».
Assistiamo al paradosso per cui le discariche legali vengono usate per fini illegali.
«Se in una discarica autorizzata metto quel che non posso mettere, mi trovo davanti a una discarica autorizzata usata in maniera abusiva. Questo è il senso della pericolosità del crimine ambientale. Viene posto in essere da persone autorizzate, in luoghi autorizzati. Ma tutto avviene in maniera distorta, in violazione della legge».
E quando non si riesce a portare a termine lo smaltimento, si ricorre al fuoco.
«Il fuoco ti risolve il problema. Non devi fare nulla con una cosa che ha preso fuoco. L'imprenditore intasca la somma pattuita per prendere in carico i rifiuti, ma non li condurrà mai alla loro destinazione naturale».
Come se ne esce, secondo lei?
«Il sistema criminale è favorito dal fatto che circolano troppi rifiuti in Italia e non abbiamo abbastanza impianti per trattarli».
Che tipo di impianti ha in mente?
«Termovalorizzatori. Il termovalorizzatore, se usato correttamente, è un ottimo strumento di contrasto al crimine ambientale».
C'è chi obietta alla sua visione, dicendo che i termovalorizzatori inquinano.
«In Italia manca una strategia di ampio respiro, nazionale. E una visione nazionale non può prescindere dai termovalorizzatori. Certo, ci sarà un certo quantitativo di inquinamento, ma se tutto viene fatto nelle regole è un quantitativo ammesso. Ha idea di quanto inquinino 10.000 o 100.000 impianti di riscaldamento autonomi? E poi, perché al centro di Vienna c'è un termovalorizzatore? È una città inquinata?».
Altri dicono che per portarli a regime c'è bisogno di troppo tempo.
«Pensare all'oggi senza una visione futura è tipico della politica. In materia ambientale tutto quel che si fa lo si fa pensando al futuro. Il contrasto del crimine ambientale è una garanzia per le generazioni future».
Forse fa più comodo correre dietro all'emergenza?
«Ci si riempie la bocca con parole come “economia circolare", ma è solo aria fritta in assenza di strumenti concreti. È necessario agire perché il rifiuto diventi una ricchezza».
Come accade all'estero, dove esportiamo i nostri rifiuti.
«Portare i rifiuti all'estero è sbagliato per tre motivi: paghiamo il trasporto; paghiamo perché qualcuno li prenda in consegna; paghiamo perché ad arricchirsi siano gli altri. Questo è l'emblema di una strategia che non c'è. Non abbiamo capito che il rifiuto è una ricchezza, che stiamo disperdendo in modo riprovevole».