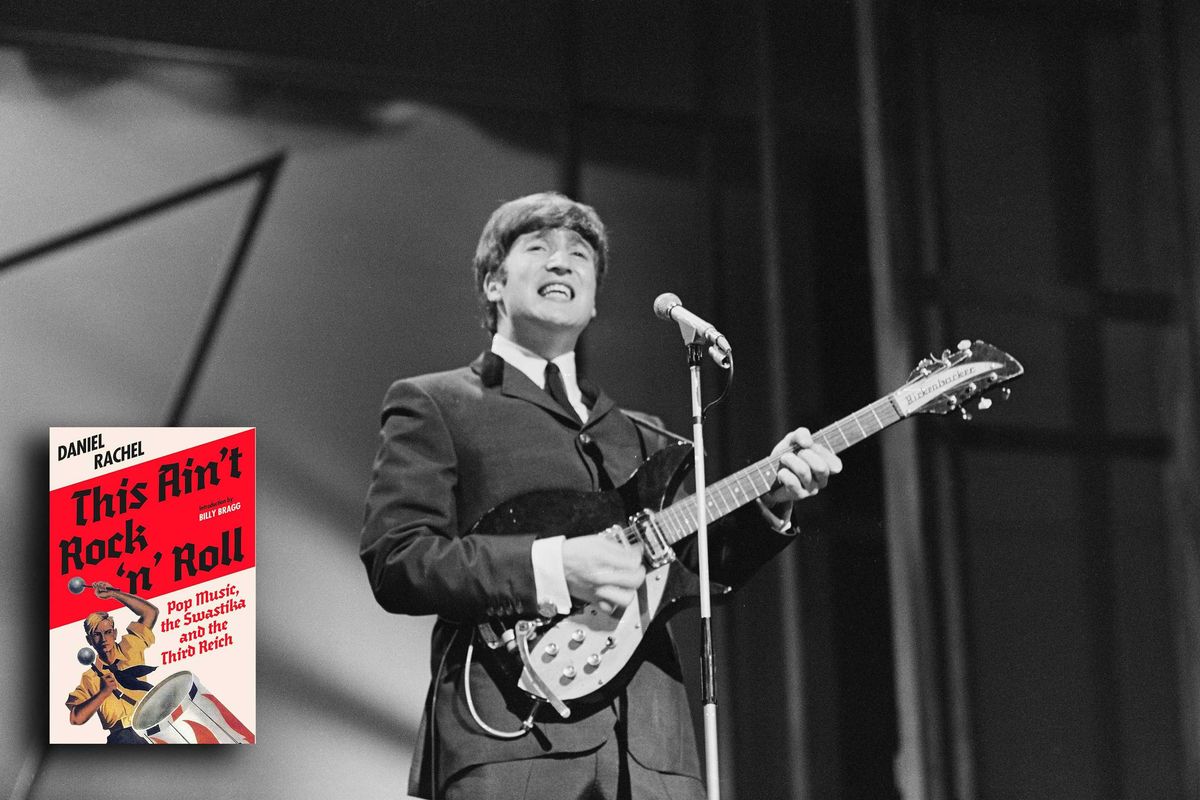Il dolce di Napoli non si mangia più solo a Pasqua ma si prepara tutto l’anno. Le origini sono mitiche. E può anche essere salato.È un piccolo grande mondo a sé, con storia, tradizioni e traduzioni materiali al piatto che la rendono unica. Dice di lei Stanislao Porzio: «La pastiera non è una realtà univoca, ma una serie di possibilità che, se messe in fila, la prima sarà abissalmente diversa dall’ultima», all’interno di una gamma di ingredienti fissata dall’uso, ma le cui proporzioni sono variabili.Inizialmente legata alla Pasqua, la preparazione, poi, si è spalmata lungo tutto il calendario. Nonostante questo, la pastiera ha mantenuto salda la tradizione domestica, ogni famiglia è custode dei suoi piccoli segreti, con una estensione alle pasticcerie dell’area campana che la propongono in varie versioni, spesso quale merce d’asporto per i turisti di passo. Come ha scritto qualcuno, la pastiera è l’apoteosi del grano, che ne è protagonista, nella sostanza, ma anche nella mitologia che lo accompagna ad iniziare dall’etimo, laddove per alcuni risale al latino «pastinare», cioè zappare, a conferma dello stretto legame tra il dolce e gli antichi riti legati alla fertilità del terreno.Una tradizione giunta a noi con una missione condivisa di generazione in generazione: quella di «sentirsi elemento di una catena che non si spezza». Inevitabile il ricorso alle radici, ben salde nella mitologia conseguente, a iniziare da quella che vede protagonista la sirena Partenope, come riportato da Lejla Mancusi Sorrentino citando alcuni passaggi di Bruno Stocchetti, leggendaria firma de Il Roma, lo storico quotidiano partenopeo. Partenope scelse il golfo su cui si specchiava il Vesuvio quale residenza prediletta e, sul fare della primavera, emergeva dalle acque con il suo canto melodioso per allietare le genti del posto. Generosità ricambiata. Furono scelte sette tra le più belle fanciulle del luogo per portare sulla rena altrettanti prodotti, frutto della terra, quale omaggio alla serenità che trasmetteva la sirena.Ognuno con un preciso riferimento. La farina quale simbolo di ricchezza; la ricotta, di abbondanza; le uova, di fertilità; il grano cotto nel latte, fusione tra mondo animale e vegetale; l’acqua di fiori d’arancio, simbolo della terra campana; le spezie, omaggio ai popoli lontani, di cui Napoli era crocevia; lo zucchero, assimilato alla dolcezza del canto di Partenope la quale, riconoscente, il giorno dopo restituì il tutto assemblato in magica armonia. Nacque così la prima pastiera.Poi vi è la versione più laica. Le mogli di alcuni pescatori, non vedendoli tornare dalla pesca notturna, bloccati al largo da una mareggiata, lasciarono loro alcuni prodotti, protetti da una rete, per dare conforto alle bocche affamate al loro auspicato ritorno. La mareggiata di Nettuno fece il resto, tanto che rimescolò il tutto dentro la rete e così i marinai, finalmente giunti a riva, trovarono una pastiera, meritato premio al loro digiuno.Non poteva mancare un’altra lettura, stavolta goliardica, dal tocco aristocratico. Ferdinando II di Borbone, re delle Due Sicilie, rimasto vedovo sposò in seconde nozze la riservata Maria Teresa d’Asburgo, la regina «che non rideva mai». Casualmente, dalla cucina di corte, un giorno arrivò un dolce poco in uso nel nobile casato. E fu così che al solo suo assaggio, la regina triste debuttò con un sorriso compiaciuto. Fu allora che il re, piacevolmente sorpreso, se ne uscì con una frase divenuta poi celebre «E mammamì, magnatella ‘na risata», gioia e piacere, con un sorriso, ad accompagnare un dolce presente da secoli, con i suoi profumi, tra i vicoli dei quartieri partenopei. Dalla mitologia alla storia documentata il passo è breve.Le prime tracce scritte sono della metà del XV secolo, laddove Jacopo Sannazzato racconta come «quel bel colore biondo delle pastiere ti faccia subito saziare», messaggio rinforzato un secolo dopo da Gioan Battista del Tufo che sottolinea come «l’odor e il sapor delle pastiere ogni gusto eccede», con una nota di colore che ne sottolinea la radicata tradizione domestica di un dolce «ben preparato da le mogli lasciando per allor pettini e specchi». La prima ricetta scritta del 1692, a opera di Antonio Latini, anconetano ma trapiantato a Napoli per meriti culinari. Si narra di cascio parmiggiano grattato, pistacchi ammaccati e marzapane. Una versione prevalentemente salata in cui non vengono citate le uova. Seguirà, nel 1773, Vincenzo Corrado che, nelle pagine del suo Il cuoco galante parla di una torta di frumento cotto nel brodo, arricchito con la sugna, il grasso di maiale. Ingentilisce il tutto l’acqua ai fiori d’arancio. La panna sostituisce la ricotta, posto che così alleggerisce i retrogusti del brodo di cappone.Ci si avvicina alla versione moderna come la conosciamo oggi con la pastiera elaborata dalle suore del monastero di San Gregorio Armeno, così prese da questa loro parallela missione laica che una loro consorella, Enrichetta Caracciolo, le riprende con una nota nel suo diario citando «quelle consorelle di scarsa spiritualità che preferiscono dedicarsi ai dolci anziché alle cerimonie liturgiche». Che la pastiera abbia salde radici popolari lo conferma Ippolito Cavalcanti, nel 1837, con il suo La cucina casereccia in dialetto napoletano, con una sorta di quadratura finale del cerchio, sino ad allora estremamente mobile, nell’equilibrio tra i diversi ingredienti e le rispettive proporzioni. Il tutto rigorosamente scelto presso i negozianti di fiducia, integrati dalla presenza delle «pascarelle», venditrici ambulanti che si preannunciavano tra i vicoli con il richiamo «u ggrano p’à pastiera».Spesso si trattava della risciola, un grano antico che, a Napoli, veniva conservato nei magazzini pubblici per essere distribuito ai poveri in caso di carestia. È con questa varietale che Raffaele Esposito, nel 1889, omaggiò con la sua pizza la regina Margherita in visita in città. Con un volo radente sui diversi ingredienti emergono alcune caratteristiche. Il grasso animale (la sugna) è preferito al burro non solo perché più abbordabile per le classi popolari ma anche perché, mescolandosi al resto, conferisce una maggior morbidezza finale, tanto che la vera pastiera deve regalare una goccia al taglio, simbolo di umidità e, quindi, migliori retrogusti all’interno.La frutta candita si abbina a relativa simbologia: ad esempio con la zucca segno di nutrimento e immortalità, oltre al cedro e all’arancio, quest’ultimo presente anche con un distillato dei suoi fiori, il neroli, talmente prezioso che Giacomo Cautiello ne usa dieci gocce per cento chili d’impasto. Ai profumi intriganti si aggiunge la vaniglia, tanto che la pastiera «si annuncia all’olfatto prima che al palato». La pastiera, quindi, è una «apoteosi del grano», con una inedita combinazione. Lavorato a farne da astuccio, integro e cotto così da renderlo succoso all’interno. Sulla decorazione a losanghe si è discusso a lungo, in tempi recenti, per la burlona trovata secondo la quale queste dovrebbero essere sette, richiamo ai decumani di antica origine in cui era divisa la pianta urbana. Niente di vero, tanto che, con ironia tipicamente partenopea, qualcuno ha rilanciato che, in realtà, siano un rimando alle grate (dette gelosie) messe alle finestre dei vicoli per impedire ai curiosi di sbirciare la bellezza delle donne di casa.Fra tradizione e leggenda della pastiera tradizionale esistono anche altre versioni territoriali, ognuna con la sua storia: ad esempio la pastiera di riso, detta pastiero, nel Salernitano o la pastiera salata (con salumi e formaggi, antico retaggio storico) nel casertano, a pastier e’ ferellini (i capellini di pasta lunga) a Torre del Greco. Tutte, comunque, degne di concorrere alle olimpiadi del gusto, ovvero la pastiera regina, intrigante e goloso concorso ideato nel 2021 dal funambolico Stanislao Porzio, al quale dobbiamo gran parte delle fonti di questo racconto.
Il Tempio di Esculapio, all’interno del parco di Villa Borghese (IStock)
La capitale in versione insolita: in giro dal ghetto ebraico a Villa Borghese, tra tramonti, osterie e nuovi indirizzi.
John Lennon e la cover del libro di Daniel Rachel (Getty Images)
Un saggio riscrive la storia della musica: Lennon si ritraeva come il Führer e Clapton amava il superconservatore Powell.
L’ultimo è stato Fedez: dichiarando di preferire Mario Adinolfi ad Alessandro Zan e scaricando il mondo progressista che ne aveva fatto un opinion leader laburista, il rapper milanese ha dimostrato per l’ennesima volta quanto sia avventata la fiducia politica riposta in un artista. Una considerazione che vale anche retrospettivamente. Certo, la narrazione sul rock come palestra delle lotte per i diritti è consolidata. Non di meno, nasconde zone d’ombra interessanti.
Gianrico Carofiglio (Ansa)
Magistrato, politico in quota Pd per un breve periodo e romanziere. Si fa predicatore del «potere della gentilezza» a colpi di karate. Dai banchi del liceo insieme con Michele Emiliano, l’ex pm barese si è intrufolato nella cricca degli intellò scopiazzando Sciascia.
(IStock)
Pure la Francia fustiga l’ostinazione green di Bruxelles: il ministro Barbut, al Consiglio europeo sull’ambiente, ha detto che il taglio delle emissioni in Ue «non porta nulla». In Uk sono alle prese con le ambulanze «alla spina»: costate un salasso, sono inefficienti.
Con la Cop 30 in partenza domani in Brasile, pare che alcuni Paesi europei si stiano svegliando dall’illusione green, realizzando che l’ambizioso taglio delle emissioni in Europa non avrà alcun impatto rilevante sullo stato di salute del pianeta visto che il resto del mondo continua a inquinare. Ciò emerge dalle oltre 24 ore di trattative a Bruxelles per accordarsi sui target dell’Ue per il clima, con alcune dichiarazioni che parlano chiaro.