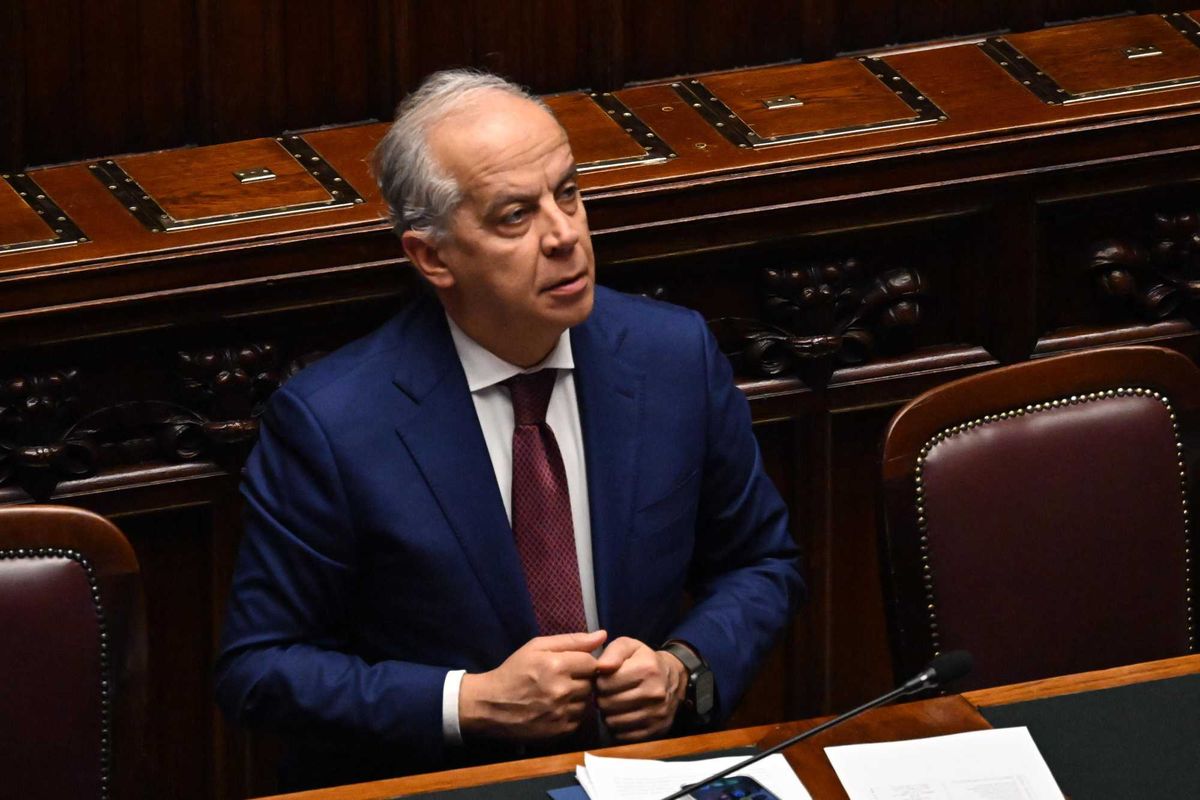C’è un agrume che ci dona i suoi frutti in estate ma anche a novembre e dicembre e parte di gennaio e, soprattutto, rende grande e unico un dolce caratteristico del Natale appena passato, di origine milanese ma ormai nel cuore della nazione tutta e anche fuori di essa, il panettone. Pochi lo sanno, ma i canditi del panettone devono essere di arancia e di cedro (la buccia). Non canditi misti come si vede a volte, per esempio con ciliegie o zucca candita, ma solo questi due. Il cedro, che si usa candito in tanti altri dolci dello Stivale, però non è solo un ingrediente del panettone, ma un albero da frutto che produce un agrume fondamentale, sebbene passi un po’ in sordina, rispetto ad arance e mandarini. Un agrume con una storia affascinante, ramificata e anche collegata alla nostra cultura cattolica.
Il nome botanico del cedro è Citrus medica. Appartiene alla famiglia delle Rutacee, al genere Citrus, alla specie medica. Il Citrus è un genere che ci interessa da molto vicino: le piante di questo genere della famiglia delle Rutacee sono quelle che chiamiamo colloquialmente - e commercialmente - agrumi. Sono arbusti o alberi (alberi sono le piante con tronco libero più chioma, arbusti sono quelle i cui rami partono dalla base) che possono arrivare anche a 15 metri di altezza e producono frutti molto profumati e molto ricchi di succo la cui caratteristica principale è l’acido ascorbico (la vitamina C). Frutti acri, dal latino acer cioè aspro, da cui il termine agrumi.
Il cedro insieme con il pomelo (Citrus maxima) e il mandarino (Citrus reticulata) costituisce la triade di agrumi dai cui incroci derivano tutti i restanti agrumi che conosciamo (e coltiviamo) oggi. Il cedro è anche il più antico agrume coltivato in Europa. Secondo Plinio il Vecchio il cedro è originario dell’antica Persia: nella Naturalis Historia lo chiama «mela assira». In greco antico si chiamava kitron e in latino citrus e con molta probabilità questi nomi derivano dal cedro del Libano - di cui parleremo in seguito - che in greco antico si chiamava kedros, in latino cedrus. La parola italiana cedro, che usiamo per entrambi, deriva dalla volgarizzazione del latino citrus in cedro, ma potrete trovare, soprattutto in italiano antico, il termine citro per indicare l’agrume e differenziarlo dal cedro del Libano.
Oggi il cedro è diffuso in molte parti del mondo: in Medio Oriente, in India, in Indonesia, in Australia, in Brasile, negli Stati Uniti e, ovviamente, in area mediterranea. Nell’area italiana, la regione che più è terra di cedro è la Calabria: lì esiste un’area chiamata Riviera dei Cedri che contiene anche toponimi dedicati al cedro come Santa Maria del Cedro, dove si trova anche il Museo del Cedro. Come mai questo toponimo? Anche qui abbiamo una bella storia. La coltivazione del cedro in Calabria si afferma già nel I-II secolo a.C. per mano degli ebrei ellenizzati che seguirono il cammino dei coloni Greci. È probabile che gli ebrei abbiano portato con sé alcuni esemplari di cedro per mantenere vivi i loro cerimoniali religiosi, uno dei quali (Sukkot) comprende ancora oggi l’utilizzo del cedro (identificato con il Perì ‘etz hadar citato nella Bibbia) che i rabbini considerano come il prezioso frutto dei Giardini dell’Eden. Il legame con il territorio è rimasto così forte che nel 1968 il comune di Cipollina cambiò nome nell’attuale Santa Maria del Cedro e ancora oggi, ogni anno, i rabbini del popolo ebraico arrivano in città per prendere i cedri da esportare. Santa Maria del Cedro è pure una varietà di cedro, conosciuta anche come liscia diamante che, da due anni, ha ottenuto il riconoscimento Dop.
Il Cedro di Santa Maria del Cedro Dop è il frutto, o esperidio, allo stato fresco ottenuto dalla coltivazione della varietà liscia-diamante della specie Citrus medica. La zona di produzione del Cedro di Santa Maria del Cedro Dop comprende il territorio di 18 comuni in provincia di Cosenza. È disponibile dal 15 ottobre fino a tutto gennaio per la raccolta principale e dal 15 febbraio fino a tutto maggio per la raccolta tardiva: mentre leggete, lo stanno raccogliendo. Il Cedro di Santa Maria del Cedro Dop presenta una buccia esterna liscia e carnosa ed è quello più pregiato e più diffuso in Calabria. A Santa Maria del Cedro ogni anno si svolge il Mediterraneo Cedro Festival. Ma le feste dedicate al cedro nello Stivale non finiscono qui: a Forlì il primo giorno di maggio durante la festa dedicata al santo servita Pellegrino Laziosi si svolge la fiera del cedro, a Bibbona, in provincia di Livorno, il giorno di Pasquetta, si tiene la festa del cedro per ricordare l’uso antico e locale del cedro come dazio.