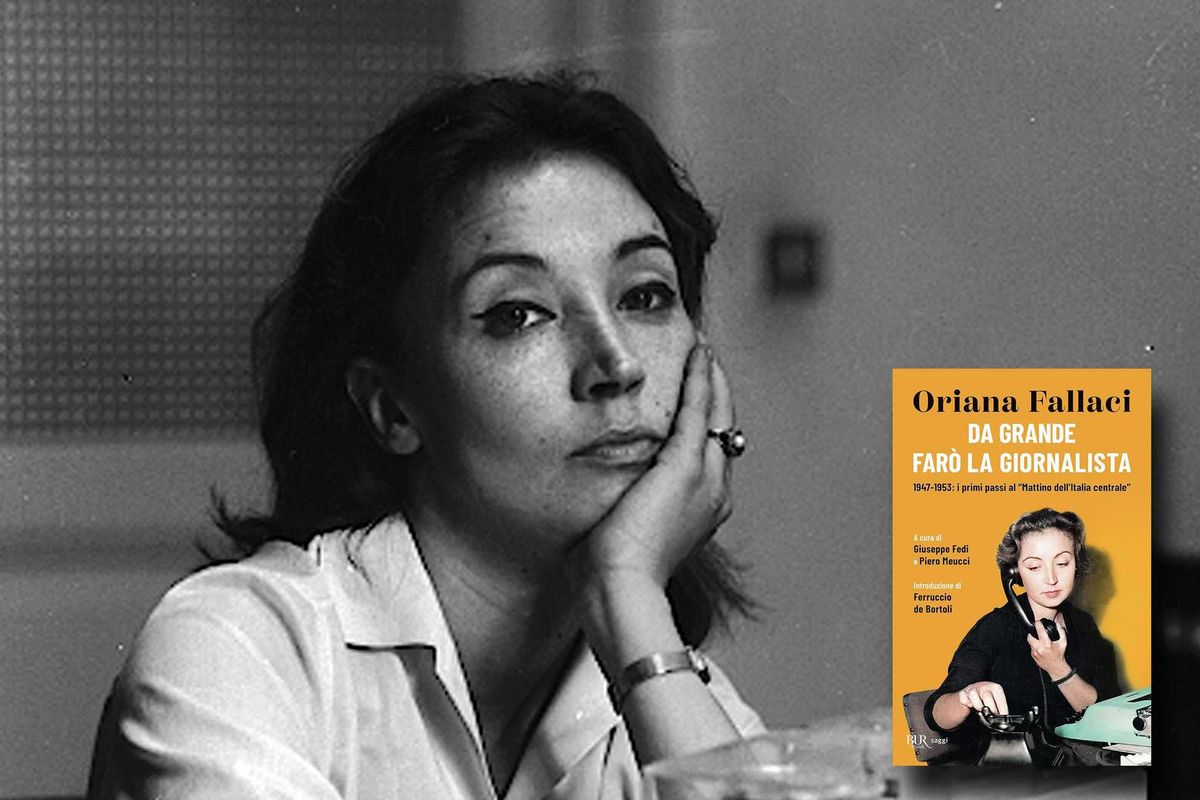Fiorenzo Caterini: «I boschi della Sardegna sono i miei luoghi di riflessione e intimità»

Fiorenzo Caterini (Lodi, 1965) è laureato all’Università di Sassari in Scienze dei beni culturali, specializzato in Antropologia culturale; lavora come ispettore nel Corpo forestale della Regione Sardegna. Nel 2013 l’editore sassarese Carlo Delfino pubblica l’ampio saggio Colpi di scure e sensi di colpa, uno studio sul disboscamento della Sardegna dalle origini ad oggi, con particolare dovizia di dettagli per quanto riguarda il XIX secolo, quando le foreste isolane vennero drammaticamente ridotte di quattro quinti. Il libro riceve il Premio Siro Vannelli, intitolato al primo cercatore di grandi alberi dell’isola, e molti attestati di stima, tanto che ancora oggi, a dieci anni dall’uscita, viene ristampato e presentato. Successivamente lo stesso editore ha pubblicato il saggio La Mano destra della storia ed il romanzo La notte in fondo al mare.
Colpi di scure e sensi di colpa è un vero colpo al cuore! Qui sulla terraferma sappiamo che i Savoia hanno derubato la Sardegna di molti suoi tesori boschivi e forestali, ma non ci si rende mai conto della vastità del danno, forse tendiamo inconsciamente a diminuirlo, a dimenticarlo, è oltremodo qualcosa di remoto. E invece, per fortuna, il suo libro ne parla, ci offre dati e testimonianza, ed è anche per questo che ancora viene presentato nonostante siano passati dieci anni dalla sua uscita, un’epoca nell’isterico mercato editoriale dei nostri giorni. Ma come è nato quel libro?
«La storia del disboscamento della Sardegna stava per venire confinata, mia impressione, in un ambito mitologico, anticamera del revisionismo e del negazionismo. Vedevo residui di antiche, splendide foreste e mi domandavo che fine aveva fatto il bosco che le aveva generate. Così ho iniziato una lunga ricerca, durata diversi anni, per raccogliere tutto quello che si poteva sull’argomento, scoprendo una persino sorprendente ed inequivocabile concordanza nell’incrociare i dati interdisciplinari: testimonianze dell’epoca, ma anche quelle che prima dell’Ottocento descrivevano una natura ricca di boschi, e quelle che dopo l’Ottocento dicevano il contrario; il parere dei botanici e dei naturalisti; le statistiche dell’epoca che disegnano una curva matematica coerente; i dati economici, topografici e gli studi degli storici. Alla fine emerge un quadro impietoso del più grande disastro ecologico dei nostri tempi, sulla quale ne ho tratto delle osservazioni di natura antropologica sulla natura del rapporto tra uomini e boschi durante le trasformazioni sociali ed economiche che si sono succedute nel tempo».
Abbandonando questa enorme ferita per arrivare ai tempi nostri, la Sardegna viene vista come uno dei serbatoi del nostro capitale naturale, della biodiversità e parlando a nome dei cercatori d’alberi secolari, anche una delle mete più ambite ed emozionanti laddove incontrare alberi millenari e maestosi. Come siamo arrivati al paesaggio odierno? Come sta insomma la natura dell’isola? Quali i fattori positivi e quali le criticità?
«Ora che una buona parte del patrimonio boschivo è stato reimpiantato, la natura sarda soffre dell’abbandono dell’agricoltura e dello spopolamento delle zone interne. Le motivazioni sono, come dire, molto “moderne”, e vanno ricercate nel distacco (economico, sociale e culturale) dalla natura e dal territorio degli esseri umani in questa parte di mondo occidentale. Sicché oggi cresce il cosiddetto “terzo paesaggio”, una distesa di incolti e macchia involuta che non è agricoltura e non è bosco. È una criticità nel versante degli incendi, ad esempio: dopo anni di trend positivo, le vaste aree abbandonate non presentano quella discontinuità che consente di controllare gli eventi incendiari. Ma allo stesso tempo, questo territorio abbandonato può essere una grande risorsa, se si pensa ai paesaggi, alla biodiversità, alla storia e alle tradizioni che racchiude».
Ha collaborato al progetto La maestra muta, un tentativo di ampliare la storia sarda tra i sardi, tra gli insegnanti che operano in Sardegna. Che risultati avete ottenuto?
«Ho collaborato come docente al progetto del Cesp, centro studi del Cobas scuola Sardegna, che è poi si è fermato con la pandemia. Sono state giornate di studio intense con gli insegnanti di tutte le scuole nei principali centri dell’isola. L’argomento di studio è stato principalmente il grande mistero della trascuratezza della storia sarda e in particolare nuragica, cioè della più importante civiltà dell’età del bronzo del Mediterraneo e dell’Europa occidentale, che è praticamente sconosciuta in Italia, al punto che è quasi completamente trascurata nei libri di testo e in molta letteratura nazionale. È l’argomento del mio secondo saggio La Mano Destra della Storia, sul problema storiografico sardo».
Esiste un luogo della natura sarda per lei speciale? Al quale magari fa ritorno spesso per motivi del tutto personali, intimi? Ce ne può parlare?
«Sono i luoghi della meditazione, dell’intimità, della solitudine e della riflessione. Da sardo non posso che ammettere tanta fortuna. “All’uomo che cavalca lungamente per terreni selvatici viene desiderio d’una città”, scrisse Italo Calvino ne Le città invisibili. Per me che la natura è luogo di studio e di lavoro, Cagliari è la città ideale per il cavaliere desideroso, dove trovare le opportunità cittadine ma anche una natura sorprendente: poter fare lunghe passeggiate, magari all’alba, nella lunga spiaggia bianca del Poetto; o salire in cima al promontorio di Capo Sant’Elia dove si gode di un panorama meraviglioso; ammirare i fenicotteri che al tramonto solcano il cielo sopra il placido stagno di Molentargius, dove anticamente si estraeva il sale, oggi Parco Regionale. Ma l’elenco dei luoghi speciali è troppo lungo, in Sardegna. Noi sardi stessi lasciamo pezzetti di cuore ovunque andiamo, in questa isola che è «quasi un continente». Ci sono i paesi dell’isola che hanno qualcosa di speciale nel connubio tra il territorio e le persone che ci vivono, per non parlare, ahimè, di quello che si mangia e si beve. Ecco, quando vado in quei paesi, Oliena, Lula, Ollollai, Fonni, Baunei e tanti altri, non so perché, ma torno a casa con il cuore gonfio di gioia e di umanità».