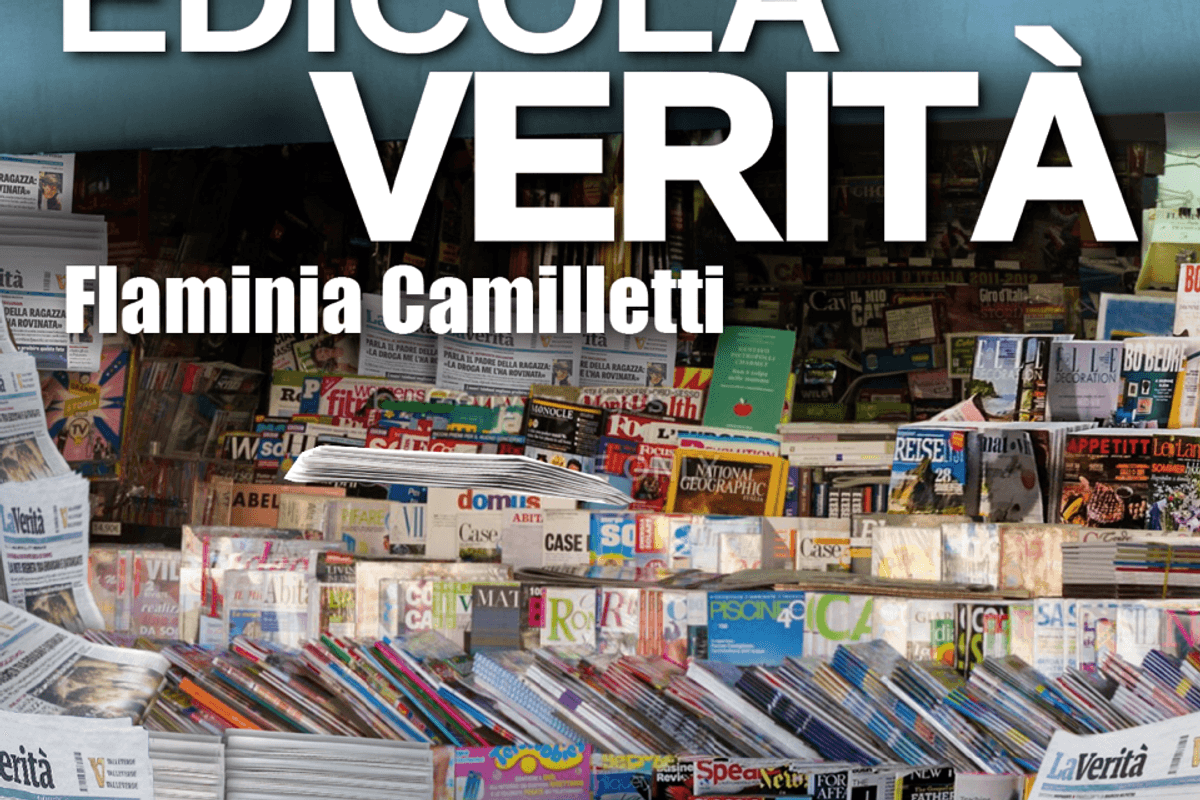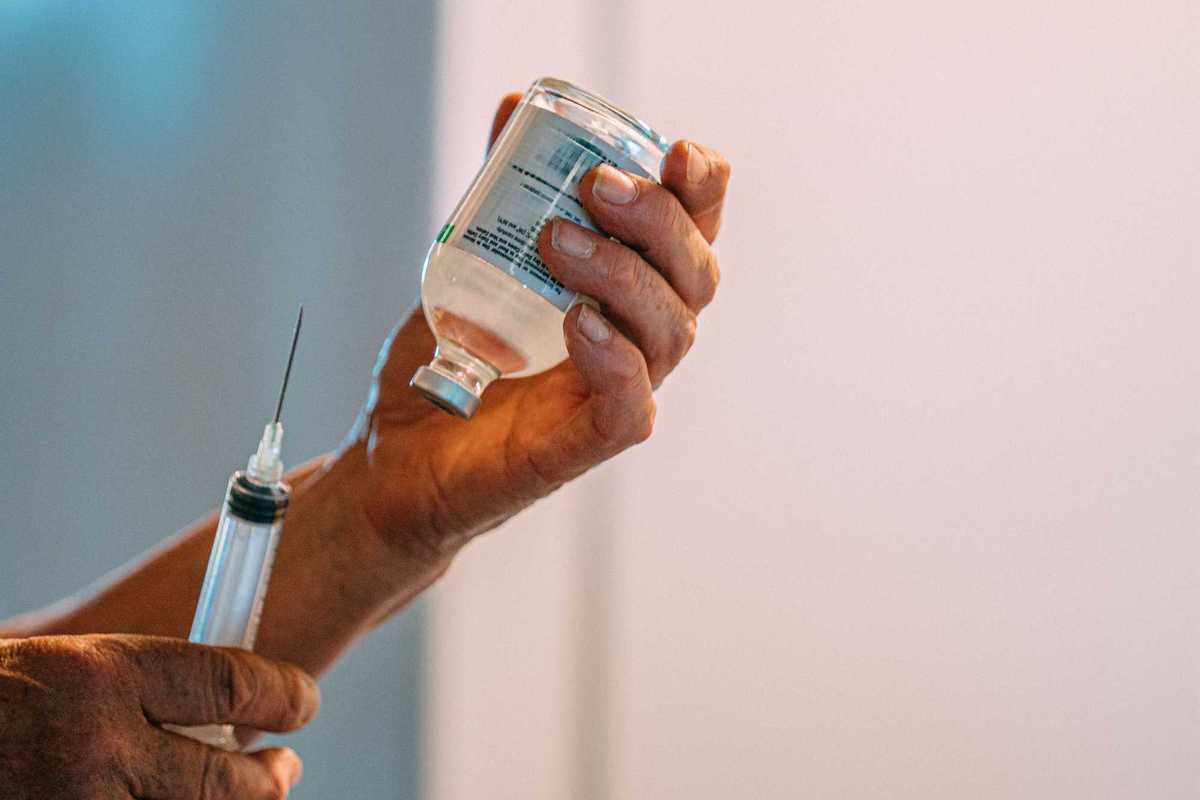Ma dov’è che si corre maggiormente il rischio di contagiarsi? E cosa si sarebbe potuto fare in concreto per ridurre le probabilità di contagio in quei contesti? A queste domande - che ognuno di noi si è posto mille volte - ha provato a dare una risposta rigorosa un documentatissimo studio di Mario Menichella, divulgatore scientifico impegnato con la Fondazione David Hume (www.fondazionehume.it), guidata da Luca Ricolfi.
Menichella fa subito una premessa decisiva: il punto cruciale è la «gravità della malattia che il contagiato svilupperà», che - spiega l’autore del paper - «è legata (a parità di altri fattori come ad esempio l’età e le condizioni della persona) alla “dose” di virus assorbita, in particolare tramite la respirazione». E così si arriva alla domanda delle domande: «Dove rischio di prendermi la forma più grave?».
Con ammirevole onestà intellettuale, Menichella ci fa sapere che la letteratura scientifica su questi temi è scarsa: ci sono studi su singoli luoghi (autobus, per esempio), ma pochi confronti quantitativi tra un luogo e l’altro.
Uno studio a cui Menichella dedica particolare attenzione è comparso sulla rivista Nature a gennaio a proposito dei cosiddetti «luoghi superdiffusori». E cosa viene fuori? È fondamentale «ridurre la massima occupazione di un ambiente» (mezzo di trasporto, supermercato, ecc): fare questo, ad esempio nella misura di un 20%, può portare a una riduzione del numero di infezioni fino all’80%. Sembra intuitivo, perfino banale. Eppure, chiosa Menichella, «è l’opposto di quanto si è fatto in Italia, dove i centri commerciali sono stati chiusi nei weekend, le corse degli autobus sono state ridotte con la chiusura delle scuole, invece di ridurre al minimo il tasso di occupazione consentito al chiuso e aumentare al massimo orari di apertura e corse». Menichella è chirurgico nel trarre una conclusione logica: «L’impatto economico dei lockdown in Italia è stato devastante», mentre «limitare l’occupazione massima avrebbe consentito di mitigare quest’impatto tutt’altro che secondario e di non dover chiudere per mesi intere attività in modo indiscriminato, come invece è stato fatto».
Una sezione importante del lavoro di Menichella è poi dedicata a uno strumento decisivo per difendersi: l’importanza di un ricambio d’aria elevato. Ad esempio, annota l’autore del paper, «una ricerca dell’Arpa Piemonte […] ha confermato una minore presenza del virus negli ospedali e nei luoghi al chiuso dove il sistema di areazione funziona alla perfezione».
In sostanza, dice lo studio della Fondazione Hume, tra i punti di diffusione, «nettamente ai primi due posti si trovano la casa (in quanto lì non si usano le mascherine) e l’ospedale (in quanto vi è un’alta densità di infetti Covid, spesso anche quando fuori di esso il numero è basso)».
Ma attenzione: «Se nell’ospedale c’è un tasso di ricambio d’aria elevato, il virus circola meno».
E non è paradossale ma logico, purtroppo, il fatto che sovente «a casa o in ospedale una persona sana si contagi più facilmente», e che «spesso le conseguenze su intere famiglie siano letali. In questi ambienti, si ha infatti il cosiddetto “reinoculo” del virus, che ne facilita il prevalere sul sistema immunitario».
E allora la classifica, se possiamo usare impropriamente questo termine, vede in testa (staccatissime rispetto agli altri luoghi) case e ospedali, seguiti da aule scolastiche e metropolitane.
Quanto alle aule, sono a rischio «a causa dell’assenza di ricambio d’aria continuo». Per questo, la Fondazione Hume insisteva da mesi, purtroppo inascoltata come La Verità, per «la necessità di avere, in ogni aula scolastica, un sistema di Ventilazione Meccanica Controllata». Ma, com’è noto, i decisori politici hanno preferito dedicarsi ai banchi a rotelle.
Veniamo ai mezzi di trasporto, metropolitane in testa. Queste ultime sono particolarmente pericolose non solo per ragioni ovvie (tasso di occupazione alto), ma anche per un altro motivo: «Il ruolo principale della metropolitana nel diffondere i contagi - scrive Menichella - non sta tanto nel numero di contagi che vi avvengono a bordo […], quanto per il fatto che quei […] contagi mettono in contatto cerchie in cui il virus era presente con cerchie in cui non lo era ancora». È un po’ come se, appiccato il fuoco in un punto del bosco, il vento spargesse dei tizzoni ardenti in giro e a grande distanza [… bruciando più rapidamente il bosco».
Dunque, torna decisivo il tema della riduzione dell’occupazione massima consentita. Altro che lockdown, pensando al 2020. E altro che green pass, pensando ai giorni nostri. Meglio ridurre il tasso di occupazione di un luogo che impedire o restringere gli accessi a molti luoghi. «Si noti - aggiunge Menichella - che in Italia si è andati invece addirittura nella direzione opposta, poiché con il coprifuoco praticato nel periodo più critico della pandemia si è spinto al massimo il tasso di occupazione delle metro nelle fasce serali, dato che le persone dopo cena dovevano rincasare presto per evitare la multa».
Unica buona notizia: «Il contagio outdoor» è «un problema trascurabile»: «la probabilità di trasmissione indoor è circa 20 volte maggiore rispetto a quella outdoor, per cui all’aperto si può stare senza mascherina senza correre rischi particolari, se si sta a qualche metro da altri (ma il governo italiano, anche in questo caso, è andato proprio nella direzione opposta!)», conclude Menichella.