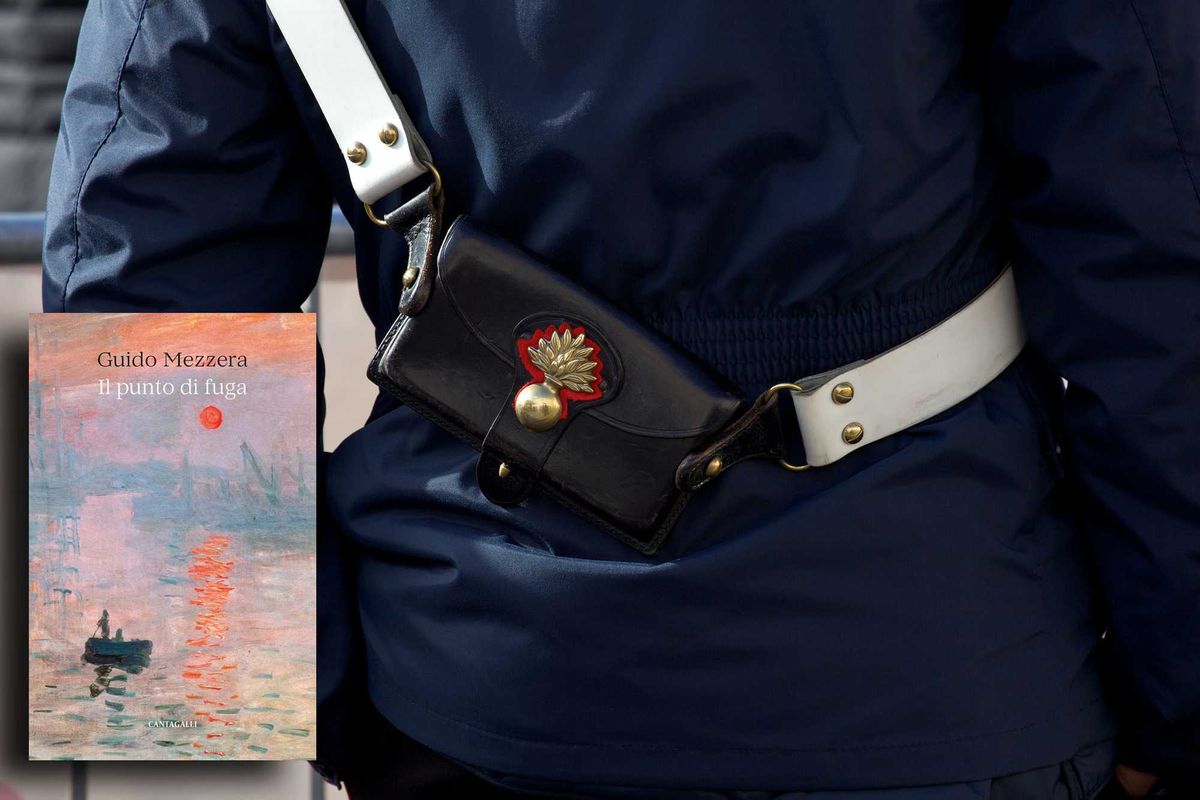Ci sono delle piccole Cenerentole che hanno tutte le caratteristiche per diventare curiose scoperte una volta che, a tavola, ne conoscete la storia. Una di queste potrebbe essere la casatella trevigiana dop. Così la descrive il presidente del Consorzio di tutela, Lorenzo Brugnera: «Nonostante la lunga tradizione è un prodotto ancora molto “nuovo” che merita di essere conosciuto a livello nazionale, per apprezzarne le diverse qualità».
Cominciamo dal medagliere. È una delle otto Dop casearie del Veneto, assieme a blasoni riconosciuti quali Asiago, Grana padano, taleggio. Tra i formaggi a pasta morbida, è stato il primo a ottenere la Dop a livello nazionale, nel 2008. L’altro, il romagnolo squacquerone, che ha avuto tra i suoi testimonial un certo Tonino Guerra, lo sceneggiatore di Federico Fellini, è arrivato dopo, nel 2010. Riavvolgiamo la pellicola. La casatella è figlia di un’arte domestica tramandata oralmente, laddove erano le donne di casa a gestire la cabina di regia della civiltà contadina. Mentre i mariti erano al pascolo o in altre faccende affaccendati, loro, dopo aver munto la vacca che ruminava, spesso solitaria nella stalla, provvedevano (anche) alla lavorazione del latte. Ne descrive bene i passaggi Ottorino Sottana, in un suo scritto del 1977. «Ogni mattina la massaia, con uno scopino di saggina, filtrava il latte, raccogliendo il cao, cioè lo strato superficiale del latte formatosi nella notte, ovvero la panna, depositandolo nel fiasco o nella zangola (un recipiente di legno a forma tronco conica) dove questo veniva sbattuto così da dare il burro. Si ottenevano dei panettini, a volte decorati usando un cucchiaio per lasciare un piccolo tocco personale, che venivano poi portati nella bottega, spesso come merce di scambio con altri generi alimentari. Poteva capitare che, a volte, il latte per la necessaria lavorazione quotidiana non bastasse e allora si andava dal vicino per una “prestanza”, una prassi alla base della solidarietà sociale del tempo. Prestiti sull’onore, ricambiati quanto prima. Al latte avanzato dalla lavorazione del burro si aggiungeva il conaio, ovvero il caglio. Il tempo che coagulasse e lo si calcava in una cassetta cilindrica detta forma così da separare la caseina dal siero detto scoro. Si otteneva un prodotto che poi veniva messo sui davanzali del granaio in attesa che asciugasse». Anche se, spesso, la tradotta in cucina, e quindi al piatto, avveniva prima che il tutto andasse a compimento, pappato assieme alla polenta abbrustolita o al pane quando c’era.
Era questa la «casata», cioè il formaggio di casa, di forme e pesi variabili, tanto da essere chiamato casatella quando di pochi etti. Ma la filiera casearia non terminava qui. «Con lo scoro avanzato dalla casata si otteneva la puina, ovvero la ricotta e il rimasto finiva nel trogolo del maiale». Una triangolazione virtuosa, all’insegna del non si butta via niente. Dalla stalla al porcile passando per la cucina.
Quella descritta da Sottana e, prima di lui, da Ottorino Milesi nel 1961, era una procedura le cui prime tracce risalgono al XVII secolo e che sono rimaste tali fino alla metà del Novecento. Con lo svilupparsi delle latterie sociali, un po’ alla volta si è prestata più attenzione anche a questa piccola creatura destinata al pronto consumo, non più di due settimane dalla sua maturazione. Se un tempo la casatella migliore era quella prodotta nel periodo invernale, con le vacche alimentate dal foraggio secco e, quindi, produttrici di un latte più grasso, ora, grazie alla meccanizzazione di tutta la filiera produttiva, la casatella ha iniziato a diventare realtà disponibile tutto l’anno. Era conseguente, pertanto, ottimizzare un prodotto che poteva uscire dalla pura dimensione domestica e diventare un’altra delle buone tradizioni legate al territorio, considerato l’evolversi del consumo con una maggiore attenzione per i formaggi molli a pasta cruda, compreso il loro positivo aspetto dietetico. Qualità e sostanza, senza eccessivi pedaggi calorici.
Il 19 febbraio del 2001 nasce il Consorzio di tutela per opera di tredici pionieri, tra caseifici e latterie sociali. Si mette a punto un disciplinare di produzione con l’obiettivo di «far riscoprire sapori e aromi di un prodotto legato alla tradizione rurale del Trevigiano». Nel 2006 il ministero delle Politiche agricole approva la disciplinare che porterà poi, nel 2008, a ottenere il prestigioso riconoscimento Dop (e poi Igp), il primo a livello nazionale per un formaggio fresco a pasta molle. Non vacche qualsiasi, ma quelle tradizionalmente allevate sul posto: frisona, pezzata rossa e bruna, la piccola burlina e i loro incroci. L’alimentazione deve avvenire con fieni e pascoli dell’area trevigiana, così da ottenere una flora microbica locale (streptococchi e lattobacilli) che, oltre a garantire salubrità del prodotto, contribuiscono a caratterizzarne le proprietà organolettiche.
La trasformazione del latte deve avvenire entro 48 ore con una attenta procedura di lavorazione della cagliata sì da portare a un lento e naturale spurgo del siero che è un altro dei segreti della sua personalità, garantendo una naturale compattezza e struttura alla forma finale. Anche la salatura segue una procedura più lenta rispetto ad altri formaggi a pasta morbida con un risultato finale che porta a un originale equilibrio tra consistenza e retrogusti dolci e salati, così da rendere la casatella trevigiana di un eclettismo tutto da scoprire una volta giunta a tavola, sdoganandola da quelle ataviche necessità che la vedevano limitata ad abbinarsi a pane o polenta.
Scorrendone i ricettari che le sono stati dedicati sembra quasi che sia lei, piccola Cenerentola tutta da scoprire, che sussurri al cuoco di turno «Abbinami con l’ingrediente giusto e ti stupirò». Dopo un primo ricettario sviluppato dal Consorzio in collaborazione con l’Alberghiero Maffioli di Castelfranco Veneto, coordinato dal bravo Marco Valletta, la casatella trevigiana e stata proposta in svariate ricette. Recentemente, con il patrocinio del ministero delle Politiche agricole, la casatella è stata «riletta» anche da cuochi di varie Regioni d’Italia, a testimonianza della sua versatilità. Come stuzzichino ci sta «in carrozza» a sostituire degnamente la mozzarella, da sola o in abbinata al prosciutto. E così pure a farcire i fiori di zucchina fritti in pastella. C’è pure la firma dei cuochi stellati, dall’altoatesino Herbert Hintner dello Zur Rose di San Michele Appiano, che la propone con il risotto al radicchio rosso di Treviso e speck, al bravo Alessandro Breda del Gellius di Oderzo, in abbinata con ravioli e alici. Casatella senza frontiere con le alici di Cetara, in Campania, ma anche con la cipolla di Tropea e il suino nero in Calabria. E poi in lambada casearia con degni cugini, dal pecorino romano al seirass valdostano. Per il dolce, non c’è storia: non fa rimpiangere il mascarpone in un originale tiramisù con torchiato di Fregona (un vino passito) e sbrisolona su salsa al cioccolato. Molti pizzaioli sono apripista nel proporla al posto della mozzarella.
Una casatella che, come ricorda il presidente Brugnera, pur avendo raggiunto una produzione di degno rispetto, 680.000 forme all’anno, è ancora poco conosciuta al di fuori dei confini provinciali (a Treviso il 30% del consumo) e regionali (60%), ma che ha tutte le caratteristiche per ottenere il suo meritato posto al sole. Nel frattempo, da piccola Cenerentola, è cresciuta di grado. Fin dal 2008, dopo il riconoscimento della Dop, è stata affiancata alla prestigiosa rassegna del Radicchio d’oro che si tiene ogni anno nel Trevigiano a cura dell’apposito consorzio, con premi che riconoscono eccellenze di vari settori a livello nazionale, consegnati da una madrina quale Miss Italia.