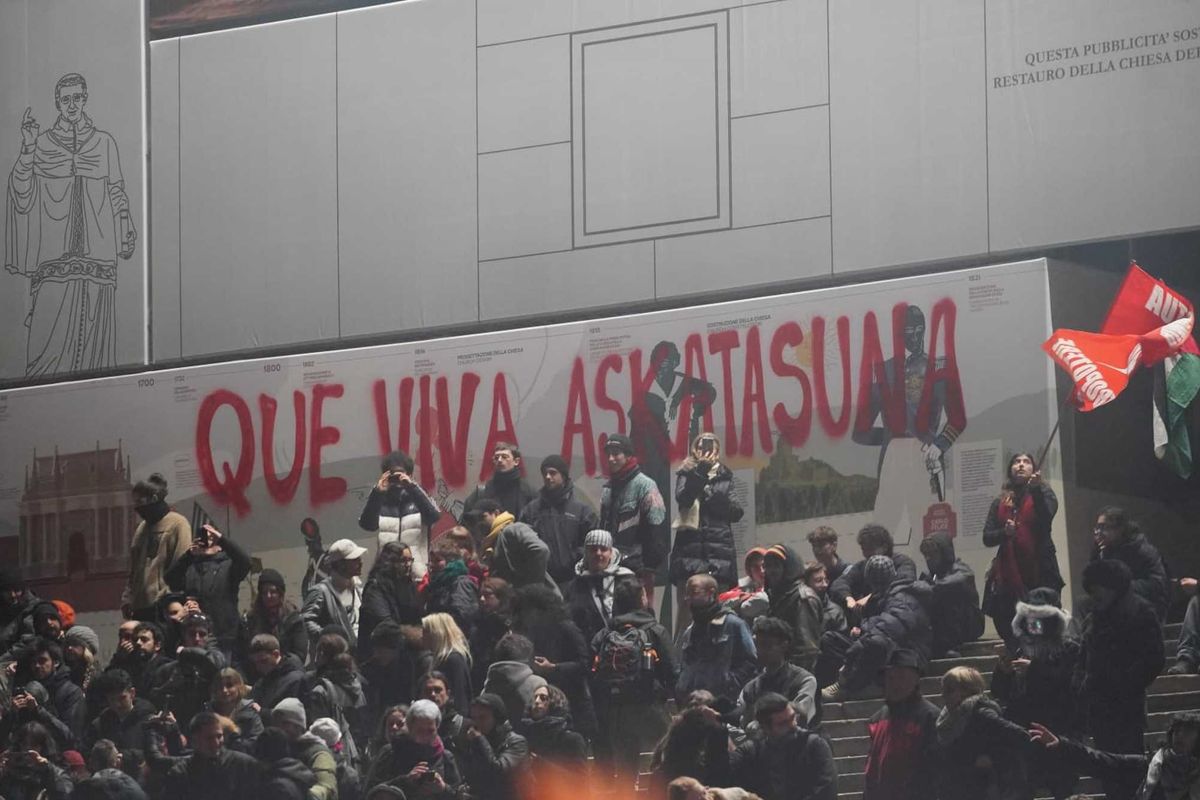Che il settore dell’accoglienza, nel nostro Paese, sia un business gestito da imprese in forma cooperativa è un dato di fatto. E, certamente, non fa eccezione l’accoglienza dei minori allontanati dalle famiglie di origine per gravi motivi e collocati dai Tribunali, in emergenza, nelle «comunità educative» o «case famiglia» che dir si voglia.
Al netto dei minori stranieri non accompagnati (che sono un ramo di attività a parte), il giro d’affari del settore è stimato in oltre 1 miliardo all’anno: più di 23.000 minori da spartirsi, con rette (pagate dallo stato) che variano dai 100 ai 120 euro al giorno e con una «permanenza minima garantita» di circa un triennio. E, il tutto, senza nemmeno un registro che tenga le fila di questi numeri enormi o qualcuno che conosca precisamente quantità e qualità dei servizi offerti.
È a questo assurdo vulnus (perché di bambini rimasti senza famiglia stiamo parlando) che il disegno di legge 1694, presentato dal ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella, e dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sta provando a rimediare. Con passi piccoli va detto - leggendo il testo si capisce bene quanto una riforma del sistema affido familiare sia ancora lontana - ma, comunque costruendo un punto fermo da cui partire.
L’idea di base della proposta, passata lo scorso 21 ottobre al vaglio della Camera, è «monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo» e soprattutto «prevenire e ridurre situazioni di collocamento improprio presso istituti» attraverso la creazione di un «registro e di un osservatorio nazionale di tutte le strutture attive sul territorio».
Il minimo sindacale in un tale mare magnum, penserete, e invece no. Anche su una proposta tanto semplice, in aula alla Camera, il Pd (storicamente il partito più rappresentativo in termini di cooperative di accoglienza) ha deciso, prudentemente, di astenersi: meglio non accollarsi responsabilità su un passaggio legislativo che, nella sua applicazione, potrebbe finire per destabilizzare una situazione così ben consolidata.
Il disegno di legge, infatti, vuole tenere monitorato l’andamento delle permanenze dei piccoli ospiti nelle varie strutture perché, ormai da decenni, i tempi medi vanno ben oltre quelli previsti dalla legge 184 del 1983, che indicava la struttura residenziale come una «extrema ratio» assolutamente «temporanea» da usare al massimo «per alcuni mesi».
Anche se, appunto, di dati precisi non ce ne sono si stima che, in media, i bambini allontanati dalla famiglia d’origine spesso con decreto d’urgenza, restino poi nelle comunità almeno tre anni prima di tornare a casa o trovare un’altra (vera) famiglia. Ci sono casi in cui gli anni diventano ben di più e molti ragazzi raggiungono addirittura la maggiore età senza mai uscirne.
Fatiche burocratiche, lungaggini giudiziarie, poco personale, difficoltà a individuare famiglie affidatarie: queste sono le motivazioni ufficiali dei tribunali e dei servizi che si occupano dei minori per giustificare la situazione. «Un business sulla pelle dei bambini», l’aveva invece definita il ministro Matteo Salvini, quando l’uragano Bibbiano prometteva di scavare a fondo in un sistema nazionale, ancora oggi, pieno di ombre. Vedremo se l’osservatorio voluto dal ddl Roccella ci riuscirà.
Tornando ai numeri: i rapporti ministeriali del 2023 parlano di 33.200 minorenni in situazione di «affidamento», senza distinguere tra quelli collocati in strutture residenziali o nelle famiglie affidatarie, mentre l’autorità garante dell’Infanzia di questi ne conta 23.000 collocati in comunità. Le strutture di accoglienza sarebbero - ma il dato è ipotetico perché appunto non esiste un registro - circa 3.600 sul territorio nazionale e le regioni più fornite risultano essere: Piemonte, Lazio, Puglia, Campania e, nemmeno a dirlo, Lomardia ed Emilia Romagna.
Il comprensorio di Bologna, che ha raccolto un report locale, conta 43 strutture attive dedicate ai più piccoli, tra pronta accoglienza, comunità familiari e case famiglia, mentre a Roma le strutture sono 55. I contributi, erogati dai Comuni con apposite delibere, si aggirano tra i 100 euro e i 120 euro al giorno per ospite, a cui vanno aggiunte erogazioni diverse per servizi particolari per un totale che supera il miliardo all’anno.
«Se hai pensato di aprire una casa famiglia non solo sei una persona lodevole dal punto di vista umano, ma hai avuto anche una buona idea di business: è un’attività che può risultare economicamente gratificante», recitano i claim che si incrociano in rete scorrendo le pagine dedicate al tema. O, ancor meglio, c’è chi propone «il kit start up», per una «casa famiglia in franchising» con «costi di ingresso trasparenti e fee mensili». Nel frattempo, mentre c’è chi prepara il business plan, in Italia sono circa 8.000 le coppie che hanno dato la loro disponibilità ad adottare un bambino e che, senza che più nessuno si stupisca, aspettano anni in «vigile attesa».