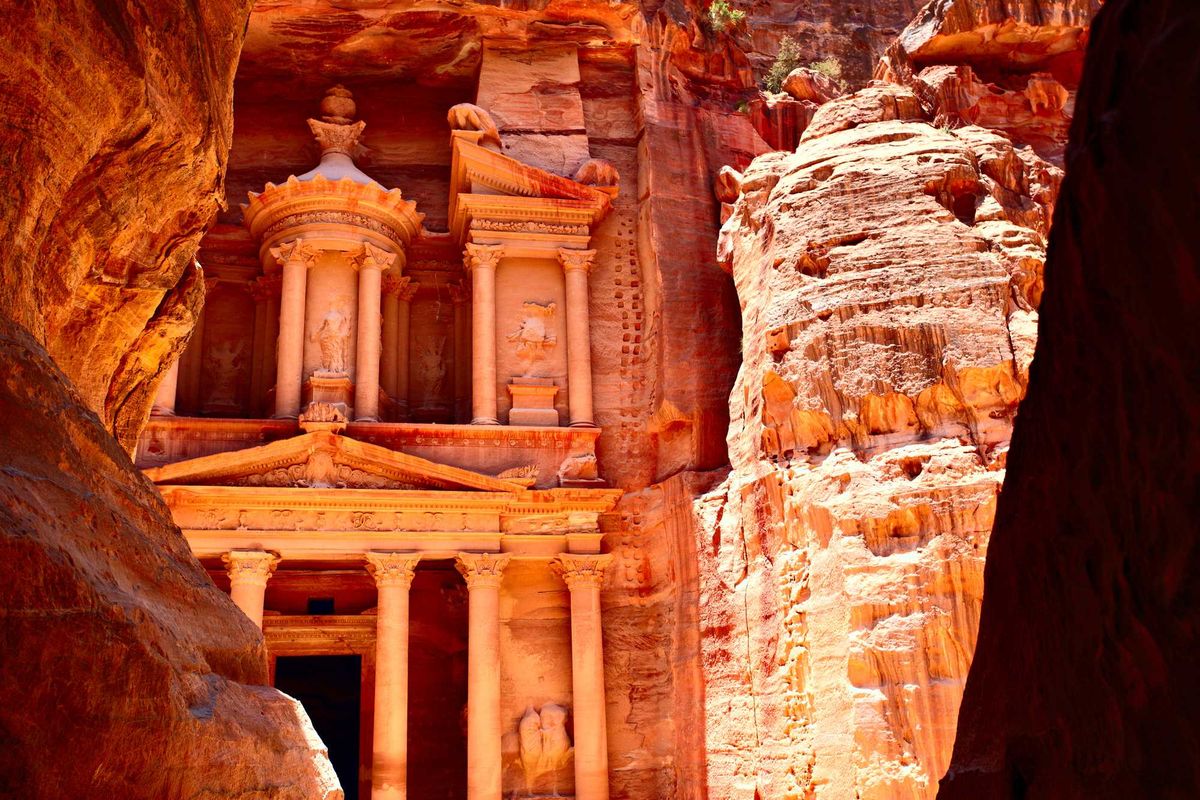E se fosse la Costituzione a smentire i magistrati? Se fosse la Carta fondamentale della nostra Repubblica a dimostrare che non ci si può aggrappare alla sentenza della Corte Ue, per picconare l’accordo con l’Albania sul Centro per i rimpatri?
Partiamo dal riassunto delle puntate precedenti. Il 4 ottobre, i giudici di Strasburgo si pronunciano sul ricorso di un moldavo contro la Repubblica ceca, che lo aveva respinto. Dicono due cose. Primo: la direttiva europea sui richiedenti asilo va interpretata in modo che un Paese non possa essere definito sicuro, a meno che non sia sicuro - cioè «generalmente e costantemente» privo di persecuzioni - l’intero suo territorio. Secondo: al giudice nazionale spetta d’ufficio il compito di verificare che la lista dei Paesi sicuri, redatta dagli Stati membri dell’Unione, rispetti i requisiti indicati dalla Corte stessa, sulla base della famosa direttiva di Bruxelles.
Sul primo punto, la giurista Serena Rossi, ex membro dell’organismo con sede in Francia, ha illustrato al Giornale quale sarebbe stato il fraintendimento dei nostri giudici: essi avrebbero sovrapposto al «criterio geografico» quello delle «categorie di persone perseguitate». Tuttavia, è il secondo punto quello più delicato. La verità, infatti, è che nemmeno il nuovo decreto legge del governo, che eleva il rango della norma contenente l’elenco della discordia, è al riparo dall’intervento dei tribunali. A questi ultimi, come abbiamo visto, Strasburgo attribuisce il compito di controllare ed eventualmente smentire la tabella governativa. Certo: essi dovranno argomentare, volta per volta, perché un Paese che Roma reputa sicuro non vada invece considerato tale. L’esecutivo, poi, potrà impugnare i provvedimenti che non condivide anche in Appello. Ma siccome nel Cpr di Gjadër, in virtù del protocollo firmato con Edi Rama, possono stare soltanto i migranti sottoposti a procedure accelerate di rimpatrio nelle nazioni in cui non ci sono guerre né soprusi ricorrenti, per rovinare il gioiellino geopolitico di Giorgia Meloni basterà impugnare la clava che la Corte Ue ha cortesemente fornito.
Il problema è che persino la Consulta e, a cascata, tutti gli organismi giurisdizionali, hanno ormai giurato fedeltà al dogma del primato del diritto comunitario. Si appellano all’articolo 11, nel quale vengono ammesse «limitazioni di sovranità», collegate all’adesione a «organizzazioni internazionali». La primazia del diritto unionale europeo, comunque, dovrebbe trovare un argine nella Costituzione stessa: in parole povere, se la norma Ue è in contrasto con la Carta, non sarebbe più così pacifico che si debba privilegiare la disposizione di Bruxelles. Così facendo, anzi, si invaliderebbe il dettato costituzionale.
Perché questo è un aspetto centrale? Perché la sentenza della Corte di Strasburgo assegna ai magistrati l’ultima parola su una materia che, da Costituzione, spetta a chi esercita la funzione di varare le leggi. Lo specifica il Titolo V, all’articolo 117: «Lo Stato ha legislazione esclusiva» in ambito di «politica estera», «rapporti dello Stato con l’Unione europea», «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea», «immigrazione», oltre che «sicurezza dello Stato» stesso e «ordine pubblico». Stabilire se un Paese terzo sia o meno sicuro non è affare di politica estera? Di rapporti diplomatici con gli Stati extra Ue? Di immigrazione e asilo? Financo di sicurezza e ordine pubblico, dal momento che l’invasione degli stranieri ha un impatto sui reati che destano maggiore allarme sociale?
Un conto è riconoscere al magistrato la facoltà di esaminare, caso per caso, se i diritti inalienabili del singolo immigrato siano stati rispettati; un conto è sostituire il suo arbitrio a una decisione che in primis la Carta assegna alla politica. Può accadere che un bengalese, a casa sua, sia entrato in rotta con un clan mafioso e che rimpatriarlo lo esponga al pericolo di essere assassinato. Diverso è se un tribunale stabilisce di propria iniziativa che in Bangladesh si abusa sistematicamente di oppositori, sindacalisti e gay e che, dunque, il governo ha fatto male a inserirlo nella lista dei Paesi sicuri. Significherebbe attribuire al magistrato non semplicemente la possibilità di difendere i diritti di un vulnerabile, bensì la «funzione legislativa» che la Costituzione riconosce al Parlamento e al governo, nella misura in cui l’esecutivo può emettere decreti legge o essere delegato dalle Camere a legiferare.
D’altra parte, pure quella di rendere il diritto Ue preminente è stata una decisione politica, non desumibile da alcun automatismo tecnico-giuridico, al contrario di ciò che crede qualche trombettiere dell’europeismo. Ancor più controverso è che la versione «ufficiale» del diritto comunitario debba essere quella identificata dalla Corte di Strasburgo. La quale, alla stregua della Corte Suprema americana nel 1803, fin dagli anni Sessanta (caso Costa contro Enel) si è investita da sola di tale potere. Quasi come se, nel Vecchio continente, vigesse una sorta di common law, di cui imporre l’esegesi. Per carità, pure in Italia le sentenze della Cassazione fanno giurisprudenza. Ma la cosiddetta «funzione nomofilattica» è stata conferita agli ermellini da una legge. La Corte Ue è stata, sì, istituita tramite i trattati; però nessuna legge le riconosce esplicitamente quel ruolo da oracolo di Delfi. Altrimenti non si spiegherebbe per quale motivo, a parità di accordi internazionali esistenti, la Germania sottoponga allo scrutinio della sua Consulta direttive e regolamenti dell’Unione; la Polonia abbia sancito il primato della Costituzione nazionale; e, almeno in materia migratoria, la Francia snobbi i verdetti delle toghe di Strasburgo, mentre la Spagna pratichi respingimenti di massa senza nemmeno identificare i clandestini, approfittando del via libera che le ha dato la propria Corte costituzionale. Alla faccia di Strasburgo.
Purtroppo, pure riaffermare la sovranità della Costituzione presuppone una volontà politica. Ma per la nostra magistratura, al momento, una sola cosa conta di più del diritto europeo: fare un dispetto alla Meloni.