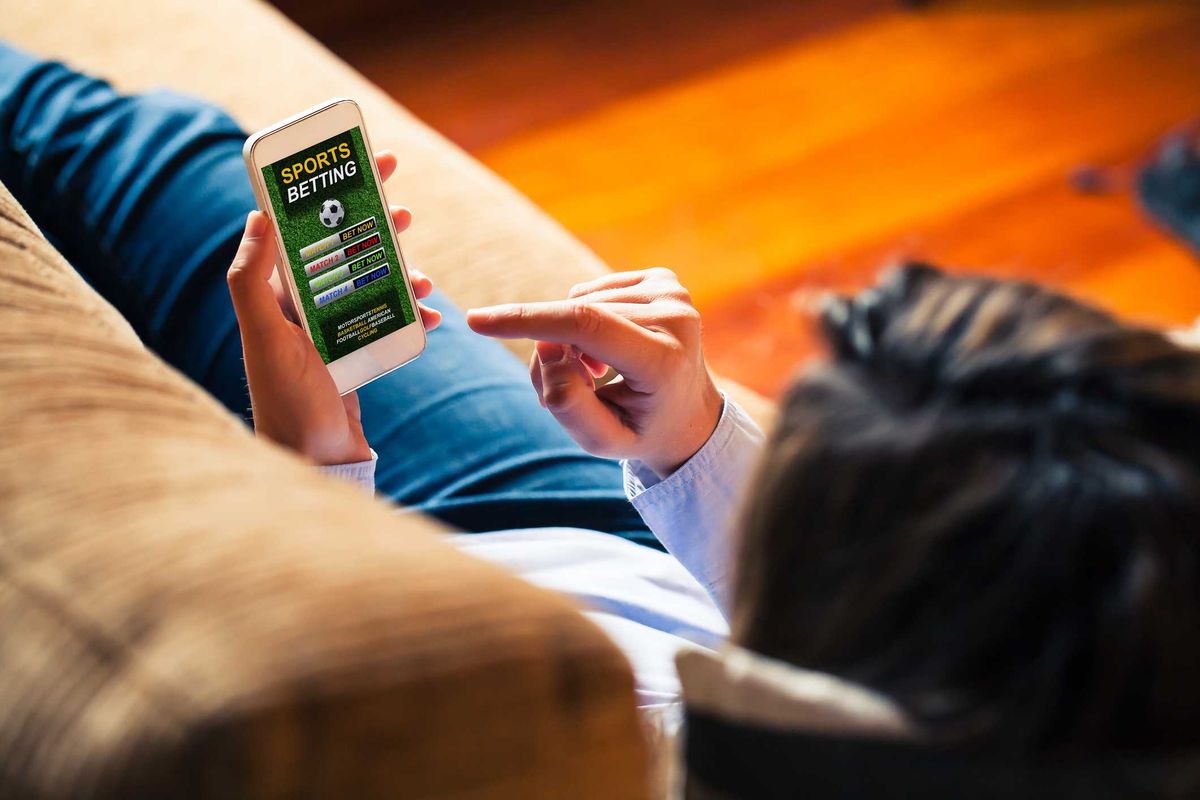Un piano delle Fs porterà a restaurare la metà di 357 mezzi in disarmo e 18 linee chiuse. Le ex stazioni diventeranno musei.La locomotiva a vapore di fabbricazione inglese, costruita nelle officine Londridge e Starbuk di Newcastle che, con la denominazione Vesuvio, trainò le sette carrozze del convoglio viaggiante sulla tratta Napoli-Portici, la prima linea ferroviaria costruita in Italia, nel giorno dell'inaugurazione, il 3 ottobre 1839, raggiunse la velocità massima di 50 chilometri orari e percorse il tragitto, di 7,25 chilometri, in 9,5 minuti. L'elettrotreno Etr 400, o Frecciarossa 1000, prodotto dal consorzio Ansaldo Breda-Bombardier, in servizio nella flotta di Trenitalia dal 2005, dotato di 16 motori e di sistema di «diagnostica predittiva» per garantire la sicurezza, è in grado di raggiungere i 300 chilometri all'ora in 4 minuti e di lambire i 400, coprendo, salvo problemi tecnici, la distanza da Roma a Milano in 2,20 ore. Tra questi due estremi, frutto dell'evoluzione tecnologica di quasi due secoli, l'albero che compone la rete delle strade ferrate nella nazione, vuoi per ragioni di competizione con altri hub del sistema di trasporto di passeggeri e merci - ci riferiamo alla rete stradale e autostradale, ma anche ai collegamenti aerei - vuoi per pianificazioni dirette ad aumentare efficienza e introiti, ha perso vari rami, definiti fatalmente «secchi», non solo per episodica carenza di passeggeri, ma soprattutto perché soccombenti nei confronti degli imparagonabili realizzi dei collegamenti principali, sui quali si stanno concentrando i maggiori investimenti attraverso quei treni super-veloci che fanno arrossire regionali vari e littorine. L'esito della potatura ha lasciato circa 7.000 chilometri di tratte dismesse e inutilizzate, di proprietà del gruppo Ferrovie dello Stato e di altri enti, oppure dati in concessione da Fs a gestori vari, con il loro armamentario di ex stazioni, caselli, magazzini, rotaie e vecchie insegne dimenticate che richiamano suggestioni da epopea del west americano con pizzichi di chitarra di Ry Cooder. Si tratta di un patrimonio sterminato di archeologia delle strade ferrate, dove vari infiniti s'intrecciano, siano essi lo schema elettrico di una locomotiva E320 delle Fs, in esercizio dal 1930 al 1983, oppure tutto ciò che evocano i sognatori, passeggeri su sedili di legno o vin-pelle che osservano nei finestrini paesaggi in dissipazione, incontri, pensieri del giorno o di una vita, avventure di ogni tipo. Dal 2013, quando l'allora amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti volle la costituzione di un organismo - Fondazione Fs - con il fine di evitare che questo capitale di infrastrutture e di mezzi finisse nell'oblio, ha battezzato un piano che ha portato al recupero di 9 linee chiuse, al restauro di oltre il 50 per cento dei 357 mezzi ferroviari in disarmo di proprietà della stessa Fondazione, e all'attivazione di corse turistiche con le vecchie motrici e i vagoni old fashion. Così 25 locomotive a vapore - delle quali, la più antica è del 1905 - sono tornate a sfrecciare insieme a mezzi più recenti, come le littorine Aln 668 degli anni del boom economico, e l'Etr 302, chiamato più simpaticamente Settebello, simbolo della rinascita economica dopo la seconda guerra mondiale, oggi treno turistico di lusso in grado di raggiungere i 160 chilometri all'ora. Le 9 linee recuperate da Fondazione Fs, sparse nella penisola, disponibili per viaggi alla ricerca di ricordi antichi, sono la Palazzolo sull'Oglio-Paratico, nel Bresciano, che costeggia in alcuni tratti il fiume Oglio e ne solca il parco naturale, la ferrovia della Val D'Orcia, da Asciano a Monte Antico, in Toscana, fra borghi, olivi, vigne, chianine al pascolo e crete senesi, la Sulmona-Carpinone-Isernia, soprannominata Transiberiana d'Italia, che raggiunge il Molise sulla via degli altipiani abruzzesi, facendo tappa nella stazione altimetricamente più elevata del Paese, dopo il Brennero. Quindi la Rivisondoli-Pescocostanzo, a 1.268 metri d'altitudine e la Agrigento Bassa-Porto Empedocle, 10 chilometri di strada ferrata che solcano la Valle dei Templi, in Sicilia. E ancora la Ceva-Ormea, in provincia di Cuneo, nell'alta valle del Tanaro, la Novara-Varallo in Valsesia, la Avellino-Rocchetta Sant'Antonio, che dall'Irpinia si dirige verso la Puglia, la Sacile-Maniago-Gemona, o Pedemontana, in quella parte del Friuli ricostruita dopo il disastro del terremoto del 1976, la ferrovia del Sannio, da Benevento a Campobasso, nota per le frequenti serpentine sul suo tracciato e per il suo mancato obiettivo di costituire una valida alternativa alla Napoli-Foggia. Il prezzo dei biglietti varia da 15 euro per brevi tragitti, a 50 euro, per percorsi di un giorno intero. Nuovi progetti sono sul tavolo per la riqualificazione di altri 9 tracciati ferroviari non più in esercizio, individuati per un riutilizzo per percorsi di convogli storici, anche con il sostegno della legge 128 del 2017 e di un documento, sempre del 2017, del ministero dell'Economia e delle Finanze, che annuncia un possibile finanziamento di 374 milioni di euro, importo del quale, come dichiara la Fondazione Fs, il cui direttore è Luigi Cantamessa, «ancora non si hanno evidenze». Sta di fatto che il processo, per quanto sconti un deficit rispetto agli altri Paesi europei e agli Stati Uniti, è stato innescato e si manifesta anche con iniziative collegate. Come quella della creazione del museo ferroviario di Pietrarsa, a Napoli, che dal 1845 fu la prima fabbrica di locomotive in Italia e la cui vita si concluse nel 1975. Riaperto, dopo una prima inaugurazione, nel dicembre 2007, ha registrato, nel 2017, sempre secondo dati della fondazione, circa 113.000 visitatori. Sembra siano imminenti, ostacoli politico-burocratici e finanziari permettendo, i lavori di ristrutturazione della stazione di Trieste- Campo Marzio, che dovrebbe diventare il secondo museo ferroviario italiano e il punto di partenza di altri treni storici che valicheranno anche i confini alpini, verso l'Austria e la Slovenia. La geografia tecnica delle Ferrovie dello Stato si articola in 10 sedi operative e in 12 impianti di manutenzione dei treni storici di Trenitalia, i maggiori dei quali sono l'ex Squadra rialzo Milano Centrale, specializzata nel restauro di carrozze costruite dal 1921 al 1985, il Deposito rotabili storici di Pistoia, l'unico in grado di ripristinare locomotive a vapore, l'officina di La Spezia Migliarina, dedicato alle locomotive elettriche dal 1928 al 1975.Gran parte delle vecchie ferrovie ritenute obsolete, e quindi chiuse, non saranno rimesse in funzione nemmeno per itinerari con carrozze d'epoca, ma alcune di esse possono diventare greenway, ossia piste ciclabili che seguono gli antichi sedimi, e si snodano tra stazioni in fatiscenza con un immaginario che passa da ricordi minimalisti a scene cinematografiche, come quella del film La stazione di Sergio Rubini del 1990, o del misterioso «sarchiapone» della gag Rai del febbraio 1958, sceneggiata nello scompartimento di un treno, di Walter Chiari e Carlo Campanini. Per il momento, sono stati convertiti a «vie verdi» circa 800 chilometri di linee, ben lontani dai 5.000 della Germania, dai 3.400 della Francia e dai 2.600 della Spagna. I lavori sono in corso. Rfi, Rete ferroviaria italiana (società di Fs), è disponibile a concedere i tracciati in disuso in affitto o comodato, compresi i fabbricati annessi, a enti locali e organizzazioni private e no profit per la riconversione alla mobilità dolce. Le ecopiste attivate sono, per ex-linee Fs, quella del Parco del Ponente Ligure, che segue la costa; la Alpe-Adria sulla ex Pontebbana, da Tarvisio e Resiutta (Udine); quelle su parti sostituite della linea del Brennero, in Trentino; e la Treviso-Ostiglia, costruita tra il 1925 e il 1941, soprattutto per usi militari, e chiusa tra il 1944 e il 1967, che diventerà la più lunga greenway nazionale (115 chilometri) con arrivo in provincia di Mantova. Il tratto Treviso-Grisignano di Zocco è già disponibile, in provincia di Vicenza c'è un progetto e per la parte veronese e mantovana il giovane di Cerea (Verona) Federico Carbonini ha costituito un'associazione per completarla e raccontarne la memoria. Nel riquadro 167 di un orario in vigore dal 15 ottobre 1942, le partenze, su vagoni di seconda e terza classe (la terza classe fu eliminata nel 1975): Ostiglia alle 17 e 20, Aselogna alle 17 e 40, Camposampiero alle 20 e 03, Badoere alle 20 e 33, Treviso alle 20 e 57. Ciascuna di queste stazioni esiste ancora. Anch'esse meriterebbero di essere ristrutturate, come per alcune è avvenuto, da Chiusaforte a Ugovizza, da San Pellegrino Terme e Retorbido, convertite a posti di ristoro, bar e ristoranti per i ciclisti in escursione. Si fa appello alla fantasia, alle idee originali, al crowdfunding, alle sinergie pubblico-privato. È un treno che non va perso.
Nadia e Aimo Moroni
Prima puntata sulla vita di un gigante della cucina italiana, morto un mese fa a 91 anni. È da mamma Nunzia che apprende l’arte di riconoscere a occhio una gallina di qualità. Poi il lavoro a Milano, all’inizio come ambulante e successivamente come lavapiatti.
È mancato serenamente a 91 anni il mese scorso. Aimo Moroni si era ritirato oramai da un po’ di tempo dalla prima linea dei fornelli del locale da lui fondato nel 1962 con la sua Nadia, ovvero «Il luogo di Aimo e Nadia», ora affidato nelle salde mani della figlia Stefania e dei due bravi eredi Fabio Pisani e Alessandro Negrini, ma l’eredità che ha lasciato e la storia, per certi versi unica, del suo impegno e della passione dedicata a valorizzare la cucina italiana, i suoi prodotti e quel mondo di artigiani che, silenziosi, hanno sempre operato dietro le quinte, merita adeguato onore.
Franz Botrè (nel riquadro) e Francesco Florio
Il direttore di «Arbiter» Franz Botrè: «Il trofeo “Su misura” celebra la maestria artigiana e la bellezza del “fatto bene”. Il tema di quest’anno, Winter elegance, grazie alla partnership di Loro Piana porterà lo stile alle Olimpiadi».
C’è un’Italia che continua a credere nella bellezza del tempo speso bene, nel valore dei gesti sapienti e nella perfezione di un punto cucito a mano. È l’Italia della sartoria, un’eccellenza che Arbiter celebra da sempre come forma d’arte, cultura e stile di vita. In questo spirito nasce il «Su misura - Trofeo Arbiter», il premio ideato da Franz Botrè, direttore della storica rivista, giunto alla quinta edizione, vinta quest’anno da Francesco Florio della Sartoria Florio di Parigi mentre Hanna Bond, dell’atelier Norton & Sons di Londra, si è aggiudicata lo Spillo d’Oro, assegnato dagli studenti del Master in fashion & luxury management dell’università Bocconi. Un appuntamento, quello del trofeo, che riunisce i migliori maestri sarti italiani e internazionali, protagonisti di una competizione che è prima di tutto un omaggio al mestiere, alla passione e alla capacità di trasformare il tessuto in emozione. Il tema scelto per questa edizione, «Winter elegance», richiama l’eleganza invernale e rende tributo ai prossimi Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, unendo sport, stile e territorio in un’unica narrazione di eccellenza. A firmare la partnership, un nome che è sinonimo di qualità assoluta: Loro Piana, simbolo di lusso discreto e artigianalità senza tempo. Con Franz Botrè abbiamo parlato delle origini del premio, del significato profondo della sartoria su misura e di come, in un mondo dominato dalla velocità, l’abito del sarto resti l’emblema di un’eleganza autentica e duratura.
iStock
A rischiare di cadere nella trappola dei «nuovi» vizi anche i bambini di dieci anni.
Dopo quattro anni dalla precedente edizione, che si era tenuta in forma ridotta a causa della pandemia Covid, si è svolta a Roma la VII Conferenza nazionale sulle dipendenze, che ha visto la numerosa partecipazione dei soggetti, pubblici e privati del terzo settore, che operano nel campo non solo delle tossicodipendenze da stupefacenti, ma anche nel campo di quelle che potremmo definire le «nuove dipendenze»: da condotte e comportamenti, legate all’abuso di internet, con giochi online (gaming), gioco d’azzardo patologico (gambling), che richiedono un’attenzione speciale per i comportamenti a rischio dei giovani e giovanissimi (10/13 anni!). In ordine alla tossicodipendenza, il messaggio unanime degli operatori sul campo è stato molto chiaro e forte: non esistono droghe leggere!
Messi in campo dell’esecutivo 165 milioni nella lotta agli stupefacenti. Meloni: «È una sfida prioritaria e un lavoro di squadra». Tra le misure varate, pure la possibilità di destinare l’8 per mille alle attività di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti.
Il governo raddoppia sforzi e risorse nella lotta contro le dipendenze. «Dal 2024 al 2025 l’investimento economico è raddoppiato, toccando quota 165 milioni di euro» ha spiegato il premier Giorgia Meloni in occasione dell’apertura dei lavori del VII Conferenza nazionale sulle dipendenze organizzata dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui Meloni ha rivolto i suoi sentiti ringraziamenti, il premier ha spiegato che quella contro le dipendenze è una sfida che lo Stato italiano considera prioritaria». Lo dimostra il fatto che «in questi tre anni non ci siamo limitati a stanziare più risorse, ci siamo preoccupati di costruire un nuovo metodo di lavoro fondato sul confronto e sulla condivisione delle responsabilità. Lo abbiamo fatto perché siamo consapevoli che il lavoro riesce solo se è di squadra».