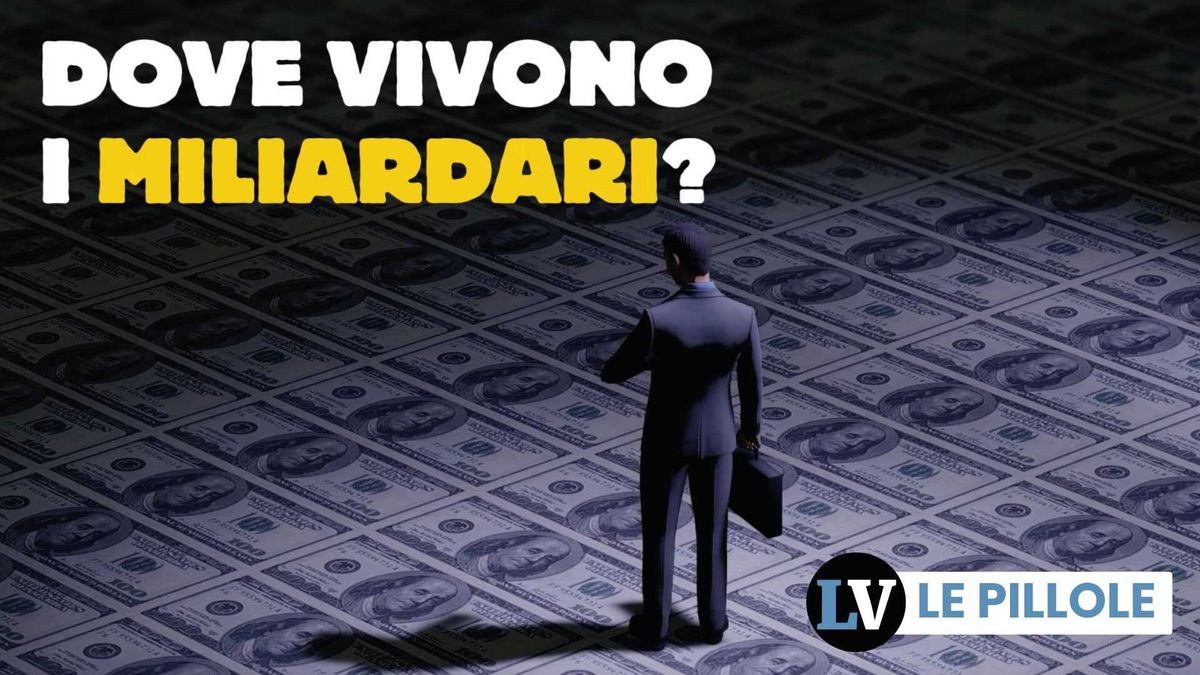Caro Matteo Bassetti, le scrivo questa cartolina perché vedo che insiste. Dopo aver organizzato rumorose festicciole domestiche, non contento di aver disturbato i vicini (casa di riposo compresa) e di aver scomodato i vigili urbani, non contento neppure di avere messo i vigili alla berlina con un video piuttosto alterato in cui li accusava di «prendersela con i deboli» (deboli come lei?), è tornato all’attacco con l’umiltà che la contraddistingue.
Anziché chiedere scusa, infatti, come avrebbe fatto ogni persona di buon senso, ha rilasciato interviste a raffica, approfittando della sua popolarità, per accusare i vigili di avere «atteggiamenti da sceriffi». Al che ho capito che dovevo esprimerle tutta la mia solidarietà perché lei è davvero debole, come dice. Molto debole. Soprattutto di memoria.
Ora, infatti, lei si dice convinto che i «metodi da sceriffi» non funzionano, e che «funziona di più una pacca sulla spalla». Deve aver dimenticato, evidentemente, quell’altro Bassetti, suo gemello, che diceva «chi non si vaccina lo andrei a prendere a casa» (19 novembre 2021), «buttiamo i non vaccinati fuori da cinema e ristoranti» (6 novembre 2021), «vietiamo le manifestazioni contro il green pass» (8 novembre 2021), «condanne esemplari per i no green pass» (5 aprile 2021) e «radiamo dalla professione i medici non vaccinati» (8 luglio 2021). Diciamocelo: lei ha passato gli ultimi anni della sua vita a invocare «metodi da sceriffi» e adesso scopre che «funziona di più una pacca sulla spalla»? Siccome è debole di memoria, mi permetto di ricordarle quando pubblicò la vignetta in cui auspicava di mandare i no vax ad Auschwitz. Anche se lì, per la verità, più che metodi da sceriffi lei invocava metodi da kapò. Però, ecco, vorrei esprimerle tutta la mia vicinanza perché lei è davvero «debole». Debole di memoria. Debole di coerenza. E debole di serietà. Perciò va capito: non è colpa sua se non si rende conto che le regole, compresa la regola di non dare festini notturni disturbando il vicinato, vanno rispettate. E che se non le si rispetta, si incorre in una sanzione. E se i vigili applicano la sanzione fanno il loro dovere, mica gli sceriffi. Chi ha un po’ di popolarità, per altro, dovrebbe cercare di dare il buon esempio, e se sbaglia dovrebbe chiedere scusa. Ma lei non se rende conto e preferisce autoesaltarsi, accusando il mondo di invidiarla. Come se fosse davvero possibile invidiare uno che negli ultimi anni ha scritto Il mondo è dei microbi e Pinocchi in camice. Due evidenti autobiografie.
Per altro, caro Bassetti, essendo lei davvero debole di memoria non ricorda neanche che quella sua popolarità è stata costruita sui morti e sulle sofferenze altrui. Meriterebbe di essere usata meglio. Purtroppo, lei non ci arriva: da sempre dedito, più che alla ricerca scientifica, alla ricerca della telecamera, non ne ha mai azzeccata una («Il coronavirus? Fuori dalla Cina non è contagioso», 6 febbraio 2020) ma continua a pontificare. Ha dato del rincoglionito a Luc Montagnier, ha definito maghi&fattucchiere i medici che curavano i malati di Covid a casa, anziché mandarli al macello in ospedale, e dopo aver chiesto il coprifuoco per tutti ora attacca i vigili che le chiedono di non fare baccano nel cuore della notte. È folle, ma noi la perdoniamo perché non è colpa sua. È che è lei debole davvero. Pure di comprendonio.