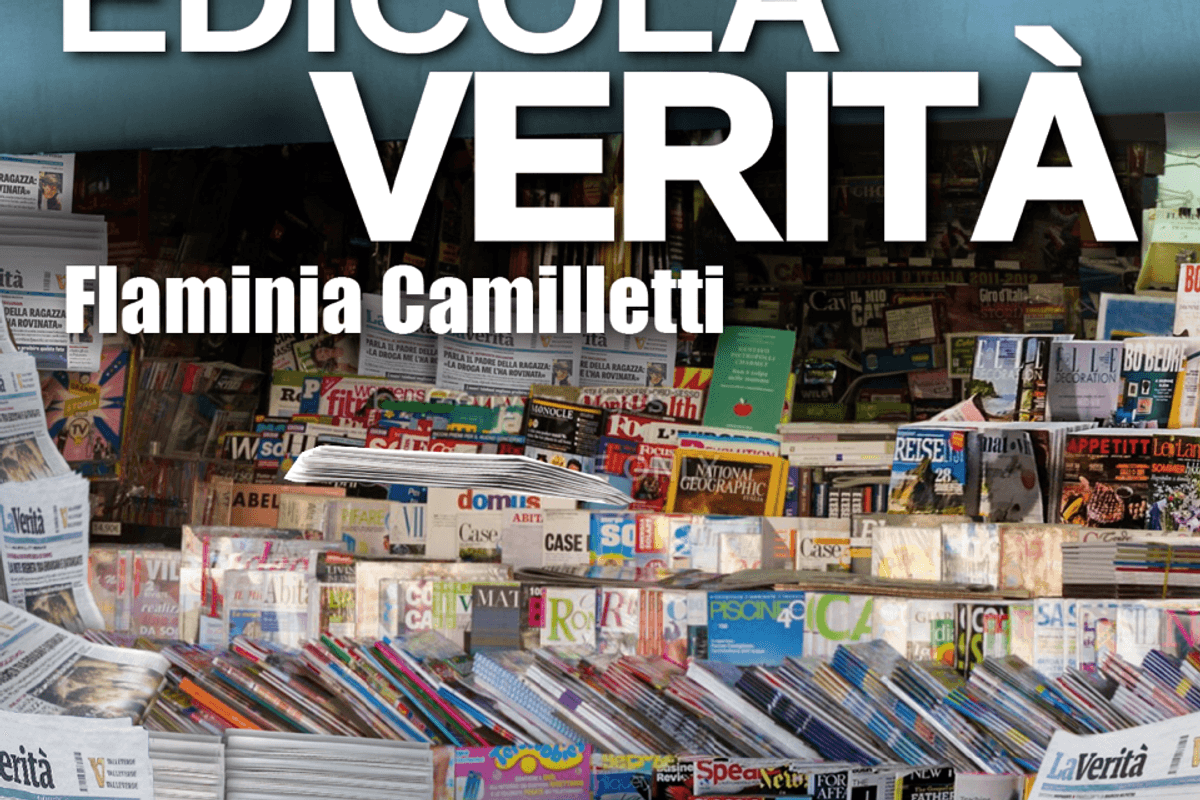Il coronavirus riporta a casa una fetta dei condannati che devono scontare ancora 18 mesi di prigione. Il loro numero, al momento, è imprecisato: c'è chi azzarda potranno essere sui 4.000. A stabilire questo «indultino» di un anno e mezzo è un articolo del decreto Cura Italia. È uno degli effetti delle rivolte carcerarie della scorsa settimana: scatenate dalla paura del virus e forse organizzate da un tam tam sotterraneo, hanno causato la morte di 14 reclusi (tutti uccisi da overdose di metadone, saccheggiato nelle infermerie dei penitenziari), il ferimento di oltre 50 agenti penitenziari e danni per circa 20 milioni di euro.
I condannati che faranno richiesta del trasferimento di pena, dovranno trascorrere quanto resta della loro condanna «presso la loro abitazione oppure in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza».
L'obiettivo è alleggerire la pressione nelle 189 carceri italiane, che in base all'ultima rilevazione del 29 febbraio ospitano 61.230 detenuti, 10.000 in più rispetto alla capienza regolamentare. Tra di loro, i condannati definitivi sono 41.873, mentre altri 9.032 sono i condannati in primo o in secondo grado. Proprio ieri si è scoperto un recluso positivo al Covid-19 nel carcere milanese di San Vittore, mentre altri tre erano stati individuati tra Pavia e Voghera, come due medici della casa circondariale di Brescia.
Ovviamente, il decreto esclude dal premio alcune categorie pericolose: i delinquenti definiti «abituali, professionali o per tendenza». Non torneranno a casa i condannati per reati di mafia o terrorismo, né per sequestro di persona o riduzione in schiavitù, per induzione alla prostituzione minorile, per pedo-pornografia, per tratta di persone (gli scafisti) o per violenza sessuale di gruppo. Non usciranno nemmeno i detenuti violenti, in regime di sorveglianza speciale, né quelli che «con i loro comportamenti compromettono la sicurezza o turbano l'ordine negli istituti», e nemmeno quelli che «con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati». Non torneranno ai domiciliari, ed è ovvio anche questo, neanche i detenuti «privi di domicilio», visto che non potrebbero rispettare le norme di sicurezza contro la pandemia, ma neanche quelli che - una volta fuori - potrebbero far del male alle loro vittime.
È strano (e grave) che il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, non abbia pensato ad alleggerire la custodia cautelare per i 9.920 detenuti che sono in attesa di primo giudizio. Eppure rappresentano il 15% della popolazione carceraria e tra di loro si poteva sicuramente individuare qualche categoria più meritevole del rientro a casa rispetto a quella dei condannati. Ma si sa, così va la giustizia nell'era grillina: risponde a logiche a volte oscure, e spesso non risponde proprio.
Rispetto agli indulti veri o mascherati del passato, comunque, c'è una novità. Per i condannati ai quali resta da scontare una pena inferiore ai sei mesi, il decreto Cura Italia stabilisce infatti possa essere applicato «il controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, ove disponibili». E chi rifiuta il dispositivo decade automaticamente dal diritto a usufruire del premio.
Il governo decide, insomma, la riesumazione del mitico «braccialetto elettronico», uno dei più sconcertanti scandali sommersi nella storia repubblicana. Come un fiume carsico, da vent'anni gli strumenti per il controllo remoto dei reclusi appaiono e scompaiono dalle cronache. Se ne parla almeno dall'aprile 2001, quando l'allora ministro dell'Interno, Enzo Bianco, investì 11 milioni di euro nella prima sperimentazione, affidandola a Telecom. Nel 2003 il suo successore, Beppe Pisanu, firmò una convenzione per altri 100 milioni di euro, che avrebbero dovuto dotare il sistema giustizia di almeno 400 dispositivi e una grande sala operativa. Nel 2012 la convenzione fu ampliata dal Viminale, a quel punto retto da Annamaria Cancellieri, e vennero spesi altri 63 milioni per altri 2.000 braccialetti. Nel 2017, sotto Marco Minniti, era stato lanciato un ultimo bando da 45 milioni per altri 12.000 apparecchi. A vincere l'ultimo appalto era stata Fastweb. Nel luglio di quello stesso anno, rispondendo a un'interpellanza in Parlamento, il sottosegretario alla Giustizia, Gennaro Migliore, rivelava che «alla fine di maggio 2017 risultavano attivi in tutto 2.000 dispositivi, altri 121 erano in lista di attesa e altri 30 erano in attivazione pianificata».
È sempre stato così. Tra lentezze burocratiche, contrasti tra il ministero dell'Interno e quello della Giustizia, mancati collaudi, scarsa disponibilità culturale dei giudici e cronica indisponibilità di apparecchi funzionanti, i braccialetti elettronici non sono mai entrati davvero in funzione. È davvero uno scandalo, sul quale (vergognosamente) nessuna Procura ha mai indagato: perché con oltre 200 milioni di euro avrebbero probabilmente potuto essere d'oro, quei braccialetti. Per lo meno, potevano essere firmati Bulgari. Sai l'eleganza…