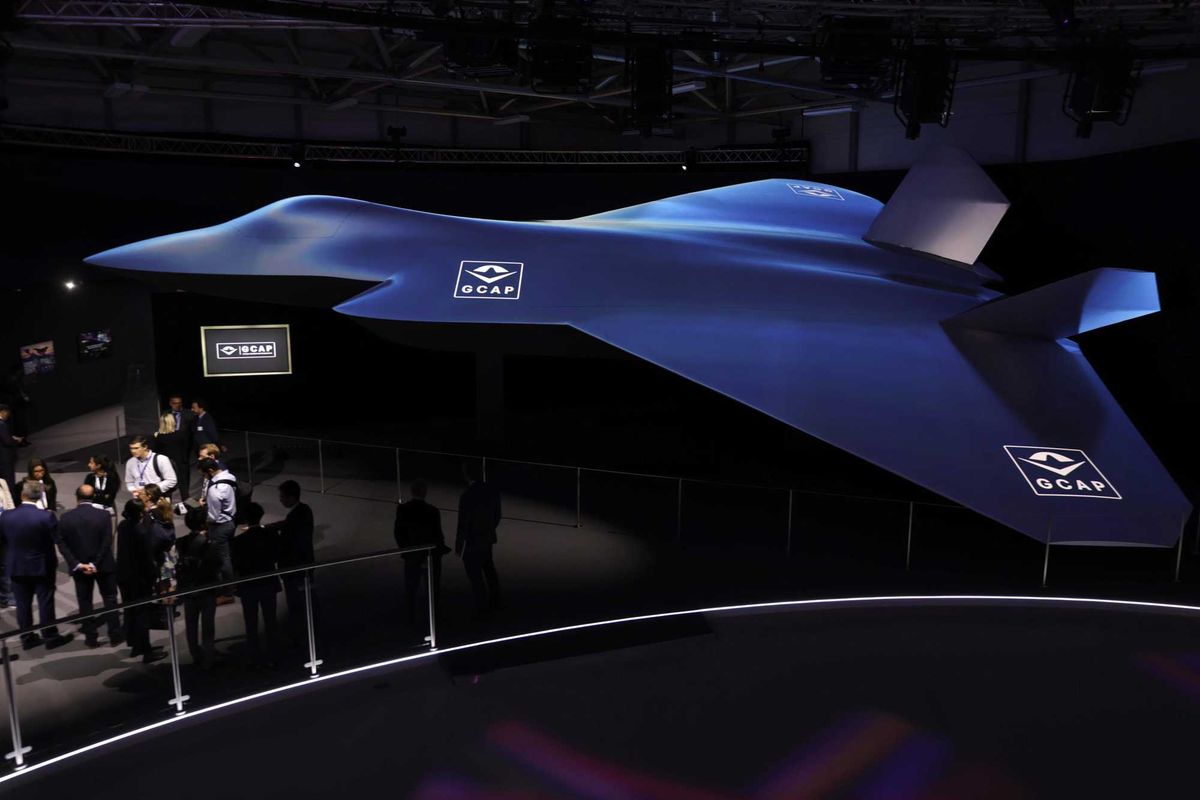Molte diverse metafore sono state proposte per intendere lo Stato, ciascuna portatrice di suoi valori e stimolo a sue strategie. Platone concepiva la repubblica ideale come una grande famiglia, in cui ciascuno trattasse ciascun altro dell’età e del sesso appropriati come un padre, una madre, un fratello, una sorella, un figlio o una figlia; quindi auspicava che i cittadini fossero legati fra loro con lo stesso affetto e la stessa generosità dei membri di una famiglia (ideale). Per Aristotele lo Stato doveva essere un gruppo di amici che si vogliono bene l’un l’altro (vogliono l’uno il bene dell’altro) e dunque non si tradiscono, non si ingannano e non si fanno violenza.
C’è stato chi, sviluppando una teocrazia, ha immaginato una convivenza retta come una chiesa o una comunità monastica: un dio (per quanto invisibile) al comando e suoi ministri che ne interpretano e ne eseguono i voleri, incapaci di sbagliare quanto lo è l’ente soprannaturale che li ispira. Nel modello proposto da Thomas Hobbes, lo Stato viene a incarnarsi, letteralmente, in un individuo, cui tutti gli altri cedono la propria libertà e che da allora esercita un potere assoluto (absolutus, sciolto da ogni vincolo); Luigi XIV avrebbe dato voce a questo modello con il famoso motto (probabilmente apocrifo) «L’état, c’est moi», lo Stato sono io.
In tempi recenti, abbiamo visto lo Stato assimilato a una caserma, con duci e ducetti in uniforme (ricordo che dux in latino è regolamente usato in contesti militari) e cittadini di varie età «irreggimentati» in corpi e pratiche marziali. E soprattutto lo abbiamo visto assimilato a un’azienda, che dovrebbe fornire servizi ai suoi clienti in modo economico ed efficiente. Negli Stati Uniti, dove questo modello impera, ai lavori in corso sulle strade si accompagnano invariabilmente cartelli che invitano a prendere atto di come i nostri soldi (quelli, cioè, del contribuente) vengano messi a buon frutto.
Negli ultimi due anni e mezzo di delirio pseudopandemico ho assistito all’emergere di una metafora che in precedenza aveva avuto usi limitati (nei Lager nazisti, nei gulag staliniani, in Paesi attraversati da temporanea follia come la Cambogia di Pol Pot) e che si sta ora affermando con prepotenza nell’universo mondo. Quella dello Stato come carcere. Vediamo qualche dettaglio.
In carcere viene negata la libertà di movimento. E in effetti, con pretesti speciosi (è stato poi dimostrato che queste misure non servivano a nulla; erano anzi controproducenti), una delle prime mosse di quasi tutti i governi è stata negare la libera circolazione dei cittadini. Chi era ancora sveglio parlava di arresti domiciliari; la maggioranza, addormentata dalla propaganda, si dichiarava fiera di rimanere a casa, chiusa fra quattro mura.
I carcerati hanno diritti civili ridotti; in particolare, mentre sono in carcere, non possono votare. Anche i cittadini (per esempio) italiani hanno visto ridurre di molto i propri diritti: non solo il diritto di muoversi liberamente ma anche quello di scegliere se e come curarsi, se e come lavorare, se svolgere attività di gruppo o anche parteciparvi come spettatori, se incontrare e abbracciare i propri cari, perfino se seppellire i propri morti. Vedremo presto se gli lasceranno il diritto di votare o troveranno una scusa per «sospenderlo» (è questo il termine usato, appunto, per i carcerati).
In compenso, ai carcerati rimane il diritto di essere (ri)educati, e su questo le autorità competenti non fanno sconti: la rieducazione ha luogo ventiquattr’ore al giorno, sette giorni la settimana, a reti televisive, siti e giornali unificati. Chi vuole eludere le censure del sistema deve fare come Gramsci quando scriveva le sue lettere dal carcere: parlare in un linguaggio cifrato per non essere smascherato (in questo caso) dagli algoritmi.
Il che mi introduce all’ultima e più inquietante analogia, che riguarda un carcere non reale ma finora soltanto sognato. Nel 1791 Jeremy Bentham, iniziatore dell’utilitarismo, completò il suo progetto di un panopticon. Il termine, di origine greca, indica una struttura in cui tutti possono essere visti, in ogni momento, da un singolo osservatore. La prima applicazione di questa idea, per Bentham, fu a un carcere: sarebbe stato costruito in forma circolare, con celle che avevano ciascuna due finestre, una verso l’esterno per prendere luce e una verso l’interno, dove, in una torre centrale, era sistemato il custode. Le celle sarebbero state illuminate e il custode avrebbe avuto accesso costante a quel che facevano i prigionieri. Il custode avrebbe dovuto essere loro nascosto, creando, scrive Bentham, «il sentimento di una sorta di onnipresenza invisibile» e inducendo così un comportamento disciplinato e deferente.
Lo stesso Bentham riteneva che il panopticon potesse essere usato anche per ospedali, manicomi e scuole, uniformandoli, a tutti gli effetti, a un carcere. Quel che non poteva prevedere è lo straordinario potere conferito da strumenti elettronici di tenere le persone sotto perpetua osservazione, senza elaborate costruzioni di celle e torri. Benvenuti dunque nella comunità come carcere: ognuno davanti al suo schermo e accessibile ininterrottamente al Grande Fratello. Gli amici di Aristotele, i clienti dello Stato-azienda e perfino i soldati di uno Stato militarizzato o i fedeli di una teocrazia mai avrebbero potuto essere piegati a un livello di disciplina e deferenza come quello disponibile oggi!