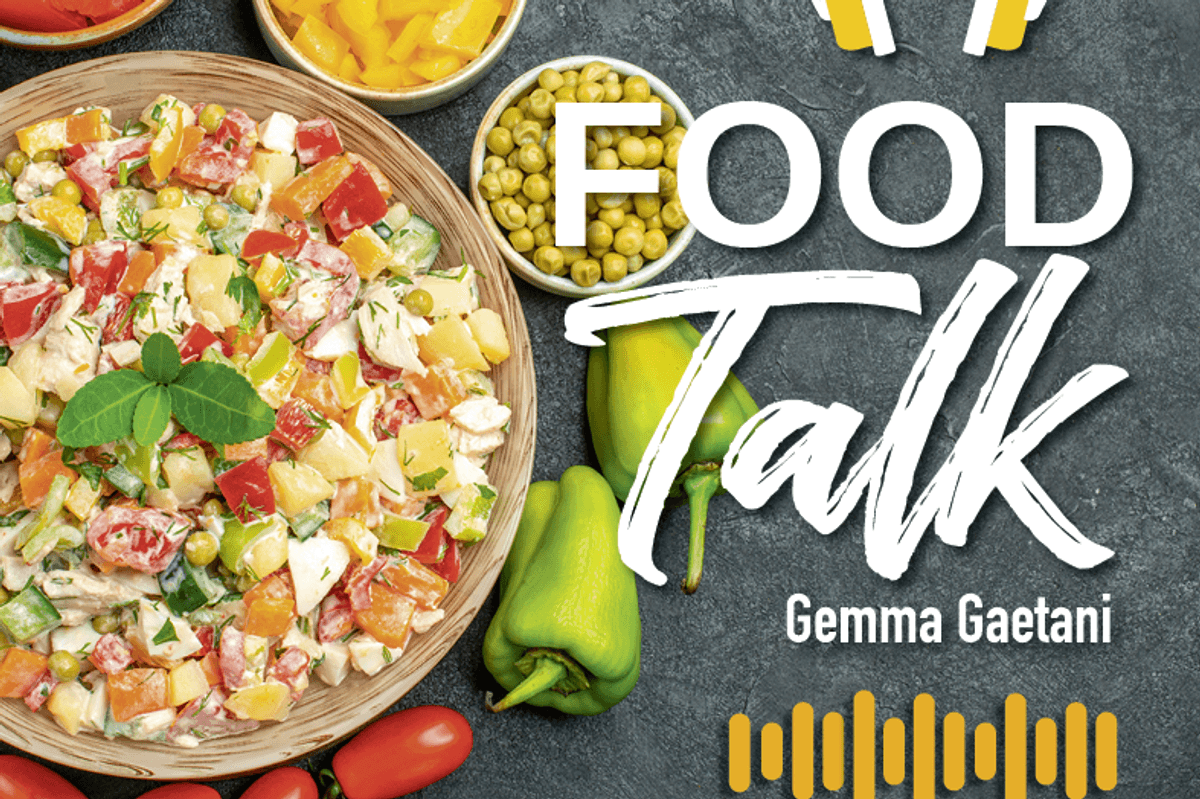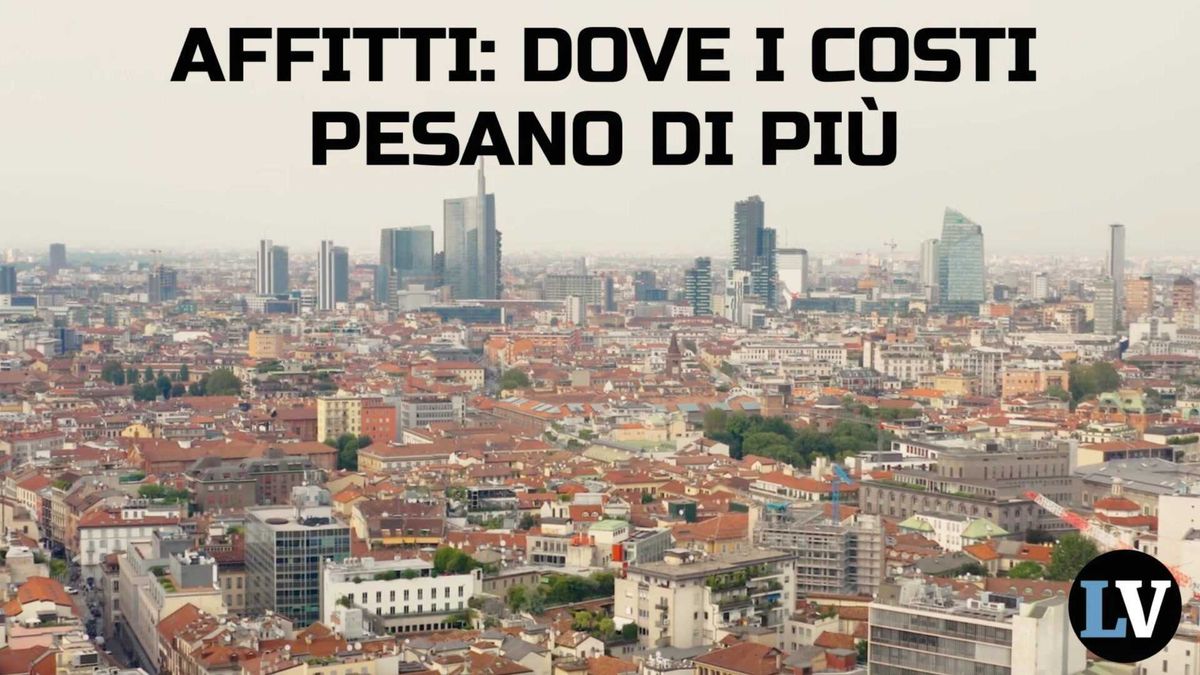Stefano Davide Bettera, Vicepresidente dell’Unione buddhista europea
Il buddismo parla solo di trascendenza. Ed è un’affermazione totale, senza indugio, della sacralità della vita. Della dignità e del valore di un vitalismo che vince sulla sofferenza, anzi, che esiste proprio oltre la sofferenza. È un’escatologia, dunque una via di salvezza. Che non vuole salvarci dal vivere ma, come affermava Friedrich Nietzsche, dall’impedirci di morire quando siamo ancora in vita. Che è tutto fuorché arrendevolezza.
Ci salviamo, infatti, attraverso il riappropriarci del reale senso del vivere, grazie alla presa di coscienza della condizione di fragilità che ci accomuna tutti e, di conseguenza nel valorizzare la nostra preziosità e unicità. Affermare che tutto è fragile, impermanente, è l’esatto contrario dal sostenere che nulla esiste. Senza l’esperienza della corporeità non è possibile alcun accesso alla trascendenza. Piuttosto, ciò che genera la nostra sofferenza, il nostro malessere, il senso di inadeguatezza, quel «malaise» di cui scriveva Paul Verlaine è l’abbandonarsi ostinato a una percezione di immortalità. Ma se l’impermanenza è la caratteristica primaria dell’essere ciò non implica affatto l’abbandono al pessimismo nichilista.
Il buddismo, al contrario, ci richiama all’azione, alla pratica, alla trasformazione del nostro rapporto con l’esistenza. Ci esorta a guardare oltre, a conoscere e comprendere la profonda tessitura che ci rende interdipendenti con un assoluto che è la nostra vera natura. E lancia, così, un messaggio di speranza: la felicità è possibile nonostante la dimensione caduca terrena. Il buddismo è, inoltre, una mistica, una «teologia negativa» che porta a destrutturare, cioè ad affermare per negazione, tutto ciò che non deve essere stereotipato, reso sterile per via razionale. Diventa un accesso totale alla sacralità del mistero, oltre la parola, oltre le definizioni perché la riporta nel quotidiano, come direbbe Martin Buber.
L’assenza di «Dio» nella dottrina buddista riguarda, poi, più un problema terminologico che sostanziale. Non è vi un richiamo esplicito perché, come ogni quesito irrisolvibile per via razionale, diventa secondario al fine di affrontare il problema del vivere e del morire. Il nirvana esaurisce, infatti, questo bisogno di trascendenza non come mero raggiungimento di una pace emotiva ma come possibilità reale di scorgere in essa l’assoluto. È, dunque, il punto di approdo di un percorso mistico, religioso, che nulla ha a che fare con un benessere strumentale. Allo stesso modo, in questa visione, la compassione non è moralismo indiscriminato, non è universalismo buonista, ma coinvolgimento nel destino del volto dell’altro, il volto concreto che incontriamo e che, per dirla con Emmanuel Lévinass, ci richiama a una responsabilità, ci giudica prima che questo incontro si trasformi in un’astrazione etica.
La compassione buddista, ancora una volta, si gioca sul piano della trascendenza perché esplicita l’affermazione di una condizione di interdipendenza a prescindere, prima che questa divenga una categoria del pensiero, un imperativo etico kantiano. Non c’è alcun monito ad agire che sia slegato dal reale, ma si agisce poiché non vi è altra condizione possibile. Non vi è via di scampo se non l’ineluttabilità dello scambiare il proprio destino con l’altro che diventa così tramite, presenza dell’assoluto. Fratello in senso francescano, se vogliamo.
Va da sé, infine, che questa dottrina non risponde ad alcun pessimismo schopenhaueriano, quanto piuttosto a un vitalismo heideggeriano che si esplica nell’affermazione di un essere e nella scelta consapevole di prenderci cura di quell’essere in ogni sua forma, in ogni sua presenza nella realtà. Questa è la condizione ultima e necessaria della nostra più autentica umanità e la risposta più decisa ed efficace alla dissoluzione pornografica e nichilista della nostra epoca che annulla il sacro. Va detto che è reale, in molti casi, la presenza nella scelta del sentiero buddista di ciò che definisco «la ferita cattolica», ossia il fraintendimento causato dall’abbandono di una religione di provenienza per la ricerca di una «spiritualità» dell’immanenza che non implichi la dimensione della ritualità e del sacro. Ma si tratta di un’incomprensione, di una mistificazione frutto di una conoscenza non adeguata.
Se è vero che oggi è non inconsueto accostarsi alla materia religiosa con una propensione all’autoerotismo spirituale, è altresì ancor più vero che il buddismo rappresenta, al contrario, una risposta decisa alla propensione al consumo superficiale dell’esperienza interiore e un baluardo che protegge da ogni cultura di morte. La religione buddista contempla una visione cosmica di sacralizzazione del rapporto col mistero e include questa relazione nella funzione che assegna all’essere umano che diviene responsabile della cura. Ogni atto di cura è un atto di gentilezza, non come semplice generosità del cuore ma come presa in carico, come responsabilità di generare un diverso paradigma e restituire alla vita la sua completezza e la sua ultima preziosità.