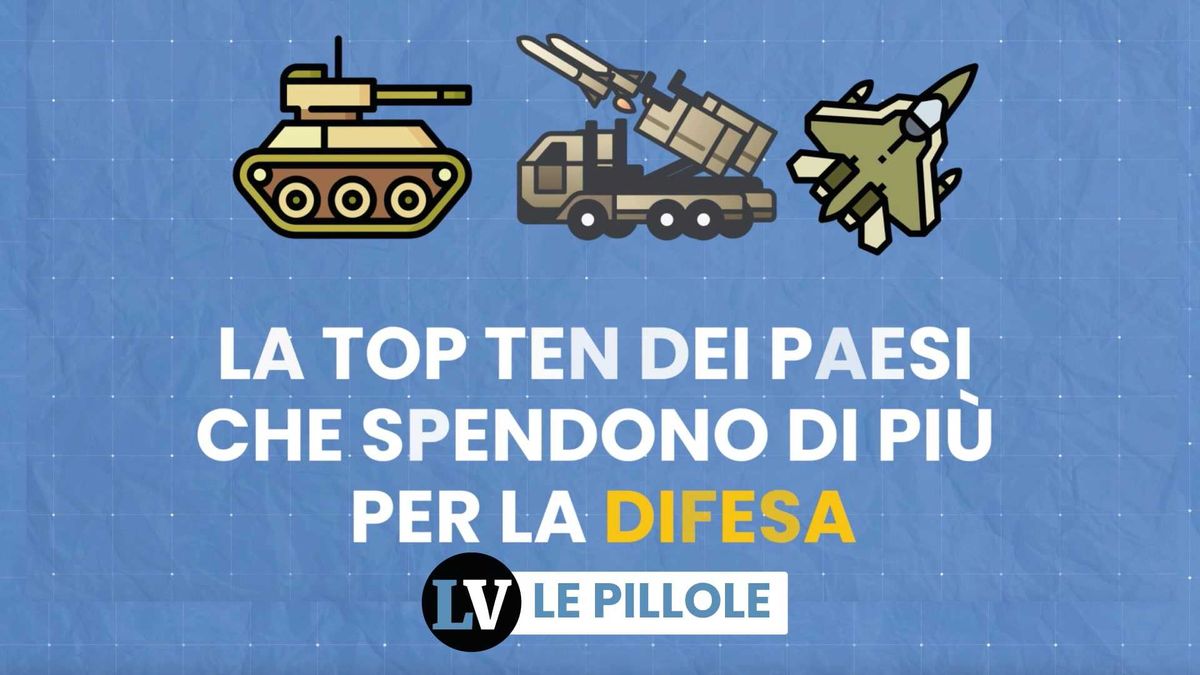È dolce, cremoso, rinfrescante, nutriente, dissetante, vitaminico e rimineralizzante, si lecca dal cono un po' selvaticamente, così come un piccolo di gatto si abbevera dalla ciotolina piena di latte, oppure si mangia dal cucchiaino che pesca nella coppa con la stessa eleganza con la quale i nobili raccolgono la zuppa d'ostriche: è il gelato, il re assoluto dell'estate e una delle preparazioni della nostra arte culinaria che, se non esistesse, bisognerebbe assolutamente inventare.
In realtà, la storia del gelato consta di un'evoluzione lenta, internazionale e, in alcuni punti dell'intricato puzzle, ancora misteriosa riguardo a chi abbia effettivamente influenzato chi e quando. Una certezza marmorea, però, è che l'antesignano del gelato come lo concepiamo oggi (ossia - per le creme - uova, latte, zucchero e l'ingrediente che ne determina il gusto e - per i gusti alla frutta - latte, zucchero e frutta) è stato quello che chiamiamo sorbetto (acqua, zucchero e frutta).
La parola sorbetto deriva dal turco şerbet che deriva dall'arabo sharāb che, a sua volta, potrebbe nascere da una radice di origine indoeuropea determinata dal latino sorbere: perfino la ricostruzione etimologica nel mondo del gelato risulta complessa, non solo quella storica. Comunque, quella parola araba significa «bibita fresca» e il verbo latino vuol dire «sorbire»: il sorbetto è, in effetti, una bibita densa e ghiacciata che si beve. Il gelato è il suo equivalente più cremoso, che non si beve come acqua, ma nemmeno si mastica come una torta.
Sono tante le tracce disseminate per tutto il mondo che ci dicono che l'uomo preparava protosorbetti e protogelati fin dall'antichità. In una tomba della II dinastia egizia (2700 a.C.) è stata ritrovata una doppia coppa che, gelando il composto dall'esterno, svolgeva la stessa funzione dell'odierna gelatiera-sorbettiera.
Si trattava di una coppa più piccola, nella quale si poneva la frutta cotta, che si inseriva in una più grande nella quale si metteva la neve o il ghiaccio rotto. L'intercapedine così ghiacciata abbassava la temperatura del contenuto che contornava fino a gelarlo.
In Cina, già intorno al 2000 a.C., si preparava una crema fatta con riso stracotto, latte e spezie, che poi si congelava ponendola sotto la neve. Non dobbiamo dunque pensare che il procedimento del gelo, fondamentale per preparare il gelato, sia nato coi congelatori elettrici contemporanei. Le cosiddette neviere erano depositi nei quali si stipavano neve e lastre di ghiaccio per l'estate: come qualsiasi altro prodotto di stagione, se ne faceva scorta e lo si conservava per utilizzarlo nelle restanti tre. Secondo molti, l'uso di gelare bibite sarebbe approdato in Italia direttamente dalla Cina nel XIII secolo attraverso Marco Polo.
Per altri, l'uso nacque in Sicilia, per alcuni tramite gli Spagnoli nel XVI secolo, per altri tramite gli Arabi nel IX secolo, quando introdussero la coltivazione della canna da zucchero che pian piano sostituì il miele come dolcificante e l'uso, già prassi nella cultura araba, della preparazione del sorbetto.
Ma pozzi per ghiaccio e neve trasportati dai monti dagli schiavi esistevano già nell'antica Roma. Tuttavia, è di fatto in Sicilia che avviene una tappa importantissima per la diffusione del moderno gelato e per la sua universalmente riconosciuta maestria italiana: Francesco Procopio Cutò De' Coltelli all'inizio del XVII secolo emigrò verso Parigi e vi aprì il Café Le Procope, che era, a tutti gli effetti, anche una gelateria: vi si potevano ordinare, infatti, acque gelate (le odierne granite) nonché gelato al succo di limone, gelato al succo d'arancio, sorbetto di fragola.
Il Café ebbe un incredibile successo e, sebbene oggi sia diventato un ristorante, presenta ancora qualche gelato nella carta dei dessert. Sempre nel XVII secolo è Antonio Latini, capocuoco di un viceré spagnolo a Napoli, a mettere nero su bianco le prime ricette moderne dei sorbetti in Lo scalco alla moderna, overo l'arte di ben disporre i conviti, con le regole più scelte di scalcheria, precisamente nel capitolo intitolato «Trattato di varie sorti di sorbette, ò di acque agghiacciate».
cedro candito e zucca
Le sue indicazioni sono in linea con le consuetudini e le intuizioni già sviluppate in precedenza: mescolare neve insieme con zucchero, sale, succo di limone, fragole, amarene, cioccolata, pinoli, ma anche melanzane.
Ingrediente, quest'ultimo, che sembra anticipare le incursioni del gelato gourmet contemporaneo nei sapori sapidi anziché dolci, che fanno storcere il naso a molti, ma che sono l'evoluzione creativa del gelato da - almeno - assaggiare prima di rifutare.
Notevole, nello Scalco, anche il «sorbetto di latte che prima sia stato cotto», praticamente un gelato ante litteram, che si preparava cuocendo una caraffa di latte, zucchero e acqua, poi aggiungendo cedro candito e zucca e, infine, mettendo a ghiacciare.
Le tappe per l'arrivo al gelato odierno - suddivisibile in artigianale e industriale, e dal punto di vista gastronomico in gelato tradizionale e gelato gourmet - sono infinite altre. Ma ciò che è più interessante, in questa fascinosa e labirintica storia, è notare come approdando ai tempi nostri siano oltre che decuplicati i consumi di gelato.
come diceva totò
Se negli anni Cinquanta in Italia se ne mangiavano due etti e mezzo a testa all'anno, siamo ora arrivati ad oltre cinque chili annuali pro capite secondo i dati Aidi e addirittura 7 secondo Cna alimentare.
Sempre secondo quest'ultima fonte, il giro d'affari del gelato in Italia ammonta a circa 2,7 miliardi di euro e, nonostante molti settori economici siano in crisi, quello della gelateria parrebbe di no: 20.500 gelaterie e più di 30.000 bar che servono gelati.
Insomma, ogni italiano, oggi può affermare in maniera veritiera quanto Totò, nei panni del povero in canna Felice Sciosciammocca, dichiarava mentendo spudoratamente nella famosa scena del film Miseria e nobiltà in cui si gettava sulle coppe di gelato offerte dal nobile don Gaetano per strafogarsi della prelibata leccornia: «Noi siamo abituati a mangiare i gelati!».
calcio e vitamine b
Mangiare gelato, dopo tutto, è davvero una buona abitudine. Considerato un comfort food, cioè un cibo che coccola l'animo, il gelato fa bene anche al corpo. Innanzitutto, refrigera e idrata, essendo una preparazione solidificata dalla glaciazione ma sostanzialmente liquida.
Importante, poi, soprattutto in estate, quando caldo e umidità possono abbassare troppo la pressione arteriosa e far sentire deboli, è l'apporto di zuccheri. Non indifferente è anche l'apporto di calcio e vitamina B del latte e quello dei sali minerali o delle proteine dei rispettivi gusti. Le calorie non sono eccessive: all'incirca 150 per i gusti alla frutta e 300 per quelli alla crema. Una ricca coppa, magari guarnita di panna montata e una cialda, oppure un cono abbastanza consistente, possono tranquillamente sostituire un pasto (non dimentichiamo che nelle creme c'è anche l'uovo).
Soprattutto, però, il gelato sembra apportare un beneficio anche all'umore. L'Institute of Psychiatry di Londra ha rilevato che mangiarlo attiva nel cervello un meccanismo di ricompensa, forse anche perché ci riporta a quando eravamo bambini.