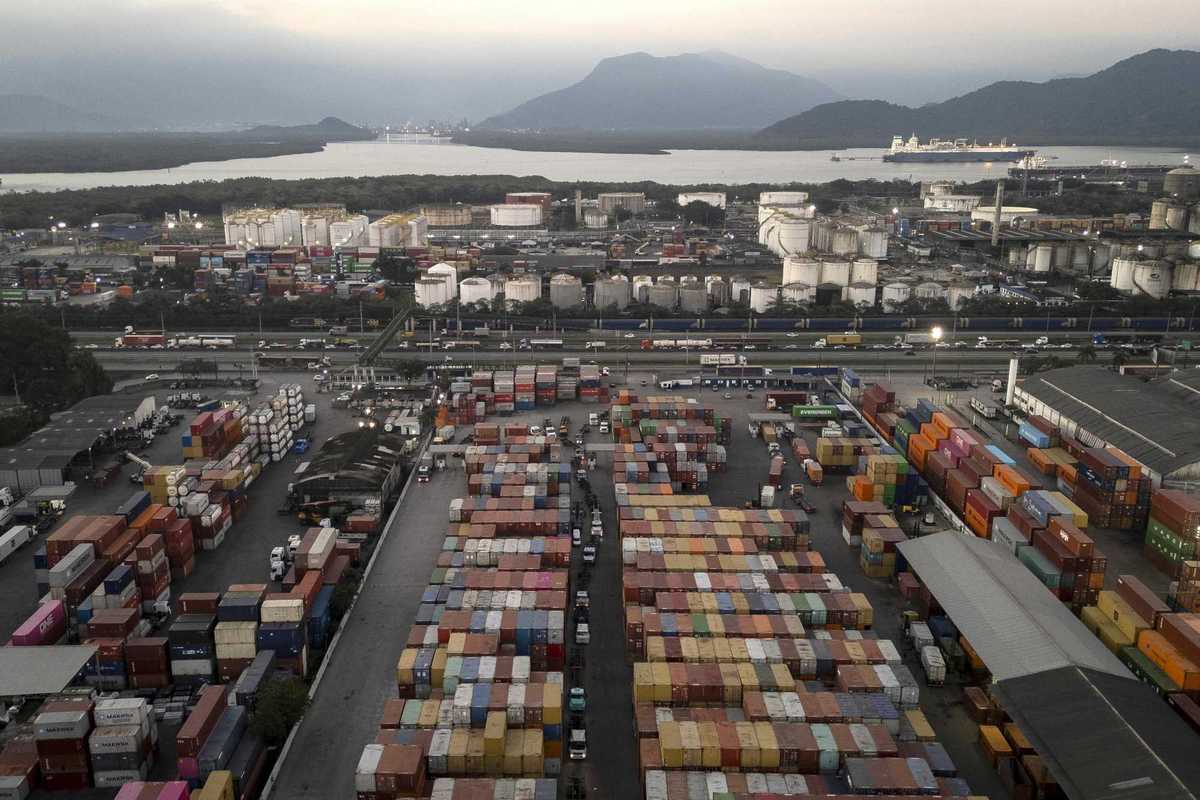True
2021-11-08
Storie di briganti del Nord Italia: Piemonte, Lombardia e Veneto
True
(Getty Images)
Arcinota è la storia del brigantaggio nell'Italia del Sud. La storiografia e le cronache, in particolare quelle risorgimentali, hanno riempito migliaia di pagine sull'epopea dei banditi che infestavano le zone montuose della Campania, del Molise, della Calabria e dellla Sicilia. Altrettante ne sono state stilate nello studio delle attività delle autorità postunitarie per la repressione del fenomeno, nella quale primeggiò per risolutezza il generale Giuseppe Govone.
Meno nota, ma non meno interessante, la storia dei briganti che terrorizzarono le terre del Settentrione italiano dalla Liguria al Friuli a partire dal medioevo, in un fenomeno diffuso che vide il suo apice tra il XVII e il XVIII secolo, spesso generato dalle condizioni di indigenza della popolazione contadina e dalla piaga delle continue guerre tra gli stati preunitari, che lasciavano sulla strada centinaia di ex soldati sbandati e giovani renitenti alle proscrizioni militari.
Piemonte: Giovanni Scarsello e i suoi fratelli.
Siamo a Narzole, paese del cuneese tra Alba e Fossano, in età napoleonica. La zona presenta folti boschi e colline, che ben si prestavano al nascondiglio di malfattori che da anni infestavano i dintorni del paese tanto che sotto il governo del Regno di Sardegna si era addirittura pensato di cancellarlo dalle mappe deportandone gli abitanti. Abitanti per il novanta percento poveri contadini alle prese con la sopravvivenza se non la fame. Già all'alba del periodo napoleonico i dintorni di Narzole erano stati battuti dal brigante "Cadreghin ", che armato del suo "spaciafoss" (piemontese per coltellaccio) aveva derubato decine di malcapitati, derubando bestiame e denari, prima della cattura nel 1800 e del carcere duro a Racconigi. L'arresto del brigante con il nuovo secolo non donò tuttavia la pace a Narzole, nonostante una guarnigione della Gendarmeria napoleonica vi avesse preso alloggio, malsopportata dalla popolazione per l'atteggiamento repressivo e arrogante nei confronti degli abitanti. L'eredità del Cadreghin è presto raccolta, questo volta da una banda ben organizzata di narzolesi. Ci sono i tre fratelli Scarsello non proprio giovanissimi. Il capo è il minore, Giovanni, di 35 anni. Gli altri due sono Domenico (40 anni) e Giambattista (45 anni). Con loro operavano una decina di compaesani anche imparentati tra loro. La prima vicenda legata alla banda è un omicidio di un gendarme sulla piazza principale del paese. dai rapporti degli inquirenti uscì la prima descrizione del "brigante simpatico", bonario con tutta la popolazione e di spirito allegro. Ma feroce e sanguinario con i nemici, in particolare modo con i nuovi dominatori portatori in Piemonte delle idee giacobine contro la tradizione cattolica e rurale delle campagne del cuneese. La banda di Scarsello, piccola Vandea piemontese, si accanirà colpendo i borghesi con particolare ferocia, specie quelli compromessi con l'occupante francese. Per la piccola guarnigione di gendarmi Narzole diventò presto un inferno, anche perché i militari, frustrati dall'insuccesso nel catturare i membri della banda, si rifacevano spesso su famiglie di contadini inermi ed innocenti. Come avvenne nel gennaio 1802 quando un nucleo della Gendarmeria fu inviato da Fossano a Narzole dopo un furto di bestiame. I soldati, al posto di cercare i responsabili della rapina si misero a scaricare i moschetti contro i passanti, seminando terrore e solidarietà ai banditi da parte degli abitanti. Nonostante i rinforzi di polizia richiesti dal sindaco, la banda di Scarsello è ancora a piede libero. Si decise così di passare, con forze più consistenti, al rastrellamento dei dintorni del paese. Ma i fratelli Scarsello e la loro banda sono più scaltri. Seppero mantenere ottimi rapporti con la popolazione, promisero protezione e soprattutto ebbero l'accortezza di non rimanere solamente nei dintorni del loro paese, ma di spingersi sino ai confini con la Liguria, arruolando nuovi membri lungo la strada. I briganti uccisero francesi a Bra, Cherasco, Alba, senza essere mai sfiorati dal pericolo della cattura. I gendarmi tentarono anche con la corruzione di un membro della banda, ma senza successo. Cercarono di attirare Giovanni arrestandone la moglie con una soffiata. Neppure questo metodo riuscirà. Anzi, un brigante sospettato di aver tradito fu ucciso ad archibugiate dal capobanda stesso, mentre sempre più frequenti furono gli episodi di connivenza tra i gendarmi e la popolazione che li proteggeva, spesso comprata con i soldi delle rapine. Il sindaco e il comando delle forze francesi sono sul punto di imporre il coprifuoco. Soltanto in un occasione Scarsello e i suoi rischiarono la vita, quando un certo Dalpozzo, narzolese vicino ad alcuni banditi si fece rapire appositamente. I briganti della banda commisero l'errore di rilasciarlo con il compito di portare una camicia al capo. Dalpozzo tornò coi francesi e ne seguì un rocambolesco conflitto a fuoco dal quale Scarsello e il compagno Vivalda uscirono illesi grazie all'inceppamento del fucile che per primo aveva puntato al capobanda. La leggenda vuole che negli anni seguenti la banda avesse operato spingendosi fino a Torino, e che avesse puntato in alto sottraendo vere e proprie fortune ai proprietari terrieri del Piemonte occidentale, come il colpo da 450 franchi a casa di Giuseppe Ciuco di Novello. Si dice siano arrivati fino in Valle d'Aosta nei pressi di Pré Saint Didier e che addirittura fossero protetti e finanziati dai servizi segreti britannici per tenere impegnati i Francesi. Poi le cronache si interrompono fino al 1808, quando si diffuse la notizia che i capi della banda erano stati catturati ed immediatamente ghigliottinati sotto l'insegna della coccarda tricolore napoleonica, quella che tanto avevano odiato.
Lombardia: Giacomo Legorino e Battista Scorlino.
Gli anni sono quelli della Milano spagnola, alla metà del cinquecento. Il luogo è la zona a nord ovest delle mura, tra l'odierno quartiere di Villapizzone e il bosco della Merlata, una folta macchia verde che all'epoca dei fatti si estendeva sino all'area dove nel 2015 si è tenuto l'Expo e oltre, verso Arese. Il bosco si trovava sulla strada per Como e Varese con una biforcazione verso Novara, pertanto era battuta da molti commercianti in viaggio verso Milano. Ai margini del sentiero si erano appostati due capibanda con il loro seguito: Giacomo Legorino e Battista Scorlino, che per diversi anni spogliarono i viandanti dei loro averi e in alcuni casi non si fecero scrupoli ad uccidere a colpi di cappa e spada. Il loro quartier generale era una cascina nei pressi della attuale via Console Marcello, chiamata la Melgasciada, dal nome in milanese del fusto del granoturco. Il caseggiato, trasformato in seguito in osteria dove i milanesi passavano le domeniche a mangiare asparagi sotto le frasche, era in quegli anni la tana dei due lupi. Non sono rimaste testimonianze di cronaca, ma la leggenda dei due briganti di Villapizzone è rimasta viva anche grazie alle numerose rappresentazioni teatrali che a Milano si tennero fino ad oltre la metà dell'ottocento. Soprattutto ci rimangono gli atti relativi al processo stilati in seguito alla loro cattura nel 1566, scritti che permettono di ricostruire la storia delittuosa e la loro fine fatta di dolore e tortura. Tutto ciò è raccolto nel tomo (dal titolo un po' lungo) Processo formato contro duoi famosissimi banditi Giacomo Legorino, e Battista Scorlino, con suoi seguaci, quali furono tutti pubblici assassini di strada. Dalle pagine del volume si ricostruisce il lungo processo ai due banditi e alla loro banda, durato quasi un mese dal giorno della cattura, il 26 aprile 1566. Davanti al Capitano di Giustizia di Milano, cavalier Giulio da Modena, fu portata la testimonianza di colui che con un tranello riuscì a fare arrestare la banda che da anni terrorizzava i viandanti della Merlata. Simone Manzino, commerciante di cavalli, quel giorno rientrava da Milano a Novara per la via di Villapizzone . All'imbocco del bosco fu assalito dalla banda di Scorlino e Legorino che lo disarcionarono e cercarono di rapinarlo. Non avendo nulla con sé, la banda era pronta ad ucciderlo per il gusto. Tuttavia Giacomo Legorino si fece promettere 24 scudi d'oro in cambio della vita, che il malcapitato avrebbe dovuto consegnare all'indomani. L'appuntamento sarebbe stato al medesimo luogo dell'incontro. Quando fu a Novara, Manzoni sporse denuncia al podestà e il giorno dopo scattò l'imboscata. A distanza seguivano Manzoni un drappello di fanti di Novara e e uno proveniente da Milano e quando il commerciante, giunto appositamente in ritardo all'appuntamento, fu di fronte a Leporino temporeggiò fino a che quest'ultimo non fu colpito alle spalle da una guardia. Tramortito si trovò legato da capo a piedi e con lui il figlio Paolo, anche lui membro della banda di briganti milanesi. Incalzato dalle domande dell'inquisitore Giulio da Modena, inizialmente Legorino sciorinò una serie di bugie, dichiarando di essere un povero ex soldato e boscaiolo fornendo il falso nome di Vincenzo da Gusmé. L'imputato fu messo subito a confronto con il figlio Paolo, anche lui agli arresti, cercando anche in questo caso di farla franca fingendo di non conoscerlo. Il Capitano di Giustizia ordinò allora la prima delle torture al quale verrà sottoposto il brigante: l'ustione dei piedi, al quale l'efferato omicida non riuscì a resistere a lungo, cominciando la confessione di anni di delitti e rapine, archibugiate, pugnalate, strangolamenti. Circa trecento omicidi furono quelli confessati da Legorino, che dichiarò anche la sepoltura di tutti i corpi delle vittime sotto la terra del bosco della Merlata. Mentre Giacomo Legorino deponeva di fronte al giudice, il complice Battista Scorlino era ancora in latitanza. L'11 maggio 1566, verso sera, Giulio da Modena fu raggiunto nella sua abitazione da un drappello di soldati, che gli comunicarono l'arresto del secondo brigante dall'altra parte della città rispetto a Villapizzone, presso la Porta Vercellina. Portato dinnanzi al tribunale come il socio, la scena si ripeté con mistificazioni e false deposizioni, che durarono ben poco grazie al confronto col complice ormai crollato. Le sevizie seguite alle confessioni confermarono gli omicidi compiuti dalla banda tra il 1558 e il 1566, la sentenza di morte era scontata. La fine della banda della Merlata fu alquanto macabra. I due capibanda furono trascinati a terra legati alla coda di due cavalli in corsa fino alla Cagnola, quindi furono mutilati e appesi alla ruota della tortura. Dopo qualche ora Giacomo Legorino era ancora vivo. Come da regolamento, per porre fine alle sofferenze il bandito fu sgozzato con un fendente alla gola. La cascina Melgasciada, covo della banda, fu demolita nel 1959 per fare spazio ad un edificio scolastico. Durante i lavori, quattro secoli dopo i fatti, la leggenda riprese vigore perché i muratori trovarono un po' dappertutto i segni della ricerca del mitico tesoro di Legorino e Scorlino da parte di ignoti. Naturalmente questa fu senza esito, ma gli operai riuscirono a vedere il quadro "naif" che raffigurava i due briganti a riposo sotto le frasche della cascina oggi scomparsa, inghiottita negli anni del "boom" dalla città in espansione.
Veneto: Giuseppe Bedin.
In questo caso l'epopea brigantesca si consumò negli anni trenta del ventesimo secolo a Monselice, comune rurale a Sud di Padova. Qui nel 1901 da una famiglia contadina (come la maggior parte degli abitanti del paese) nasceva Giuseppe Bedin, destinato a diventare uno dei banditi più noti d'Italia grazie anche alle innumerevoli pagine di cronaca che narrarono le sue gesta di fuorilegge durante il ventennio. La sua fu una gioventù di ordinaria povertà, condivisa con molti coetanei in quel veneto misero e contadino da poco flagellato dalle rovine della Grande Guerra di cui era stato teatro. Il giovane Bepi si dimostra sveglio, fervente cattolico ed in grado di leggere e scrivere, presta regolarmente servizio militare nel 1922 e poco più tardi segue molti dei suoi conterranei nella via obbligata all'emigrazione, per lavorare in una miniera francese dalla quale farà ritorno dopo avere avuto il primo figlio da una compaesana. Il lavoro principale della giovane famiglia di Bepi a Monselice era quello di riuscire a mettere insieme il pasto quotidiano con molta difficoltà, tra il lavoro nei campi e quello occasionale come manovale in edilizia . Per arrotondare la paga misera, Bedin trovò nella allora fiorente borsa nera una soluzione nel quale si rivelò subito abile, ma che aprirà per lui la strada verso il crimine. Dopo il furto di una motocicletta per il quale sarà condannato, conoscerà per la prima volta il carcere dove a più riprese costruì la sua fama di brigante protettore dei poveri, attirando a sé con una buona dose di carisma i suoi futuri complici. Tra i capibanda figurò Severino Urati, conosciuto in carcere a Verona e compagno di una delle molteplici evasioni di cui il Robin Hood di Monselice si rese protagonista negli anni trenta. Urati sarà in seguito il cassiere della banda, abile nel ripulire i proventi delle rapine mediante investimenti in beni mobili e immobili, oltre che a maneggiare e usare senza scrupoli le armi. Nativo del mantovano, su di lui pendeva una condanna per omicidio durante una rissa. Passò anni alla macchia prima di conoscere Bedin in carcere nel 1935. Il terzo uomo fu Clemente Lampioni, anche lui con l'esperienza di una miniera belga alle spalle e varie condanne per furto. Dopo la fuga dal carcere, l'organizzazione criminale prese piede, concentrata negli anni tra il 1936 e il 1939 con un'escalation di colpi spettacolari e organizzati alla perfezione. Se dalla parte dei compaesani il mito di Bedin cresceva esponenzialmente, dall'altra le istituzioni fasciste, impegnate in quegli anni nella normalizzazione e nella lotta alla criminalità (un esempio su tutti il contrasto alla mafia da parte del prefetto di ferro Mori) non potevano più tollerare le scorrerie impunite dei banditi veneti. Senza tralasciare peraltro la scia di sangue che la banda lasciò dietro di sé durante i colpi: A Treviso sotto le raffiche dei banditi di Monselice era morto un maresciallo dei Carabinieri. I colpi messi a segno dalla banda furono moltissimi e non soltanto in Veneto. Muovendosi con automobili veloci e armi automatiche come i coevi gangster americani, rapinarono in Emilia, in Lombardia e in Piemonte. A Monselice i banditi godevano di stima e protezione, anche perché Bedin dispensava ai più bisognosi regali di un certo valore come attrezzi agricoli, capi di bestiame, alimentari. Molti furono i terreni e le cascine acquistate e affidate a prestanomi dal braccio destro Urati, che contribuirono ad alimentare il patrimonio ormai molto consistente dei briganti. Ma il colpo dei colpi fu realizzato nel 1938 a Milano. Allenati alla rapina delle paghe degli operai di diverse aziende venete, Bedin e i suoi uomini decisero di puntare al cuore dell'industria italiana. L'obiettivo era nientemeno che l'ufficio paghe della Pirelli alla Bicocca, al quale i banditi ebbero accesso e la giusta soffiata da una talpa interna alla fabbrica. Il colpo andrà a segno offrendo ai briganti un bottino stellare (860 mila lire, molto più di quanto sottratto anni dopo nella famosa rapina di via Osoppo a Milano) ma le conseguenze di questa clamorosa sfida al patrimonio industriale italiano faranno si che Mussolini stesso si muovesse per porre fine ai crimini della banda, mettendo alle calcagna dei veneti due tra gli uomini migliori delle forze dell'ordine. A Milano si occupò del caso il brigadiere Giuseppe Crespi detto Maciste, sia per la stazza (era alto quasi due metri) che per la risolutezza nello svolgimento delle indagini. Fu lui a scoprire la talpa della Pirelli, il fattorino Biasi, in casa del quale il poliziotto trovò nascosta dietro ad un quadro la paga per il favore a Bedin in banconote da 500 lire. Tornati in Veneto, Bedin e i suoi continuarono le attività criminali e la bella vita, spostandosi tra le cascine e le case parrocchiali che Bedin ben conosceva a causa della sua profonda fede cattolica e per la riconoscenza di certi parroci per la sua generosità verso i poveri. Addirittura il bandito riuscì a presenziare alle esequie della madre vestito da carabiniere, mentre in altre occasioni si mischiò tra la gente di paese vestito da donna. Il romanzo criminale di Monselice si avviò alla conclusione l'anno successivo, il 1939. Sulle tracce delle indagini iniziate dal maresciallo Maciste si inserì un altro mastino direttamente voluto dal Duce. Si trattava dell'ispettore di Polizia Giuseppe Gueli, che senza troppe remore fece uso di metodi non ortodossi su molti compaesani di Bedin (Gueli sarà condannato dopo la guerra a 8 anni di carcere per le torture messe in atto quando era a capo dell'Ispettorato speciale di P.S. per la Venezia-Giulia). Sotto tortura, alcuni degli interrogati cominciarono a cedere e il cerchio attorno alla banda si strinse sempre di più fino all'epilogo che, considerati i protagonisti delle due parti, fu bagnato dal sangue. Bepi Bedin fu circondato dalle forze dell'ordine mentre si trovava nascosto nella canonica in località Casoni di Mussolente, piccolo borgo nei pressi di Bassano del Grappa. Nonostante fosse braccato, Bepi non era abituato alla resa e cercò di vendere cara la pelle. Armato di revolver riuscì a correre fuori dalla casa parrocchiale nonostante un colpo sparato dai Carabinieri lo avesse ferito ad una spalla. Cercò l'estrema resistenza asserragliandosi in una casa colonica poco distante dove ebbe una colluttazione con i figli del proprietario, che solo per un caso non rimasero uccisi dai colpi di pistola esplosi dal malvivente. Pochi minuti dopo, raggiunto da ingenti forze di polizia cadde sotto i colpi esplosi da un agente che lo centrarono in viso e nel collo, freddandolo sul colpo. Quando lo perquisirono, gli inquirenti gli trovarono in tasca, oltre a banconote di diverso taglio, le immaginette dei Santi a cui Bepi era devoto sin dall'infanzia. Era il 4 aprile 1939 e nel pomeriggio del giorno stesso cadde sotto i colpi delle forze dell'ordine anche il socio Severino Urati (la mente finanziaria dal grilletto facile) durante uno scontro a fuoco nella sua terra d'origine, il Mantovano. La banda perdeva in un solo giorno il capo carismatico e il suo braccio destro e di lì a poco sarebbero stati arrestati anche gli altri membri di spicco della banda di Bedin. Il suo nome rimase tuttavia impresso nella memoria collettiva della zona e passò anche per gli anni di guerra. Molti furono i membri delle brigate partigiane che usarono il nome del bandito veneto e terminata la guerra saranno le voci dei bambini a tramandarne il ricordo nei loro giochi quotidiani. Nella persistente miseria del Veneto del dopoguerra, si giocava a "guardie e Bedin".
Continua a leggereRiduci
La storiografia e la cronaca hanno raccontato tutto sul brigantaggio meridionale. Anche nel settentrione il fenomeno fu a lungo presente. Tre casi in tre diverse epoche e regioni, tra mito e realtà.Arcinota è la storia del brigantaggio nell'Italia del Sud. La storiografia e le cronache, in particolare quelle risorgimentali, hanno riempito migliaia di pagine sull'epopea dei banditi che infestavano le zone montuose della Campania, del Molise, della Calabria e dellla Sicilia. Altrettante ne sono state stilate nello studio delle attività delle autorità postunitarie per la repressione del fenomeno, nella quale primeggiò per risolutezza il generale Giuseppe Govone.Meno nota, ma non meno interessante, la storia dei briganti che terrorizzarono le terre del Settentrione italiano dalla Liguria al Friuli a partire dal medioevo, in un fenomeno diffuso che vide il suo apice tra il XVII e il XVIII secolo, spesso generato dalle condizioni di indigenza della popolazione contadina e dalla piaga delle continue guerre tra gli stati preunitari, che lasciavano sulla strada centinaia di ex soldati sbandati e giovani renitenti alle proscrizioni militari. Piemonte: Giovanni Scarsello e i suoi fratelli.Siamo a Narzole, paese del cuneese tra Alba e Fossano, in età napoleonica. La zona presenta folti boschi e colline, che ben si prestavano al nascondiglio di malfattori che da anni infestavano i dintorni del paese tanto che sotto il governo del Regno di Sardegna si era addirittura pensato di cancellarlo dalle mappe deportandone gli abitanti. Abitanti per il novanta percento poveri contadini alle prese con la sopravvivenza se non la fame. Già all'alba del periodo napoleonico i dintorni di Narzole erano stati battuti dal brigante "Cadreghin ", che armato del suo "spaciafoss" (piemontese per coltellaccio) aveva derubato decine di malcapitati, derubando bestiame e denari, prima della cattura nel 1800 e del carcere duro a Racconigi. L'arresto del brigante con il nuovo secolo non donò tuttavia la pace a Narzole, nonostante una guarnigione della Gendarmeria napoleonica vi avesse preso alloggio, malsopportata dalla popolazione per l'atteggiamento repressivo e arrogante nei confronti degli abitanti. L'eredità del Cadreghin è presto raccolta, questo volta da una banda ben organizzata di narzolesi. Ci sono i tre fratelli Scarsello non proprio giovanissimi. Il capo è il minore, Giovanni, di 35 anni. Gli altri due sono Domenico (40 anni) e Giambattista (45 anni). Con loro operavano una decina di compaesani anche imparentati tra loro. La prima vicenda legata alla banda è un omicidio di un gendarme sulla piazza principale del paese. dai rapporti degli inquirenti uscì la prima descrizione del "brigante simpatico", bonario con tutta la popolazione e di spirito allegro. Ma feroce e sanguinario con i nemici, in particolare modo con i nuovi dominatori portatori in Piemonte delle idee giacobine contro la tradizione cattolica e rurale delle campagne del cuneese. La banda di Scarsello, piccola Vandea piemontese, si accanirà colpendo i borghesi con particolare ferocia, specie quelli compromessi con l'occupante francese. Per la piccola guarnigione di gendarmi Narzole diventò presto un inferno, anche perché i militari, frustrati dall'insuccesso nel catturare i membri della banda, si rifacevano spesso su famiglie di contadini inermi ed innocenti. Come avvenne nel gennaio 1802 quando un nucleo della Gendarmeria fu inviato da Fossano a Narzole dopo un furto di bestiame. I soldati, al posto di cercare i responsabili della rapina si misero a scaricare i moschetti contro i passanti, seminando terrore e solidarietà ai banditi da parte degli abitanti. Nonostante i rinforzi di polizia richiesti dal sindaco, la banda di Scarsello è ancora a piede libero. Si decise così di passare, con forze più consistenti, al rastrellamento dei dintorni del paese. Ma i fratelli Scarsello e la loro banda sono più scaltri. Seppero mantenere ottimi rapporti con la popolazione, promisero protezione e soprattutto ebbero l'accortezza di non rimanere solamente nei dintorni del loro paese, ma di spingersi sino ai confini con la Liguria, arruolando nuovi membri lungo la strada. I briganti uccisero francesi a Bra, Cherasco, Alba, senza essere mai sfiorati dal pericolo della cattura. I gendarmi tentarono anche con la corruzione di un membro della banda, ma senza successo. Cercarono di attirare Giovanni arrestandone la moglie con una soffiata. Neppure questo metodo riuscirà. Anzi, un brigante sospettato di aver tradito fu ucciso ad archibugiate dal capobanda stesso, mentre sempre più frequenti furono gli episodi di connivenza tra i gendarmi e la popolazione che li proteggeva, spesso comprata con i soldi delle rapine. Il sindaco e il comando delle forze francesi sono sul punto di imporre il coprifuoco. Soltanto in un occasione Scarsello e i suoi rischiarono la vita, quando un certo Dalpozzo, narzolese vicino ad alcuni banditi si fece rapire appositamente. I briganti della banda commisero l'errore di rilasciarlo con il compito di portare una camicia al capo. Dalpozzo tornò coi francesi e ne seguì un rocambolesco conflitto a fuoco dal quale Scarsello e il compagno Vivalda uscirono illesi grazie all'inceppamento del fucile che per primo aveva puntato al capobanda. La leggenda vuole che negli anni seguenti la banda avesse operato spingendosi fino a Torino, e che avesse puntato in alto sottraendo vere e proprie fortune ai proprietari terrieri del Piemonte occidentale, come il colpo da 450 franchi a casa di Giuseppe Ciuco di Novello. Si dice siano arrivati fino in Valle d'Aosta nei pressi di Pré Saint Didier e che addirittura fossero protetti e finanziati dai servizi segreti britannici per tenere impegnati i Francesi. Poi le cronache si interrompono fino al 1808, quando si diffuse la notizia che i capi della banda erano stati catturati ed immediatamente ghigliottinati sotto l'insegna della coccarda tricolore napoleonica, quella che tanto avevano odiato.Lombardia: Giacomo Legorino e Battista Scorlino.Gli anni sono quelli della Milano spagnola, alla metà del cinquecento. Il luogo è la zona a nord ovest delle mura, tra l'odierno quartiere di Villapizzone e il bosco della Merlata, una folta macchia verde che all'epoca dei fatti si estendeva sino all'area dove nel 2015 si è tenuto l'Expo e oltre, verso Arese. Il bosco si trovava sulla strada per Como e Varese con una biforcazione verso Novara, pertanto era battuta da molti commercianti in viaggio verso Milano. Ai margini del sentiero si erano appostati due capibanda con il loro seguito: Giacomo Legorino e Battista Scorlino, che per diversi anni spogliarono i viandanti dei loro averi e in alcuni casi non si fecero scrupoli ad uccidere a colpi di cappa e spada. Il loro quartier generale era una cascina nei pressi della attuale via Console Marcello, chiamata la Melgasciada, dal nome in milanese del fusto del granoturco. Il caseggiato, trasformato in seguito in osteria dove i milanesi passavano le domeniche a mangiare asparagi sotto le frasche, era in quegli anni la tana dei due lupi. Non sono rimaste testimonianze di cronaca, ma la leggenda dei due briganti di Villapizzone è rimasta viva anche grazie alle numerose rappresentazioni teatrali che a Milano si tennero fino ad oltre la metà dell'ottocento. Soprattutto ci rimangono gli atti relativi al processo stilati in seguito alla loro cattura nel 1566, scritti che permettono di ricostruire la storia delittuosa e la loro fine fatta di dolore e tortura. Tutto ciò è raccolto nel tomo (dal titolo un po' lungo) Processo formato contro duoi famosissimi banditi Giacomo Legorino, e Battista Scorlino, con suoi seguaci, quali furono tutti pubblici assassini di strada. Dalle pagine del volume si ricostruisce il lungo processo ai due banditi e alla loro banda, durato quasi un mese dal giorno della cattura, il 26 aprile 1566. Davanti al Capitano di Giustizia di Milano, cavalier Giulio da Modena, fu portata la testimonianza di colui che con un tranello riuscì a fare arrestare la banda che da anni terrorizzava i viandanti della Merlata. Simone Manzino, commerciante di cavalli, quel giorno rientrava da Milano a Novara per la via di Villapizzone . All'imbocco del bosco fu assalito dalla banda di Scorlino e Legorino che lo disarcionarono e cercarono di rapinarlo. Non avendo nulla con sé, la banda era pronta ad ucciderlo per il gusto. Tuttavia Giacomo Legorino si fece promettere 24 scudi d'oro in cambio della vita, che il malcapitato avrebbe dovuto consegnare all'indomani. L'appuntamento sarebbe stato al medesimo luogo dell'incontro. Quando fu a Novara, Manzoni sporse denuncia al podestà e il giorno dopo scattò l'imboscata. A distanza seguivano Manzoni un drappello di fanti di Novara e e uno proveniente da Milano e quando il commerciante, giunto appositamente in ritardo all'appuntamento, fu di fronte a Leporino temporeggiò fino a che quest'ultimo non fu colpito alle spalle da una guardia. Tramortito si trovò legato da capo a piedi e con lui il figlio Paolo, anche lui membro della banda di briganti milanesi. Incalzato dalle domande dell'inquisitore Giulio da Modena, inizialmente Legorino sciorinò una serie di bugie, dichiarando di essere un povero ex soldato e boscaiolo fornendo il falso nome di Vincenzo da Gusmé. L'imputato fu messo subito a confronto con il figlio Paolo, anche lui agli arresti, cercando anche in questo caso di farla franca fingendo di non conoscerlo. Il Capitano di Giustizia ordinò allora la prima delle torture al quale verrà sottoposto il brigante: l'ustione dei piedi, al quale l'efferato omicida non riuscì a resistere a lungo, cominciando la confessione di anni di delitti e rapine, archibugiate, pugnalate, strangolamenti. Circa trecento omicidi furono quelli confessati da Legorino, che dichiarò anche la sepoltura di tutti i corpi delle vittime sotto la terra del bosco della Merlata. Mentre Giacomo Legorino deponeva di fronte al giudice, il complice Battista Scorlino era ancora in latitanza. L'11 maggio 1566, verso sera, Giulio da Modena fu raggiunto nella sua abitazione da un drappello di soldati, che gli comunicarono l'arresto del secondo brigante dall'altra parte della città rispetto a Villapizzone, presso la Porta Vercellina. Portato dinnanzi al tribunale come il socio, la scena si ripeté con mistificazioni e false deposizioni, che durarono ben poco grazie al confronto col complice ormai crollato. Le sevizie seguite alle confessioni confermarono gli omicidi compiuti dalla banda tra il 1558 e il 1566, la sentenza di morte era scontata. La fine della banda della Merlata fu alquanto macabra. I due capibanda furono trascinati a terra legati alla coda di due cavalli in corsa fino alla Cagnola, quindi furono mutilati e appesi alla ruota della tortura. Dopo qualche ora Giacomo Legorino era ancora vivo. Come da regolamento, per porre fine alle sofferenze il bandito fu sgozzato con un fendente alla gola. La cascina Melgasciada, covo della banda, fu demolita nel 1959 per fare spazio ad un edificio scolastico. Durante i lavori, quattro secoli dopo i fatti, la leggenda riprese vigore perché i muratori trovarono un po' dappertutto i segni della ricerca del mitico tesoro di Legorino e Scorlino da parte di ignoti. Naturalmente questa fu senza esito, ma gli operai riuscirono a vedere il quadro "naif" che raffigurava i due briganti a riposo sotto le frasche della cascina oggi scomparsa, inghiottita negli anni del "boom" dalla città in espansione.Veneto: Giuseppe Bedin.In questo caso l'epopea brigantesca si consumò negli anni trenta del ventesimo secolo a Monselice, comune rurale a Sud di Padova. Qui nel 1901 da una famiglia contadina (come la maggior parte degli abitanti del paese) nasceva Giuseppe Bedin, destinato a diventare uno dei banditi più noti d'Italia grazie anche alle innumerevoli pagine di cronaca che narrarono le sue gesta di fuorilegge durante il ventennio. La sua fu una gioventù di ordinaria povertà, condivisa con molti coetanei in quel veneto misero e contadino da poco flagellato dalle rovine della Grande Guerra di cui era stato teatro. Il giovane Bepi si dimostra sveglio, fervente cattolico ed in grado di leggere e scrivere, presta regolarmente servizio militare nel 1922 e poco più tardi segue molti dei suoi conterranei nella via obbligata all'emigrazione, per lavorare in una miniera francese dalla quale farà ritorno dopo avere avuto il primo figlio da una compaesana. Il lavoro principale della giovane famiglia di Bepi a Monselice era quello di riuscire a mettere insieme il pasto quotidiano con molta difficoltà, tra il lavoro nei campi e quello occasionale come manovale in edilizia . Per arrotondare la paga misera, Bedin trovò nella allora fiorente borsa nera una soluzione nel quale si rivelò subito abile, ma che aprirà per lui la strada verso il crimine. Dopo il furto di una motocicletta per il quale sarà condannato, conoscerà per la prima volta il carcere dove a più riprese costruì la sua fama di brigante protettore dei poveri, attirando a sé con una buona dose di carisma i suoi futuri complici. Tra i capibanda figurò Severino Urati, conosciuto in carcere a Verona e compagno di una delle molteplici evasioni di cui il Robin Hood di Monselice si rese protagonista negli anni trenta. Urati sarà in seguito il cassiere della banda, abile nel ripulire i proventi delle rapine mediante investimenti in beni mobili e immobili, oltre che a maneggiare e usare senza scrupoli le armi. Nativo del mantovano, su di lui pendeva una condanna per omicidio durante una rissa. Passò anni alla macchia prima di conoscere Bedin in carcere nel 1935. Il terzo uomo fu Clemente Lampioni, anche lui con l'esperienza di una miniera belga alle spalle e varie condanne per furto. Dopo la fuga dal carcere, l'organizzazione criminale prese piede, concentrata negli anni tra il 1936 e il 1939 con un'escalation di colpi spettacolari e organizzati alla perfezione. Se dalla parte dei compaesani il mito di Bedin cresceva esponenzialmente, dall'altra le istituzioni fasciste, impegnate in quegli anni nella normalizzazione e nella lotta alla criminalità (un esempio su tutti il contrasto alla mafia da parte del prefetto di ferro Mori) non potevano più tollerare le scorrerie impunite dei banditi veneti. Senza tralasciare peraltro la scia di sangue che la banda lasciò dietro di sé durante i colpi: A Treviso sotto le raffiche dei banditi di Monselice era morto un maresciallo dei Carabinieri. I colpi messi a segno dalla banda furono moltissimi e non soltanto in Veneto. Muovendosi con automobili veloci e armi automatiche come i coevi gangster americani, rapinarono in Emilia, in Lombardia e in Piemonte. A Monselice i banditi godevano di stima e protezione, anche perché Bedin dispensava ai più bisognosi regali di un certo valore come attrezzi agricoli, capi di bestiame, alimentari. Molti furono i terreni e le cascine acquistate e affidate a prestanomi dal braccio destro Urati, che contribuirono ad alimentare il patrimonio ormai molto consistente dei briganti. Ma il colpo dei colpi fu realizzato nel 1938 a Milano. Allenati alla rapina delle paghe degli operai di diverse aziende venete, Bedin e i suoi uomini decisero di puntare al cuore dell'industria italiana. L'obiettivo era nientemeno che l'ufficio paghe della Pirelli alla Bicocca, al quale i banditi ebbero accesso e la giusta soffiata da una talpa interna alla fabbrica. Il colpo andrà a segno offrendo ai briganti un bottino stellare (860 mila lire, molto più di quanto sottratto anni dopo nella famosa rapina di via Osoppo a Milano) ma le conseguenze di questa clamorosa sfida al patrimonio industriale italiano faranno si che Mussolini stesso si muovesse per porre fine ai crimini della banda, mettendo alle calcagna dei veneti due tra gli uomini migliori delle forze dell'ordine. A Milano si occupò del caso il brigadiere Giuseppe Crespi detto Maciste, sia per la stazza (era alto quasi due metri) che per la risolutezza nello svolgimento delle indagini. Fu lui a scoprire la talpa della Pirelli, il fattorino Biasi, in casa del quale il poliziotto trovò nascosta dietro ad un quadro la paga per il favore a Bedin in banconote da 500 lire. Tornati in Veneto, Bedin e i suoi continuarono le attività criminali e la bella vita, spostandosi tra le cascine e le case parrocchiali che Bedin ben conosceva a causa della sua profonda fede cattolica e per la riconoscenza di certi parroci per la sua generosità verso i poveri. Addirittura il bandito riuscì a presenziare alle esequie della madre vestito da carabiniere, mentre in altre occasioni si mischiò tra la gente di paese vestito da donna. Il romanzo criminale di Monselice si avviò alla conclusione l'anno successivo, il 1939. Sulle tracce delle indagini iniziate dal maresciallo Maciste si inserì un altro mastino direttamente voluto dal Duce. Si trattava dell'ispettore di Polizia Giuseppe Gueli, che senza troppe remore fece uso di metodi non ortodossi su molti compaesani di Bedin (Gueli sarà condannato dopo la guerra a 8 anni di carcere per le torture messe in atto quando era a capo dell'Ispettorato speciale di P.S. per la Venezia-Giulia). Sotto tortura, alcuni degli interrogati cominciarono a cedere e il cerchio attorno alla banda si strinse sempre di più fino all'epilogo che, considerati i protagonisti delle due parti, fu bagnato dal sangue. Bepi Bedin fu circondato dalle forze dell'ordine mentre si trovava nascosto nella canonica in località Casoni di Mussolente, piccolo borgo nei pressi di Bassano del Grappa. Nonostante fosse braccato, Bepi non era abituato alla resa e cercò di vendere cara la pelle. Armato di revolver riuscì a correre fuori dalla casa parrocchiale nonostante un colpo sparato dai Carabinieri lo avesse ferito ad una spalla. Cercò l'estrema resistenza asserragliandosi in una casa colonica poco distante dove ebbe una colluttazione con i figli del proprietario, che solo per un caso non rimasero uccisi dai colpi di pistola esplosi dal malvivente. Pochi minuti dopo, raggiunto da ingenti forze di polizia cadde sotto i colpi esplosi da un agente che lo centrarono in viso e nel collo, freddandolo sul colpo. Quando lo perquisirono, gli inquirenti gli trovarono in tasca, oltre a banconote di diverso taglio, le immaginette dei Santi a cui Bepi era devoto sin dall'infanzia. Era il 4 aprile 1939 e nel pomeriggio del giorno stesso cadde sotto i colpi delle forze dell'ordine anche il socio Severino Urati (la mente finanziaria dal grilletto facile) durante uno scontro a fuoco nella sua terra d'origine, il Mantovano. La banda perdeva in un solo giorno il capo carismatico e il suo braccio destro e di lì a poco sarebbero stati arrestati anche gli altri membri di spicco della banda di Bedin. Il suo nome rimase tuttavia impresso nella memoria collettiva della zona e passò anche per gli anni di guerra. Molti furono i membri delle brigate partigiane che usarono il nome del bandito veneto e terminata la guerra saranno le voci dei bambini a tramandarne il ricordo nei loro giochi quotidiani. Nella persistente miseria del Veneto del dopoguerra, si giocava a "guardie e Bedin".
Romano Prodi premier nel 2006 (Ansa)
L’editorialista di Repubblica ha citato Giuseppe Conte spiegando che la nuova norma sarebbe peggiore della legge truffa e della legge Acerbo del 1923 che concesse la maggioranza alla lista di Benito Mussolini. «Stiamo virando dalle democrazie rappresentative alle autocrazie elettive», ha affermato in diretta un preoccupatissimo Giannini. A suo dire, esiste un piano di Giorgia Meloni che coincide con quello di Donald Trump in cui la riforma della giustizia, il premierato e, appunto, la legge elettorale si incastrano quali tasselli di un mosaico eversivo. Il centrodestra sarebbe, dunque, alla «ricerca di pieni poteri» e usa la legge elettorale come «scorciatoia per raggiungerli il prima possibile». Tale norma, infatti, «consente alla maggioranza di prendere tutto, dove tutto significa non solo il Parlamento, ma anche le nomine e le elezioni di tutti gli organi di garanzia, la Corte costituzionale, il Csm e la presidenza della Repubblica».
Ed eccolo qui il vero problema. La sinistra accusa Meloni di voler mettere le mani sul Colle e questo è semplicemente inaccettabile per un sola, cristallina ragione: il Quirinale è prerogativa progressista, non sia mai che vi salga qualcuno su cui il Partito democratico non abbia fatto calare la sua entusiastica benedizione. Per questo motivo i dem dichiarano ai quattro venti che il testo di legge è «inaccettabile» e «irricevibile». Elly Schlein ripete che «può essere molto distorsivo della rappresentanza e con premi alti e senza limiti. Quindi, da questo punto di vista», ribadisce il segretario del Pd, «rischiano di consegnare a chi può vincere le elezioni anche la possibilità di eleggere da solo il presidente della Repubblica».
Ovviamente, queste grida scomposte e allarmate sono strumentali e piuttosto pretestuose. Posto che, come notava qualcuno, questa legge potrebbe persino giovare alla Schlein, garantendole, in mancanza di altri leader credibili, di inchiodarsi alla guida del suo partito, non è affatto detto che una nuova norma avvantaggi la destra. Anzi, la storia recente insegna che le leggi elettorali pensate da una maggioranza per assicurarsi maggiore stabilità non hanno mai funzionato granché, rivelandosi più spesso un boomerang.
In ogni caso, è bene rinfrescarsi un poco la memoria a proposito di alchimie elettorali, premi di maggioranza e pieni poteri, anche solo per svelare l’ipocrisia democratica sul tema. Quelli che ora berciano di deriva autoritaria e si struggono per il premio di maggioranza abbondante, in passato hanno profittato eccome dei premi offerti dalle leggi elettorali vigenti. Nel 2006, per dire, si andò a votare con il famigerato Porcellum di cui va riconosciuta la paternità a Roberto Calderoli. Quella norma prevedeva un premio di maggioranza su base nazionale per la Camera e regionale per il Senato. Il partito più votato risultò essere Forza Italia, ma vinse l’Unione di Romano Prodi con un margine risicatissimo, grazie ai famigerati voti esteri. Alla Camera, il centrosinistra prese il 49,81% dei voti contro il 49,74% del centrodestra. Grazie al premio, la sinistra prese 67 seggi in più e tanti saluti. Romano Prodi divenne presidente del Consiglio e, a stretto giro, la sinistra elesse Giorgio Napolitano al Quirinale. Nessuno si fece scrupoli, non ci furono pianti sulla deriva autoritaria e la legge elettorale pensata a destra alla fine fu un bel regalo per la sinistra. Altro giro e altro regalo nel 2013, di nuovo con il Porcellum. Il partito più votato alla Camera risultò essere il Movimento 5 stelle, che si era sempre opposto al Porcellum giudicandolo addirittura immorale. Il centrosinistra prese il 29,54% dei voti, il centrodestra il 29,18%, i grillini arrivarono al 25,5%. Grazie al premio previsto dalla legge, la sinistra ottenne 220 seggi in più e, dunque, la maggioranza alla Camera e, dato che Pier Luigi Bersani non fu in grado di trovare un accordo con i pentastellati, nacque il governo di larghe intese guidato da Enrico Letta. Il Pd, insomma, si prese senza restarci troppo male la presidenza del Consiglio e di lì a un paio di anni circa si avviò serenamente a scegliere Sergio Mattarella quale presidente della Repubblica.
In buona sostanza, quando c’è stato da prendere il potere, il Partito democratico non si è mai fatto troppi scrupoli, e non si è dato gran pena per il rispetto delle decisioni degli elettori, la concentrazione dei poteri. Come al solito, la deriva autoritaria non è deriva e non è autoritaria se favorisce il Pd.
Continua a leggereRiduci
Il Bitcoin è scivolato sotto la soglia psicologica dei 64.000 dollari, bruciando - secondo i dati riportati da Bloomberg - qualcosa come 128 miliardi di capitalizzazione in poche ore. Ethereum ha fatto anche peggio, con cadute vicine all’8%.
Gli analisti lo chiamano «risk-off». Vuol dire che quando iniziano a volare i missili gli investitori cambiamo spalla al fucile. Vista la situazione puntano sulla concretezza dell’oro, che comunque è salito molto.
Il punto non è tanto quanto petrolio produce l’Iran - circa 3,45 milioni di barili al giorno, meno del 3% dell’offerta globale secondo la International Energy Agency.
Il punto è dove passa il petrolio degli altri. Il collo di bottiglia si chiama Stretto di Hormuz di cui ieri i pasdaran iraniani hanno annunciato la chiusura. Da lì transita circa un quinto dell’offerta mondiale di greggio: qualcosa come 21 milioni di barili al giorno provenienti da tutto il Golfo. Non è una rotta. È la rotta. Alternative? Poche, complicate e molto più costose. Tradotto: se Hormuz si inceppa, il prezzo dell’energia non sale. Vola.
Secondo Capital Economics, citata dal Wall Street Journal, il blocco del traffico nello stretto potrebbe spingere il greggio fino a 100 dollari al barile, trascinando anche il gas naturale.
Uno scenario che aggiungerebbe tra lo 0,6% e lo 0,7% all’inflazione globale media. In altre parole: proprio quello che le banche centrali non volevano vedere mentre iniziavano a sognare il taglio dei tassi. Il rischio - sottolinea ancora il giornale americano - è quello di mandare all’aria una convalescenza economica già fragile, rallentata da guerre commerciali e crescita asfittica. Paradossalmente, la perdita dei barili iraniani, da sola, sarebbe gestibile. Analisti di Ubs osservano che Arabia Saudita e altri produttori potrebbero compensare eventuali stop temporanei. In questo senso una prima risposta potrebbe arrivare dalla riunione dei Paesi Opec di oggi. Il vero problema è l’effetto domino: assicurazioni marittime che esplodono, navi che evitano l’area, traffico che rallenta anche senza un blocco formale. Negli anni Ottanta Teheran minò quelle acque: i mercati se lo ricordano benissimo. Un petrolio stabilmente a tre cifre significherebbe inflazione di ritorno, proprio quando sembrava sconfitta. Banche centrali costrette a fermare, o invertire, i tagli dei tassi. Crescita rallentata in Europa e Stati Uniti. Nuova pressione sui Paesi emergenti importatori di energia. In sintesi: la geopolitica che si trasforma immediatamente in macroeconomia.
La globalizzazione digitale, l’Intelligenza artificiale, la finanza algoritmica. Tutto modernissimo. Poi basta un tratto di mare tra Iran e Oman per ricordare che l’economia mondiale funziona ancora con logiche ottocentesche: navi, petrolio, strozzature fisiche. Le criptovalute dovevano essere il futuro senza confini. Alla prima crisi vera, hanno reagito come qualsiasi asset speculativo: scendendo. Il petrolio, invece, continua a fare quello che fa da un secolo: comanda. E oggi, più che nei palazzi della diplomazia, il destino dell’economia mondiale si decide lì, nello Stretto di Hormuz. Dove non passa solo il greggio. Passa il sangue dei mercati.
Continua a leggereRiduci
Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer (Ansa)
«A seguito della situazione in corso in Iran, lunedì convocherò un collegio speciale dei commissari», ha scritto su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Nelle stesse ore, la numero uno dell’esecutivo comunitario ha sottolineato che «per la sicurezza e la stabilità regionale è di fondamentale importanza che non si verifichi un’ulteriore escalation attraverso gli attacchi ingiustificati dell’Iran contro i partner della regione». Dalla Commissione Ue e dal Servizio europeo per l’azione esterna è arrivato anche l’ormai rituale invito alla «massima moderazione», al «pieno rispetto del diritto internazionale» e alla protezione dei civili. Il lessico è quello tipico delle crisi internazionali: «grande preoccupazione», «stabilità regionale», «de-escalation». Nessuna iniziativa diplomatica autonoma, insomma, ma l’annuncio di un collegio straordinario e l’ennesimo appello alla prudenza.
Leggermente diverso, almeno nelle forme, l’atteggiamento dei cosiddetti «volenterosi». Germania, Francia e Regno Unito hanno diffuso una dichiarazione congiunta in cui affermano di «condannare gli attacchi iraniani nella regione» e chiedono che Teheran «si astenga da ulteriori azioni destabilizzanti e torni al tavolo dei negoziati». I tre leader precisano di «non aver partecipato ai raid», ma di restare «in stretto coordinamento con gli alleati». È un ricompattamento che mira a dare un segnale politico, pur muovendosi dentro il perimetro atlantico e, di fatto, oltre Bruxelles, ancora una volta scavalcata. Il premier britannico Keir Starmer ha inoltre confermato che «jet britannici sono stati coinvolti in operazioni di difesa degli alleati», chiarendo che Londra non ha preso parte all’attacco. Anche Berlino si è mossa sul piano dei contatti diretti: il cancelliere Friedrich Merz ha parlato al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu nelle ore successive all’inizio dell’operazione, secondo quanto riferito da fonti del governo tedesco. Parigi, dal canto suo, ha chiesto la convocazione urgente del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di «gravi conseguenze per la pace e la sicurezza internazionali» e ha sollecitato una ripresa dei negoziati sul programma nucleare e sui missili iraniani, insistendo sulla necessità di «evitare un allargamento del conflitto» e di «privilegiare la via diplomatica».
Posizioni ritenute evidentemente morbide dal repubblicano Lindsey Graham, che ha definito «un eufemismo» dire di essere deluso dalla posizione europea, sostenendo che le democrazie occidentali «perdono la passione per la giustizia e il senso del bene e del male quanto più l’evento si svolge lontano dalle loro coste».
Ben diverse le reazioni di Mosca e Pechino. Il ministero degli Esteri russo ha definito i raid «un atto di aggressione armata non provocata», denunciando il rischio di una «pericolosa escalation» e chiedendo la convocazione del Consiglio di sicurezza dell’Onu.
Anche la Cina si è detta «fortemente preoccupata» e ha chiesto «l’immediata cessazione delle operazioni militari», richiamando al rispetto della «sovranità, sicurezza e integrità territoriale» dell’Iran. Pechino ha invitato tutte le parti a «evitare ulteriori escalation» e a tornare «al dialogo e ai negoziati» per salvaguardare pace e stabilità in Medio Oriente.
Continua a leggereRiduci