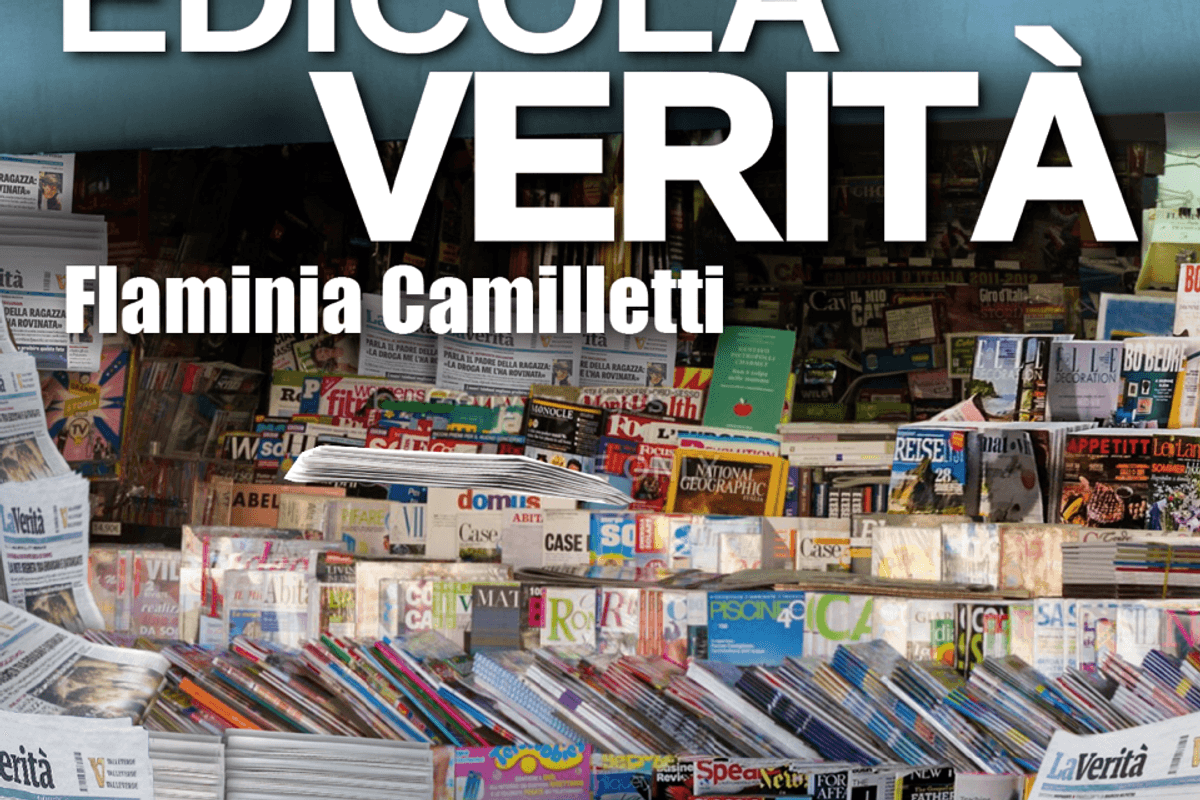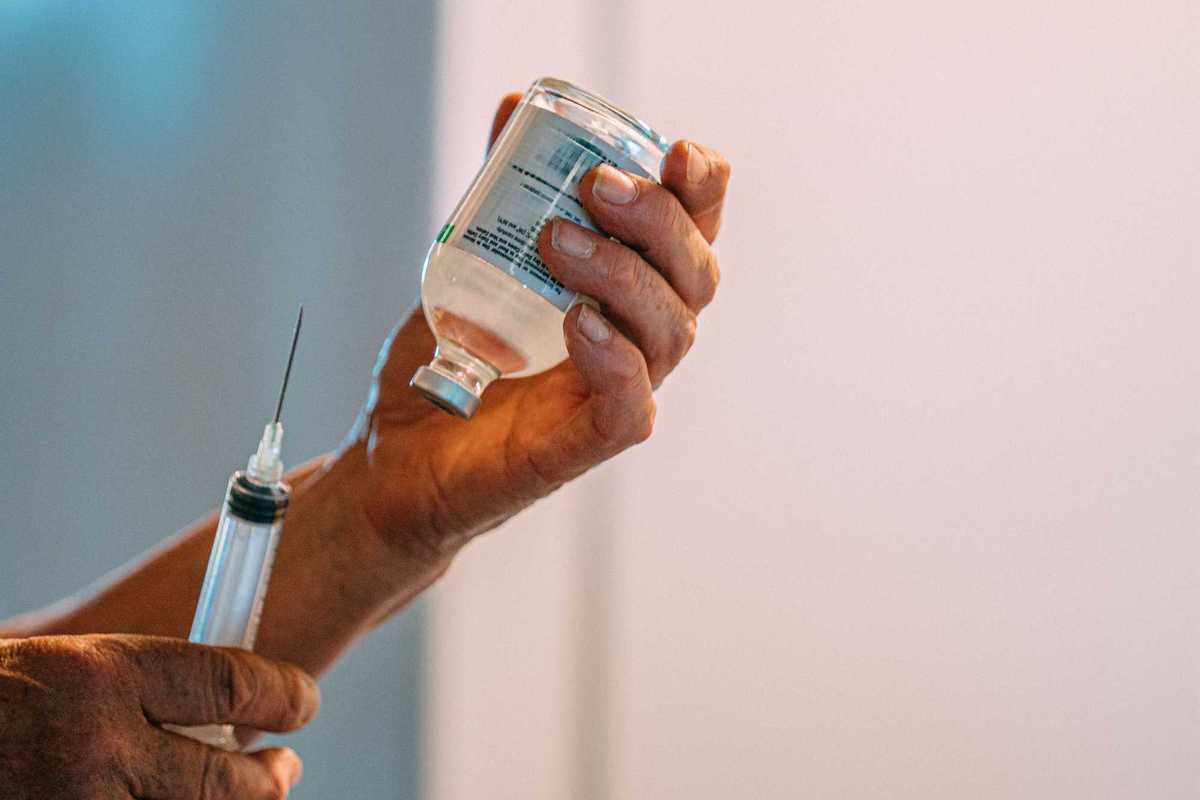True
2023-01-07
Basta col vaccino ai ragazzi. Lo studio che toglie i dubbi
Ansa
Quella della proteina Spike - presente sia nel Sars-Cov-2, sia nei vaccini a mRna - capace di provocare danni all’organismo sarebbe, stando agli autoproclamati fact checkers, una bufala antiscientifica. Qualcuno avvisi la rivista Circulation, prima in assoluto per fattore d’impatto nel settore delle ricerche sul cuore e il sistema cardiovascolare: ha appena pubblicato, infatti, uno studio condotto da Harvard medical school e Mit, su giovanissimi pazienti ricoverati in due ospedali di Boston, che individua proprio nella Spike la causa delle miocarditi post iniezione nei bimbi e negli adolescenti. Per giungere a questa conclusione, gli autori hanno confrontato i campioni di sangue dei vaccinati sani, con quelli, raccolti da gennaio 2021 a febbraio 2022, di 16 individui, tra 12 e 21 anni, colpiti da miocardite in seguito alle inoculazioni con i farmaci a Rna messaggero. E hanno riscontrato, in questi ultimi, degli alti livelli di Spike libera, cioè non aggredita da anticorpi specifici. «La proteina», spiega il virologo Francesco Broccolo, dell’Università del Salento, «non è legata agli anticorpi neutralizzanti che circolano nel sangue, che nei bambini e nei giovani adulti non si sono formati dopo la prima dose. Negli adulti» sottoposti al secondo shot, «la risposta immunitaria è più forte e gli anticorpi riescono a legare la proteina S, mentre nei bambini che sviluppano la miocardite, la proteina Spike resta libera, senza legarsi agli anticorpi neutralizzanti». È così che essa attiva «l’infiammazione che sta alla base» del danno cardiaco.
È interessante anche notare le analogie che gli autori hanno trovato con la Mis-c, la sindrome infiammatoria multisistemica. Pericoloso strascico del Covid: virostar e pediatri, alle nostre latitudini, l’avevano utilizzata per spingere i genitori a portare i figli negli hub. Le concentrazioni del frammento S1 della Spike e della proteina stessa, nei campioni presi dai bimbi colpiti da miocardite e da quelli affetti da Mis-c, erano pressoché identiche. A cambiare erano i livelli di troponina (più elevati nei primi) e quelli della proteina C-reattiva (più elevati nei secondi), che viene di solito sintetizzata durante uno stato infiammatorio.
Seppur rari - intorno a uno o due su 100.000 dosi - e per lo più risolvibili, i casi di miocardite possono comunque condurre a conseguenze gravi. Lo dimostrano le autopsie svolte in Germania e descritte in un articolo del Clinical research in cardiology a inizio dicembre, su malcapitati letteralmente fulminati da questa complicanza post vaccino. Alcuni non avevano avuto nemmeno il tempo di chiamare i soccorsi.
Broccolo insiste: «Serve un cambiamento di paradigma nei confronti delle vaccinazioni e delle numerose varianti. È ormai chiaro, per esempio, che il vaccino è particolarmente necessario per gli anziani e i fragili in quanto protegge dalle forme gravi della malattia e non dall’infezione». Gli autori del paper uscito su Circulation sostengono che restano invariate tutte le valutazioni sul rapporto rischi-benefici delle punture. Ma è sempre più chiaro che, nella popolazione giovane, ormai ben immunizzata, questo dogma andava rimesso in discussione parecchio tempo fa. Già quando il governo Draghi, al contrario, ricattava i ragazzini, praticamente obbligandoli ad accettare il booster. Pena, il rischio di finire in Dad o l’esclusione dalle attività sportive.
Lo studio americano, che ha implicazioni importanti sulle politiche sanitarie nei confronti degli under 30, riapre, più in generale, la questione della pericolosità della Spike.
Sul tema, aveva fatto scuola un’indagine di Cell, risalente al marzo 2022, che dimostrava come la proteina potesse rimanere in circolo per due mesi dopo la vaccinazione. In un loro intervento di settembre 2022, sul sito della rivista, Marco Cosentino e Franca Marino avevano citato un’altra ricerca: stavolta, la Spike era stata identificata nei campioni di sangue dei vaccinati addirittura sei mesi dopo l’iniezione. C’erano, inoltre, le analisi svolte su una donna che aveva sofferto di trombocitopenia indotta dal vaccino a mRna: i livelli di Spike nel suo plasma erano risultati 100 volte maggiori che nei soggetti inoculati senza effetti collaterali. Né sarebbero risultate sostanziali differenze, nelle concentrazioni della proteina, tra le persone infettate dal virus e quelle che hanno porto il braccio. La conclusione di Cosentino e Marino era esplicita: «I vaccini a mRna per il Covid-19, in alcune circostanze, stimolano elevate ed eventualmente tossiche quantità di Spike in organi e tessuti, che, a loro volta, la mettono in circolazione».
Non finisce qui. La famigerata proteina è stata collegata, in un paper dello scorso settembre, pubblicato da Clinical infectious diseases, e in uno di Molecular neurobiology, del 2021, alla malattia post acuta da coronavirus (Pasc). Ovvero, il temutissimo long Covid. La ciliegina della torta l’ha piazzata un preprint freschissimo, di questi giorni: «La proteina Spike», annotano i firmatari, «potrebbe causare fibrosi e la menomazione della contrattilità miocardica» negli obesi. Pure questa, una condizione che si è verificata nella Pasc.
Gli scienziati che hanno lavorato a quegli articoli si erano occupati di pazienti contagiati. Ma visto che i meccanismi alla base del danno sono simili a quelli della Spike che viene inoculata attraverso il vaccino, è lecito domandarsi se, a fronte di una possibile permanenza nell’organismo della proteina per mesi e mesi dopo la puntura, gli stessi effetti collaterali siano ugualmente riconducibili all’impiego dei medicinali a Rna messaggero.
Aver preso sul serio certi dubbi, magari, ci avrebbe aiutato a limitare le reazioni avverse. Se la medicina non è una religione, degli effetti collaterali dei farmaci si dovrebbe parlare apertamente, anziché regalare il monopolio della discussione ai vituperati «complottisti». Era l’agosto del 2021, allorché il Journal of biological regulators suggeriva di «intervenire con l’uso di combinazioni di antiossidanti, […] in aggiunta ai vaccini e ai farmaci antinfiammatori, per prevenire l’azione nociva della proteina Spike». I nostri tecnici leggevano le riviste scientifiche? O erano troppo impegnati in tv?
Avrebbe giovato un po’ meno zelo nell’inseguire con la siringa i giovani. E adesso? Ce scurdammo ’o ppassato? Ci proviamo. Ma un adolescente con una fibrosi del miocardio farà fatica a dimenticare.
Rispunta l’ivermectina, da profilassi
Potrebbe prevenire il contagio da Sars-Cov2 meglio della quarta dose di vaccino a mRna, ma il condizionale è d’obbligo perché il dato, che riguarda la tanto controversa ivermectina, arriva da uno studio aziendale di fase due, il cui scopo è testare la sicurezza ed efficacia del prodotto in un campione piccolo. Come spiega la farmaceutica MedinCell, la somministrazione dell’antiparassitario, per 28 giorni in 200 dei 399 partecipanti alla ricerca, ha ridotto del 72% l’infezione da Covid rispetto ai non trattati. Il risultato si è ottenuto testando tutti i soggetti - non vaccinati, negativi al momento dell’arruolamento - entro cinque giorni da uno stretto contatto documentato con una persona positiva al Sars-CoV-2 confermata da tampone molecolare (Pcr). In questo, l’antiparassitario sarebbe quindi più efficace del vaccino a mRna che, contrariamente a quanto annunciato inizialmente, previene circa il 50% dei contagi. L’aspetto non è secondario perché le nuove varianti si trasmettono molto più facilmente e la ricerca, altro dato da sottolineare, si è svolta tra marzo e novembre 2022, cioè quando prevaleva Omicron.
Come dichiara la stessa azienda francese, lo studio (Saive) non intende testare l’impiego di ivermectina nella cura del Covid, ma rientra nel programma di sviluppo di una formulazione iniettabile a lunga durata d’azione per un uso sicuro nella prevenzione dell’infezione da Covid-19, per settimane o mesi. Se ulteriori studi dovessero confermare i risultati ottenuti, il farmaco potrebbe rivelarsi utile contro il contagio, punto molto critico dei vaccini a mRna, soprattutto nelle persone fragili.
Uno studio canadese pubblicato a luglio sul British Medical Journal ha verificato l’efficacia della quarta dose, rispetto alla terza e all’assenza di vaccino, negli anziani di strutture assistenziali (Rsa), tra gennaio e aprile 2022, con Omicron dominante. Rispetto a chi aveva la terza dose da più di 84 giorni, in chi aveva fatto la quarta da oltre sette giorni, l’efficacia era superiore del 19% contro l’infezione, del 31% contro l’infezione sintomatica e del 40% contro esiti gravi. A confronto con i non vaccinati, la quarta dose riduceva del 49% il rischio di infezioni asintomatiche, del 69% le sintomatiche e dell’86% le forme gravi. Anche una ricerca su The Lancet Respiratory, a settembre, afferma che i vaccini a mRna «non sono molto efficaci nel fermare la trasmissione o un’infezione lieve, specialmente con Omicron».
In ogni caso, restano i dubbi sul possibile impiego di ivermectina nel trattamento del Covid. Una revisione su 11 studi, pubblicata a giugno dall’autorevole Cochrane Library, conclude che «non sono state trovate prove a sostegno dell’uso» dell’antiparassitario «per il trattamento di Covid-19. La base delle evidenze è leggermente migliorata in questo aggiornamento, ma è ancora limitata» e «si attendono i risultati di ulteriori 31 studi in corso».
Sull’impiego dell'ivermectina, un vecchio farmaco utilizzato per una vasta gamma di infezioni parassitarie intestinali e, in anni più recenti, con più ampie potenziali indicazioni come la scabbia, i primi studi nel Covid risalgono alla primavera del 2020, quando si è dimostrata l’efficacia nel ridurre la carica virale del 99,98% in 48 ore in cellule coltivate in vitro infettate da Sars-Cov2. Il passaggio però alla fase clinica non ha dato i risultati sperati nel prevenire, nei positivi al Covid, il rischio di sviluppo della forma grave. Attualmente, l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) raccomanda che il farmaco sia impiegato nel Covid solo all’interno di studi clinici controllati.
Continua a leggereRiduci
Harvard e Mit hanno individuato nella proteina Spike presente nei farmaci a Rna messaggero la causa delle miocarditi post iniezione nei bimbi e negli adolescenti. Francesco Broccolo: «Serve un cambio di paradigma».Il controverso farmaco antiparassitario non è stato utilizzato per la cura del Covid ma come prevenzione per i contagi. E ha dato risultati migliori della quarta puntura.Lo speciale contiene due articoli.Quella della proteina Spike - presente sia nel Sars-Cov-2, sia nei vaccini a mRna - capace di provocare danni all’organismo sarebbe, stando agli autoproclamati fact checkers, una bufala antiscientifica. Qualcuno avvisi la rivista Circulation, prima in assoluto per fattore d’impatto nel settore delle ricerche sul cuore e il sistema cardiovascolare: ha appena pubblicato, infatti, uno studio condotto da Harvard medical school e Mit, su giovanissimi pazienti ricoverati in due ospedali di Boston, che individua proprio nella Spike la causa delle miocarditi post iniezione nei bimbi e negli adolescenti. Per giungere a questa conclusione, gli autori hanno confrontato i campioni di sangue dei vaccinati sani, con quelli, raccolti da gennaio 2021 a febbraio 2022, di 16 individui, tra 12 e 21 anni, colpiti da miocardite in seguito alle inoculazioni con i farmaci a Rna messaggero. E hanno riscontrato, in questi ultimi, degli alti livelli di Spike libera, cioè non aggredita da anticorpi specifici. «La proteina», spiega il virologo Francesco Broccolo, dell’Università del Salento, «non è legata agli anticorpi neutralizzanti che circolano nel sangue, che nei bambini e nei giovani adulti non si sono formati dopo la prima dose. Negli adulti» sottoposti al secondo shot, «la risposta immunitaria è più forte e gli anticorpi riescono a legare la proteina S, mentre nei bambini che sviluppano la miocardite, la proteina Spike resta libera, senza legarsi agli anticorpi neutralizzanti». È così che essa attiva «l’infiammazione che sta alla base» del danno cardiaco.È interessante anche notare le analogie che gli autori hanno trovato con la Mis-c, la sindrome infiammatoria multisistemica. Pericoloso strascico del Covid: virostar e pediatri, alle nostre latitudini, l’avevano utilizzata per spingere i genitori a portare i figli negli hub. Le concentrazioni del frammento S1 della Spike e della proteina stessa, nei campioni presi dai bimbi colpiti da miocardite e da quelli affetti da Mis-c, erano pressoché identiche. A cambiare erano i livelli di troponina (più elevati nei primi) e quelli della proteina C-reattiva (più elevati nei secondi), che viene di solito sintetizzata durante uno stato infiammatorio. Seppur rari - intorno a uno o due su 100.000 dosi - e per lo più risolvibili, i casi di miocardite possono comunque condurre a conseguenze gravi. Lo dimostrano le autopsie svolte in Germania e descritte in un articolo del Clinical research in cardiology a inizio dicembre, su malcapitati letteralmente fulminati da questa complicanza post vaccino. Alcuni non avevano avuto nemmeno il tempo di chiamare i soccorsi. Broccolo insiste: «Serve un cambiamento di paradigma nei confronti delle vaccinazioni e delle numerose varianti. È ormai chiaro, per esempio, che il vaccino è particolarmente necessario per gli anziani e i fragili in quanto protegge dalle forme gravi della malattia e non dall’infezione». Gli autori del paper uscito su Circulation sostengono che restano invariate tutte le valutazioni sul rapporto rischi-benefici delle punture. Ma è sempre più chiaro che, nella popolazione giovane, ormai ben immunizzata, questo dogma andava rimesso in discussione parecchio tempo fa. Già quando il governo Draghi, al contrario, ricattava i ragazzini, praticamente obbligandoli ad accettare il booster. Pena, il rischio di finire in Dad o l’esclusione dalle attività sportive.Lo studio americano, che ha implicazioni importanti sulle politiche sanitarie nei confronti degli under 30, riapre, più in generale, la questione della pericolosità della Spike. Sul tema, aveva fatto scuola un’indagine di Cell, risalente al marzo 2022, che dimostrava come la proteina potesse rimanere in circolo per due mesi dopo la vaccinazione. In un loro intervento di settembre 2022, sul sito della rivista, Marco Cosentino e Franca Marino avevano citato un’altra ricerca: stavolta, la Spike era stata identificata nei campioni di sangue dei vaccinati addirittura sei mesi dopo l’iniezione. C’erano, inoltre, le analisi svolte su una donna che aveva sofferto di trombocitopenia indotta dal vaccino a mRna: i livelli di Spike nel suo plasma erano risultati 100 volte maggiori che nei soggetti inoculati senza effetti collaterali. Né sarebbero risultate sostanziali differenze, nelle concentrazioni della proteina, tra le persone infettate dal virus e quelle che hanno porto il braccio. La conclusione di Cosentino e Marino era esplicita: «I vaccini a mRna per il Covid-19, in alcune circostanze, stimolano elevate ed eventualmente tossiche quantità di Spike in organi e tessuti, che, a loro volta, la mettono in circolazione».Non finisce qui. La famigerata proteina è stata collegata, in un paper dello scorso settembre, pubblicato da Clinical infectious diseases, e in uno di Molecular neurobiology, del 2021, alla malattia post acuta da coronavirus (Pasc). Ovvero, il temutissimo long Covid. La ciliegina della torta l’ha piazzata un preprint freschissimo, di questi giorni: «La proteina Spike», annotano i firmatari, «potrebbe causare fibrosi e la menomazione della contrattilità miocardica» negli obesi. Pure questa, una condizione che si è verificata nella Pasc. Gli scienziati che hanno lavorato a quegli articoli si erano occupati di pazienti contagiati. Ma visto che i meccanismi alla base del danno sono simili a quelli della Spike che viene inoculata attraverso il vaccino, è lecito domandarsi se, a fronte di una possibile permanenza nell’organismo della proteina per mesi e mesi dopo la puntura, gli stessi effetti collaterali siano ugualmente riconducibili all’impiego dei medicinali a Rna messaggero. Aver preso sul serio certi dubbi, magari, ci avrebbe aiutato a limitare le reazioni avverse. Se la medicina non è una religione, degli effetti collaterali dei farmaci si dovrebbe parlare apertamente, anziché regalare il monopolio della discussione ai vituperati «complottisti». Era l’agosto del 2021, allorché il Journal of biological regulators suggeriva di «intervenire con l’uso di combinazioni di antiossidanti, […] in aggiunta ai vaccini e ai farmaci antinfiammatori, per prevenire l’azione nociva della proteina Spike». I nostri tecnici leggevano le riviste scientifiche? O erano troppo impegnati in tv? Avrebbe giovato un po’ meno zelo nell’inseguire con la siringa i giovani. E adesso? Ce scurdammo ’o ppassato? Ci proviamo. Ma un adolescente con una fibrosi del miocardio farà fatica a dimenticare.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/basta-vaccino-ragazzi-studio-2659081255.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="rispunta-livermectina-da-profilassi" data-post-id="2659081255" data-published-at="1673034187" data-use-pagination="False"> Rispunta l’ivermectina, da profilassi Potrebbe prevenire il contagio da Sars-Cov2 meglio della quarta dose di vaccino a mRna, ma il condizionale è d’obbligo perché il dato, che riguarda la tanto controversa ivermectina, arriva da uno studio aziendale di fase due, il cui scopo è testare la sicurezza ed efficacia del prodotto in un campione piccolo. Come spiega la farmaceutica MedinCell, la somministrazione dell’antiparassitario, per 28 giorni in 200 dei 399 partecipanti alla ricerca, ha ridotto del 72% l’infezione da Covid rispetto ai non trattati. Il risultato si è ottenuto testando tutti i soggetti - non vaccinati, negativi al momento dell’arruolamento - entro cinque giorni da uno stretto contatto documentato con una persona positiva al Sars-CoV-2 confermata da tampone molecolare (Pcr). In questo, l’antiparassitario sarebbe quindi più efficace del vaccino a mRna che, contrariamente a quanto annunciato inizialmente, previene circa il 50% dei contagi. L’aspetto non è secondario perché le nuove varianti si trasmettono molto più facilmente e la ricerca, altro dato da sottolineare, si è svolta tra marzo e novembre 2022, cioè quando prevaleva Omicron. Come dichiara la stessa azienda francese, lo studio (Saive) non intende testare l’impiego di ivermectina nella cura del Covid, ma rientra nel programma di sviluppo di una formulazione iniettabile a lunga durata d’azione per un uso sicuro nella prevenzione dell’infezione da Covid-19, per settimane o mesi. Se ulteriori studi dovessero confermare i risultati ottenuti, il farmaco potrebbe rivelarsi utile contro il contagio, punto molto critico dei vaccini a mRna, soprattutto nelle persone fragili. Uno studio canadese pubblicato a luglio sul British Medical Journal ha verificato l’efficacia della quarta dose, rispetto alla terza e all’assenza di vaccino, negli anziani di strutture assistenziali (Rsa), tra gennaio e aprile 2022, con Omicron dominante. Rispetto a chi aveva la terza dose da più di 84 giorni, in chi aveva fatto la quarta da oltre sette giorni, l’efficacia era superiore del 19% contro l’infezione, del 31% contro l’infezione sintomatica e del 40% contro esiti gravi. A confronto con i non vaccinati, la quarta dose riduceva del 49% il rischio di infezioni asintomatiche, del 69% le sintomatiche e dell’86% le forme gravi. Anche una ricerca su The Lancet Respiratory, a settembre, afferma che i vaccini a mRna «non sono molto efficaci nel fermare la trasmissione o un’infezione lieve, specialmente con Omicron». In ogni caso, restano i dubbi sul possibile impiego di ivermectina nel trattamento del Covid. Una revisione su 11 studi, pubblicata a giugno dall’autorevole Cochrane Library, conclude che «non sono state trovate prove a sostegno dell’uso» dell’antiparassitario «per il trattamento di Covid-19. La base delle evidenze è leggermente migliorata in questo aggiornamento, ma è ancora limitata» e «si attendono i risultati di ulteriori 31 studi in corso». Sull’impiego dell'ivermectina, un vecchio farmaco utilizzato per una vasta gamma di infezioni parassitarie intestinali e, in anni più recenti, con più ampie potenziali indicazioni come la scabbia, i primi studi nel Covid risalgono alla primavera del 2020, quando si è dimostrata l’efficacia nel ridurre la carica virale del 99,98% in 48 ore in cellule coltivate in vitro infettate da Sars-Cov2. Il passaggio però alla fase clinica non ha dato i risultati sperati nel prevenire, nei positivi al Covid, il rischio di sviluppo della forma grave. Attualmente, l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) raccomanda che il farmaco sia impiegato nel Covid solo all’interno di studi clinici controllati.
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 16 febbraio con Flaminia Camilletti
iStock
Discorsi comprensibili, peccato che la pratica metta decisamente in crisi la teoria. Sul referendum, ad esempio, abbiamo raccontato il curioso e inopportuno attivismo di alcuni alti prelati che occupano i vertici della Conferenza episcopale italiana ed esprimono posizioni che mal si conciliano con la divisione dei ruoli richiamata da Avvenire. La sensazione, va detto, è che una parte molto visibile delle gerarchie ecclesiastiche sia pronta a schierarsi politicamente, e con decisione, anche su temi che non chiamano direttamente in causa la dottrina, ma che toccano una certa sensibilità progressista, come nel caso della battaglia per il No. E pure quando ci sono in gioco questioni rilevantissime per la Chiesa, che bussano con forza alla coscienza dei fedeli, quella sensibilità progressista torna a riaffacciarsi, tanto da far pensare che sia proprio quella a regolare la presenza pubblica della Cei.
Un esempio eclatante lo fornisce monsignor Francesco Savino, vicepresidente della Conferenza episcopale che non perde occasione per esporsi. Giusto ieri abbiamo ricordato che parteciperà al congresso di Magistratura democratica, fornendo un appoggio fattuale ai sostenitori del No al referendum sulla giustizia. Mesi fa si era schierato con ancora più forza sul referendum riguardante lavoro e cittadinanza, assumendo manco a dirlo una postura affine a quella della sinistra parlamentare. Non pago, ha deciso ieri di prendere parola pure sul fine vita. Argomento, quest’ultimo, su cui la Chiesa ha tutto il diritto e probabilmente anche il dovere di pronunciarsi, ma su cui dovrebbe valutare con grande attenzione le mosse, possibilmente evitando di accordarsi ancora una volta con il fronte sinistrorso. Ancora una volta, però, Savino sceglie una prospettiva di sicuro non ostile ai progressisti. Dichiara che «la legge sul fine vita non è più rimandabile», ben sapendo che non è affatto indispensabile legiferare sul tema e che anzi una nuova legge sarebbe la proverbiale apertura della porta che prelude allo spalancamento. Savino chiede un intervento legislativo basato «su un ampio consenso» fra le parti politiche, e benché insista molto sulla sacrosanta necessità di potenziare le cure palliative e l’assistenza, di fatto apre al suicidio assistito, scelta discutibile visto il ruolo che occupa. «Per evitare le fughe in avanti c’è bisogno di una legge nazionale», dice Savino. «Non per inseguire una circolare regionale ma per assumere una responsabilità che è nazionale. Il fine vita tocca il cuore dei diritti personalissimi, incrocia la coscienza e i profili di diritto penale, responsabilità professionale, livelli essenziali di assistenza e principio di uguaglianza. Il Paese non può permettersi geografie variabili». Si potrebbe obiettare che la geografia variabile viene creata proprio da chi ha cercato in ogni modo di forzare la normativa vigente, provando a scavalcare il Parlamento con ogni mezzo disponibile.
Il vicepresidente della Cei, per altro, legittima l’idea che basti un pronunciamento della Corte costituzionale per creare un diritto, convinzione che è contestabile in assoluto e che stupisce ancora di più se a farla propria è un uomo di Chiesa. Nulla di inedito, per carità, ma almeno ci venga risparmiata la pantomima sulla Chiesa che non deve «entrare in politica». La verità è che ci entra eccome, e fin troppo spesso da sinistra.
Continua a leggereRiduci
Un asso, un grande collaudatore, un pilota primatista e un eroe che salva un generale. E anche un incallito fumatore.
Gjader, Albania (Ansa)
In Italia, se hai una lunga carriera da delinquente alle spalle, lo Stato può arrivare a risarcirti fino a 700 euro. È il paradosso che emerge dopo la sentenza del Tribunale civile di Roma sul trasferimento nel centro albanese di Gjader, e che ha come protagonista Laaleg Redouane, cittadino algerino (classe 1970) irregolare nel nostro Paese da 30 anni. Non è un irregolare qualunque, ma un uomo il cui nome ricorre da anni negli archivi giudiziari e amministrativi italiani, con una lunga sequenza di almeno 23 condanne, svariati arresti, 11 detenzioni in carcere ma soprattutto espulsioni mai eseguite.
Redouane risulta entrato illegalmente in Italia dalla frontiera di Ventimiglia intorno al 1995. Da allora, secondo gli atti di polizia, ha fornito 13 diverse generalità, senza mai risultare titolare di un permesso di soggiorno regolare né iscritto alle anagrafi o alle liste di collocamento.
A suo carico figurano 23 sentenze di condanna emesse tra il 1999 e il 2023, oltre a numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, tra cui furto aggravato, spaccio di droga, rapina e lesioni, commessi prevalentemente in Liguria. È stato detenuto in almeno undici occasioni in diversi istituti di pena, da ultimo nella casa circondariale di Cuneo tra agosto 2024 e febbraio 2025.
Una data, più di altre, sintetizza il suo curriculum criminale: il 21 settembre 2015. Quel giorno, secondo quanto accertato dal Tribunale di Genova, Redouane aggredì una donna italiana colpendola con calci e pugni alla testa e agli arti superiori, provocandole un trauma cranico e un trauma oculare con una prognosi superiore ai 20 giorni. Per quell’episodio, commesso in regime di recidiva, venne condannato nel 2018 a nove mesi di reclusione. Non è l’unico capitolo rilevante. Nel tempo, l’uomo è stato anche destinatario di provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile: ha perso la potestà genitoriale e i figli sono stati affidati ai nonni, nell’ambito di un percorso di tutela già segnato da limitazioni e controlli.
È questo profilo che conduce Redouane nel circuito dei Cpr e, in particolare, a Gradisca d’Isonzo. Non un centro di prima accoglienza, ma una struttura che ospita prevalentemente stranieri irregolari destinatari di decreti di espulsione, spesso con precedenti penali e valutazioni di pericolosità sociale. Nel maggio 2021 era stato colpito da un decreto di espulsione del prefetto di Alessandria per motivi di sicurezza pubblica, con ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, mai ottemperato. Anche all’ingresso nel carcere di Cuneo, nel 2024, informato della possibilità di chiedere protezione internazionale, dichiarò di non voler presentare domanda d’asilo.
Da Gradisca parte il trasferimento verso Gjader, in Albania. È su quel passaggio che interviene il giudice Corrado Bile (noto per sentenze pro migranti e contro lo Stato italiano) del Tribunale civile di Roma, condannando il ministero dell’Interno al pagamento di 700 euro a titolo di risarcimento. Ma per comprendere davvero la portata della decisione occorre leggere con attenzione le motivazioni. La sentenza non dichiara illegittimo il centro albanese, né mette in discussione il quadro normativo che ne consente l’utilizzo.
Il giudice muove dall’assunto che il ricorrente fosse legittimamente trattenuto ai sensi dell’articolo 14 del Testo unico sull’immigrazione e che il trasferimento si inserisse nell’operatività delle strutture previste dal protocollo Italia-Albania, dalla legge di ratifica e dalla normativa attuativa. Non c’è, in altre parole, una bocciatura del «modello Albania».
La censura riguarda altro. Secondo il Tribunale, il trasferimento sarebbe avvenuto senza un provvedimento scritto e motivato e con una comunicazione non corretta sulla destinazione finale.
È su questo piano che il giudice individua una «condotta colposa» dell’amministrazione e una violazione delle regole di buona gestione amministrativa, ritenendo che le modalità del trasferimento abbiano inciso sulla sfera privata del ricorrente. Non vengono accertate violenze, né dichiarata illegittima la misura di trattenimento in sé. Anzi, la sentenza esclude che l’uso delle fascette o le limitazioni ai contatti possano essere considerate automaticamente illegittime, potendo essere giustificate da esigenze di sicurezza. E non ravvisa una compressione effettiva del diritto di difesa.
Il risarcimento nasce dunque da un vizio procedurale, non dalla scelta di utilizzare il centro di Gjader. È una tutela riconosciuta in via equitativa, ancorata all’idea che anche l’esercizio di un potere legittimo debba avvenire nel rispetto di forme e garanzie. Ma è proprio qui che il paradosso diventa evidente. La sentenza prescinde quasi completamente dalla storia giudiziaria dell’uomo, dalle condanne, dalle espulsioni reiterate, dalla perdita della potestà genitoriale già disposta da altri tribunali. Trasforma un errore procedurale in responsabilità civile, senza misurarsi fino in fondo con un contesto segnato da 30 anni di illegalità e recidiva.
Continua a leggereRiduci