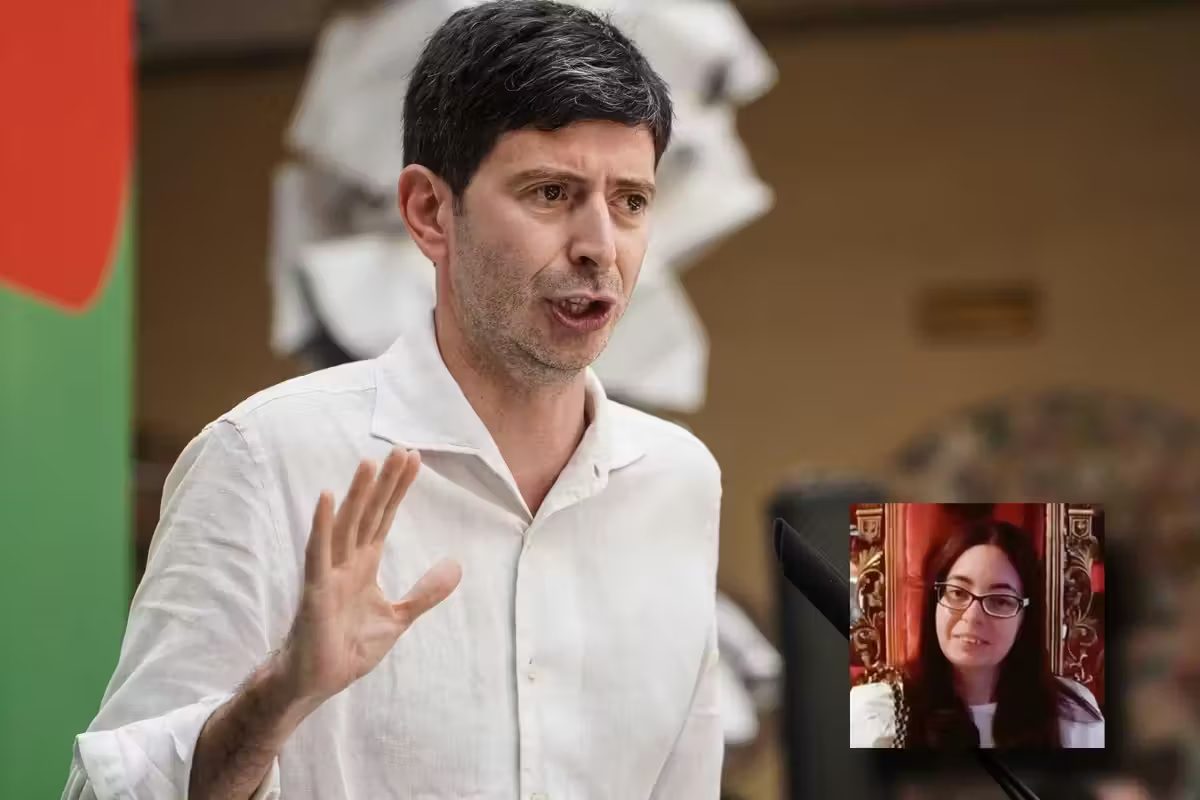Basta con i pregiudizi morali. L’Italia ha fatto sacrifici e ora va aiutata per davvero

Nelle trattative all'Eurogruppo orientate a decidere le soluzioni finanziarie da adottare per affrontare la crisi in atto, abbiamo notato alcuni pregiudizi in essere nei confronti del nostro Paese, anche in queste circostanze.
Sono emerse critiche, come al solito riferite al tema della nostra instabilità politica e del nostro debito pubblico, ma stavolta persino sottointendenti un certo «pregiudizio morale» nei confronti del nostro Paese. Oggi questo pregiudizio, grazie alla cancelliera tedesca, sembrerebbe esser stato «corretto», ma meglio chiarirlo per evitare che riemerga in futuro. La definizione di «pregiudizio morale» riferita a un salvataggio finanziario, normalmente si fonda sulla considerazione che salvare uno Stato considerato mal amministrato aumenta il rischio di cattiva amministrazione successiva ai danni del «salvatore». Questo «rischio morale» di cui sto parlando è un termine tecnico da sempre utilizzato nel mondo assicurativo. Parte dal presupposto che risarcendo i danni che si suppone siano stati provocati per trascuratezza, si incoraggia ad esser meno prudenti, se non addirittura a provocarne altri. Questo atteggiamento spiega le continue proposte di «patrimoniali» sul risparmio italiano, fatte da nazioni europee nostre partner, persino incredibilmente sostenute da «alleati» domestici in cerca di incarichi. Come da una parte ci sono stati Paesi virtuosi un po' troppo idealizzati, così ci sono quelli denigrati, tra cui il nostro. Ciò è avvenuto soprattutto per mancanza di conoscenza ed informazione, che talvolta è stata responsabilità della classe politica non saper dare. Vediamo quali accuse sembrano esser sottintese nei «pregiudizi morali» nei nostri confronti, che presuppongono proposte di patrimoniali :
1 La prima accusa sembrerebbe riferirsi alla evasione fiscale, frutto di eccessiva economia sommersa tollerata, che ha generato redditi di infedeltà fiscale che, per taluni, spiegherebbero anche l'alto livello di risparmio (investito in immobili soprattutto). Certo il sommerso vale il 12% del Pil e la conseguente evasione fiscale supera i cento miliardi di euro all'anno. Ma ciò non spiega la tassazione indiscriminata del risparmio delle famiglie. Sia chiaro che grazie al rilancio dell'economia post pandemia, verranno necessariamente adottati mezzi che necessitano totale trasparenza da parte delle imprese, per esser sorrette finanziariamente, e incoraggeranno l'emersione del «sommerso».
2 La seconda accusa sembrerebbe riferirsi alla alta redditività di cui hanno beneficiato i risparmi investiti in titoli di stato per finanziare il debito pubblico nel periodo 1980 - 1995, quando i tassi di interesse su titoli di stato superarono il 10% annuo netto. Ma non dimentichiamo che i tassi di inflazione nello stesso periodo non erano molto lontani dai rendimenti (fino al 1985 superiore al 10%, scendendo progressivamente al 6% solo dopo il 1990). Va ricordato anche che il risparmio delle famiglie, che negli anni Settanta superava il 25% del reddito, scese al 14% prima del 2000 per arrivare a valori intorno al 4-5% in questi ultimi tempi. Infatti negli ultimi 10 anni l'Italia ha perso più del 20% del risparmio lordo pro capite, mentre la Francia lo accresceva del 20% e la Germania del 40%. Ma il risparmio italiano fu sacrificato per crescere i consumi individuali, beneficiando conseguentemente l'intero sistema economico europeo.
3 Anche il famoso rapporto debito pubblico / Pil andrebbe rivisitato e compreso meglio. Questo rapporto era del 30% nel 1950, cresceva al 40% nel 1970, arrivava al 60% nel 1980, e nel 1990 salì fino al 120% (stesso livello del 1945, dopo la guerra). Ma attenzione, grazie alla politica economica di Giulio Tremonti nel governo Berlusconi, scese al 100% nel 2011. È dal 2011 che riprende a crescere per arrivare al 135% di ieri (pre pandemia). Ciò grazie alle politiche di austerità imposteci (da un governo cooptato) che fecero crollare nei tre anni successivi il Pil pro capite del -5%, paralizzandoci. Ciò mentre nello stesso tempo in Germania cresceva del 5% e poi decollava arrivando a un +10% a fine 2018. Non dimentichiamo anche che nel 1999 il Pil pro capite italiano era quasi uguale a quello tedesco (26.000 dollari verso 27.000 dollari) mentre negli anni successivi il 2011 quello tedesco arriva progressivamente a superare i 50.000 dollari (quello italiano si ferma intorno ai 34.000 dollari.) Ora, mi pare che di sacrifici gli italiani ne abbiano fatti non pochi per sostenere l'euro, soprattutto nei periodo di crisi (2007-2009 e 2011-2014). Ora si deve riconoscere una volta per tutte che l'Italia va aiutata ad accrescere soprattutto il Pil, e come conseguenza ridurre il debito. Con un governo che comprendesse questo, con l'aiuto europeo (come vale peraltro per tutti), domani l'Italia riprenderebbe a crescere prima di altri, sorprendendo molti.