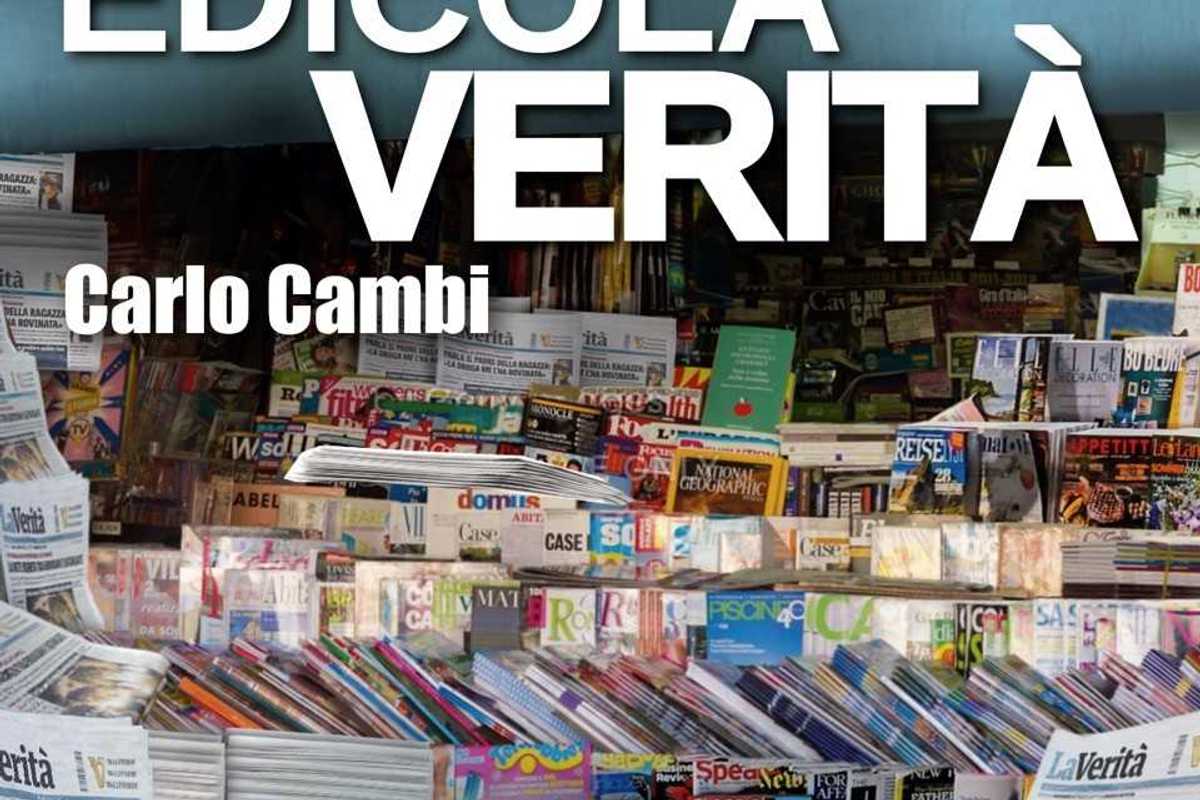- Roberto Calderoli ha presentato una bozza di riforma ed è scoppiato un putiferio. Tutti i punti chiave, tutte le obiezioni dei partiti. E le loro contraddizioni.
- «Un aiuto nella crisi energetica». L’esperto Alberto Clò: «I territori possono proporre soluzioni per il risparmio. Va rispettata la regola per cui l’interesse nazionale deve prevalere sempre per i nuovi impianti».
- «In sanità le differenze già ci sono. Il federalismo aiuta a eliminarle». Il docente Francesco Palermo: in Germania il sistema funziona come dimostra la gestione della pandemia.
A ogni cambio di governo il tema rispunta e ricominciano i contorcimenti tra maggioranza e opposizione. La concessione di un’autonomia differenziata tra le Regioni, che sta molto a cuore alla Lega, è un argomento ad alta tensione. È controverso nel centrodestra, tant’è che Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno assunto una posizione prudente. E lo è pure nel Paese, con il Sud che lo concepisce come un’arma in mano alle aree più ricche del Nord. E fa emergere le contraddizioni a sinistra, che rinnega posizioni del passato recente.
Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, è tra coloro che paventano un Paese spaccato. Eppure nel 2019 egli firmò la proposta d’intesa con cui la Campania chiedeva le competenze su sanità, istruzione, valutazioni di impatto ambientale, autorizzazioni paesaggistiche fino alla rete regionale di musei e beni culturali. Una giravolta smascherata dal ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli. Anche Giuseppe Conte è afflitto da amnesia: ora si scaglia contro l’autonomia che era già nel contratto del suo primi governo nel 2018. De Luca scavalcava perfino le regioni del Nord: avrebbe voluto basare i trasferimenti sulla spesa destinata a carattere permanente, fissa e ricorrente. Cioè la spesa storica.
Un altro dalla memoria corta è il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd. Ora pone una serie di paletti, ma gli anni scorsi accusava il governo Conte 1 (quello con la Lega) perché troppo lento nell’approvare l’autonomia, che la sua Regione aveva richiesto senza neppure passare per un referendum popolare consultivo, come avevano fatto Veneto e Lombardia. «Siamo fermi, attendiamo da mesi una risposta», incalzava Bonaccini. Adesso invece al vertice con Calderoli ha alzato un muro. Il percorso che reclama è un labirinto: prima serve una legge quadro, poi vanno definiti i Lep (livelli essenziali delle prestazioni), quindi occorre coinvolgere il Parlamento, infine vanno eliminate le questioni dei residui fiscali perché «si rischia la secessione» e va tolta dal banco la regionalizzazione della scuola. Un altro dem, il governatore toscano Eugenio Giani, è invece possibilista e prevede che la Toscana possa essere interessata a gestire beni culturali e geotermia.
Le posizioni nella maggioranza sono sfumate. Per il presidente del Senato, Ignazio La Russa, devono esserci contrappesi istituzionali mentre Fabio Rampelli chiede che prima si proceda a una riforma semipresidenziale per rafforzare i poteri dello Stato centrale. Anche per Forza Italia l’autonomia non è una priorità. I governatori di Molise, Calabria e Basilicata non si oppongono ma temono gli effetti della riforma sul territorio e chiedono garanzie.
Ma le critiche si scontrano con la realtà della Costituzione, dove sono già previste le materie che possono essere trasferite alle Regioni in base alla riforma costituzionale del 2001 votata dall’allora maggioranza parlamentare di centrosinistra. Ai governatori che chiedono al governo la definizione in via preliminare dei Lep, che lo Stato deve garantire su tutto il territorio nazionale, Calderoli si dice «assolutamente disponibile». E se il Sud è preoccupato per eventuali riduzioni dei trasferimenti, il ministro risponde con parole chiare: «Nessuno subirà riduzioni dei trasferimenti, ma la Regione che riuscisse a risparmiare sui nuovi compiti potrà scegliere se garantire più servizi o abbassare la tassazione». Si verrebbero quindi a creare le condizioni affinché a pari risorse ci siano gestioni efficienti e siano individuabili le responsabilità della mala amministrazione. Con questi presupposti, proprio le Regioni meno efficienti dovrebbero chiedere più autonomia e leggi per semplificare i vincoli nazionali.
Altro punto di contrasto è come cambieranno i trasferimenti dopo il passaggio delle competenze. Eppure Calderoli ha spiegato più volte che «si può partire dalla spesa storica e poi, in base ai costi e ai fabbisogni standard, superarla». Quanto alla scuola, il presidente della Liguria, Giovanni Toti, chiarisce che «una cosa sono i programmi ministeriali, altra la gestione degli immobili, i servizi e gli insegnanti di sostegno. L’obiettivo, come precisato dalla proposta di riforma, è di iniziare un anno scolastico con i docenti assegnati alle classi fin dal primo giorno».
Le prove generali dell’autonomia sono avvenute durante la pandemia, con Regioni che hanno preso in mano la situazione e sono intervenute in base al grado e alla gravità di diffusione del virus a livello locale. Ma anche in quella occasione, nonostante i risultati ottenuti, ci fu una levata di scudi contro gli interventi differenziati.
Ora la situazione è caratterizzata da Regioni in cui la sanità ha punte di eccellenza e altre che costringono i loro residenti al turismo sanitario. La sanità uguale ovunque significherebbe, per dirla come Toti «un appiattimento verso il basso». E l’assenza di una catena di responsabilità che impedisce al paziente/elettore di giudicare la gestione.
La bozza di riforma proposta da Calderoli alla conferenza Stato Regioni prevede il decentramento di diverse competenze oggi ripartite tra Stato e Regioni. Nella passata legislatura vi aveva lavorato l’allora ministra Mariastella Gelmini, oggi passata all’opposizione con Carlo Calenda. Il punto di partenza è il terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione, come modificato nel 2001. Sono 23 le materie di competenza mista che potrebbero rientrare nella titolarità delle singole Regioni. Esse comprendono, tra le altre, l’organizzazione dei giudici di pace, l’istruzione (norme generali a parte), la tutela di ambiente, ecosistema e beni culturali, rapporti internazionali e con l’Ue, commercio estero, salute, alimentazione, ma anche produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, previdenza complementare e integrativa, finanza pubblica e sistema tributario.
La bozza di riforma di Calderoli prevede che le Regioni, a loro volta, possano trasferire le funzioni agli enti amministrativi più vicini ai cittadini: Comuni, Città metropolitane, Province. Il governo avrà 12 mesi per determinare i Lep che dovranno essere garantiti dalle Regioni in modo uniforme. Se, trascorso un anno, i Lep non saranno definiti, le competenze passeranno direttamente ai governatori. Dalla bozza di legge di bilancio circolata sabato, risulta che a Palazzo Chigi sarà istituita una cabina di regia. La guiderà Calderoli, ne faranno parte i ministri Fitto, Casellati, Giorgetti più quelli competenti per materia oltre ai rappresentanti degli enti locali.
C’è poi il capitolo dei finanziamenti. Inizialmente, le risorse necessarie alle Regioni per occuparsi delle nuove materie assegnate dovrebbero essere attribuite secondo il criterio della spesa storica: chi più ha speso negli anni scorsi per i servizi corrispondenti alle funzioni, più riceverà. Il valore preciso dei fondi verrà approvato da una commissione paritetica Stato-Regione. Ma questo criterio sarebbe poi progressivamente sostituito dalla determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard da parte delle amministrazioni regionali in un’ottica di efficienza della spesa. Al momento, la bozza di Calderoli è ancora in fase di discussione e non è stata depositata in Parlamento. Non ci sono scadenze. Ma il ministro appare molto determinato a non fare cadere nel vuoto la riforma.
«Un aiuto nella crisi energetica»
A cosa si riferisce?
«Per esempio, tutti parlano di trivellare l’Adriatico ma il Veneto si è opposto. Il fenomeno del Nimby, cioè “non nel mio orto di casa”, rischia di amplificarsi se si riconoscono ai territori maggiori autonomie. Accadde anni fa quando la Sicilia disse di voler mettere una tassa - incostituzionale - sui gasdotti che attraversavano il territorio. Va bene valorizzare i territori, ma bisogna affermare principio di solidarietà nazionale per cui l’interesse generale prevale su quello particolare».
L’autonomia aiuterebbe nella crisi energetica?
«L’autonomia aiuta se consente ai territori di proporre soluzioni. Penso a come accrescere l’efficienza energetica, a come calibrare i consumi in inverno. Non può valere la stessa regola per il Trentino e la Sicilia. I territori sono in grado di veder meglio le necessità particolari. Dipende quindi da come lo strumento dell’autonomia è declinato e applicato. Pensiamo anche a Piombino».
Il Comune che si oppone alla nave rigassificatrice.
«C’è un interesse nazionale e non può essere la città di Piombino a impedirlo. Sarebbe un principio pericoloso. In Germania in pochi mesi sono stati autorizzati sei rigassificatori ed uno è già partito, mentre noi non abbiamo combinato niente. Gli interessi generali non possono essere sopraffatti da quelli locali».
Questo vale anche per il nucleare?
«Il nucleare nel nostro Paese è un argomento chiuso e quindi è inutile riproporlo, non ci sono le condizioni di accettabilità sociale. Non sono nemmeno riusciti a trovare i siti per le scorie radioattive. Ancora non c’è la mappa dei siti perché tutti si oppongono. Ora i residui si trovano in alcuni siti gestiti dalla Sogin, ma è una situazione provvisoria che dura da decenni».
«In sanità le differenze già ci sono. Il federalismo aiuta a eliminarle»
Partiamo dalla differenza di federalismo tra Italia e Germania e da come i sistemi sanitari hanno affrontato la pandemia.
«Innanzitutto in Germania non è stato dichiarato lo stato di emergenza e i poteri dei Land non sono stati messi in discussione. Sono stati loro a decidere di delegare responsabilità al governo federale. In Italia, invece, le Regioni sono state praticamente esautorate dall’alto, attraverso i dpcm. Questa è una differenza significativa, anche se bisogna dire che tutte le regioni sono state al gioco. L’Alto Adige ha rotto i ranghi per primo con la legge provinciale del maggio 2020. In Germania i vantaggi di un sistema federale che consente soluzioni flessibili non sono stati messi in discussione, mentre in Italia i media hanno criticato l’esistenza di 21 diversi sistemi regionali sanitari. C’è stata un’onda contraria a soluzioni differenziate nonostante che la diffusione del virus sia stata diversa sul territorio, e in situazioni regionali diverse sono state imposte misure uniformi».
Quello che è accaduto durante la pandemia può far scuola alla riforma dell’autonomia?
«Direi di sì, anzi smonta le critiche sul federalismo nella sanità come causa di una spaccatura del Paese e dell’abbassamento della qualità nelle prestazioni. Il vantaggio dei sistemi federali è la possibilità di scelta: si può decidere quanto centralizzare. Può accadere che il governo centrale si muova meglio dei territori, ma può accadere anche il contrario. Naturalmente nessuna regione può combattere da sola una pandemia. Il problema è arrivare a soluzioni mirate per situazione specifiche. E come abbiamo visto, gli effetti della pandemia sono variati da regione a regione».
Quindi tutto va a favore di un allargamento dell’autonomia nella sanità?
«Così dovrebbe essere, ma la tendenza è opposta. C’è una tendenza generale a ridurre o a togliere le competenze sanitarie alle regioni. La Corte costituzionale su questo è in prima linea. Appena c’è una legge regionale in tal senso, interviene per bocciarla. È accaduto quando ha dichiarato incostituzionale la legge regionale della Valle d’Aosta sul controllo della pandemia, motivando che spetta allo Stato e non alle regioni determinare le misure necessarie. Il pronunciamento è stato accolto da un giubilo generale, compresi molti costituzionalisti. Un altro esempio è la social card che è passata sopra le competenze delle regioni in materia di assistenza sociale, ma è stata ritenuta legittima. Hanno avuto vita breve anche alcune misure restrittive sull’immigrazione come accesso ai servizi pubblici».
Pandemia a parte, quali sarebbero i vantaggi dell’autonomia nella sanità?
«Oggi ci sono disparità territoriali enormi in tema di sanità. Il numero degli ospedali non tiene conto delle caratteristiche territoriali come la prevalenza di aree montane che rendono difficili gli spostamenti. L’autonomia viene bollata come la secessione dei ricchi, ma questa già l’abbiamo: ci sono fortissime disparità regionali che obbligano al turismo sanitario con costi a carico delle regioni del Sud. Ci sono paure storiche, ataviche, manca una cultura dell’autonomia se non nei termini dell’assistenzialismo. Temo che chi tuona contro la riforma, è perché ha paura che qualcuno venga a fare le pulci su come sono spesi i fondi pubblici».