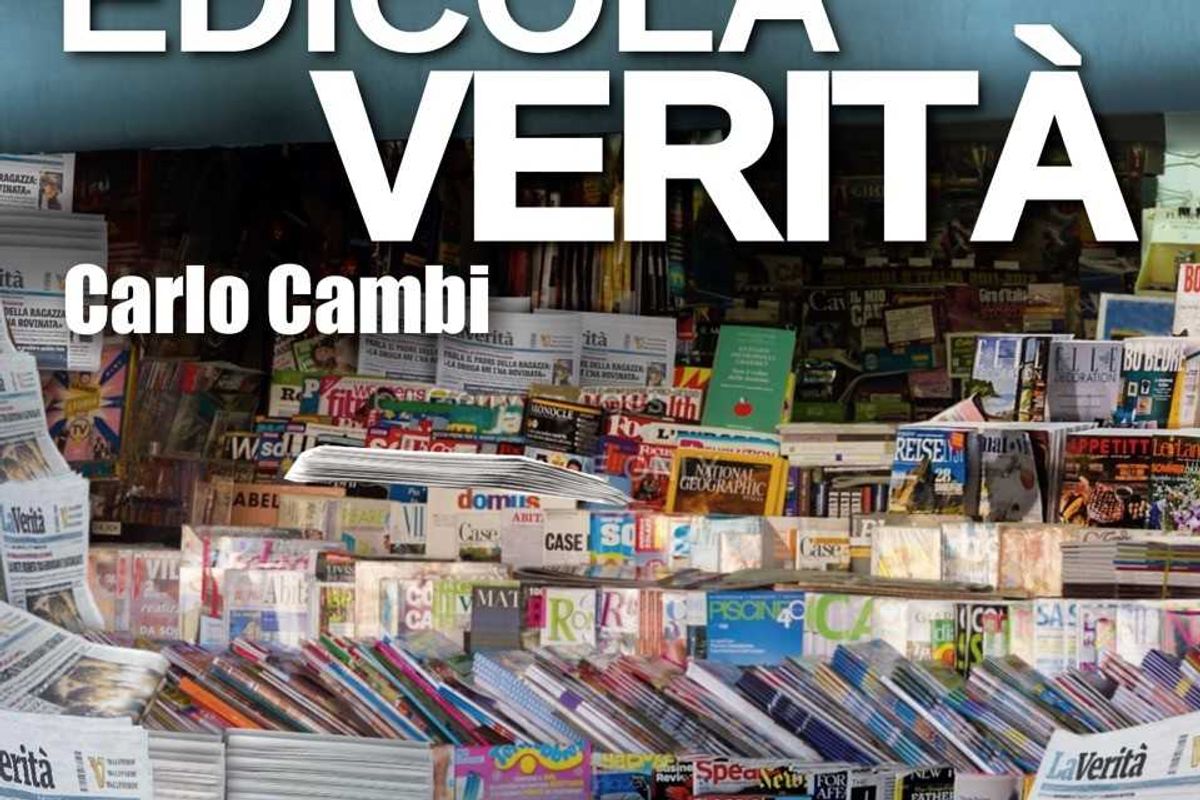Il professor Cesare Mirabelli è uno dei più noti e autorevoli giuristi italiani. Già membro della Corte costituzionale, di cui è stato anche presidente, ha accettato una conversazione a tutto campo con La Verità. Il professor Mirabelli tiene a sottolineare che «la tenuta della democrazia è salda», ma teme che «si crei una consuetudine per cui con atti amministrativi si incida su diritti di libertà».
Professore, che vuol dire prorogare lo stato d'emergenza anche in un momento in cui l'emergenza non esiste o è solo un'eventualità futura?
«L'emergenza richiede straordinarietà e temporaneità. Ci deve essere il presupposto che la giustifichi. Non può invece esservi emergenza per una situazione eventuale e futura».
Anche concettualmente, scusi la rozzezza, prima c'è il terremoto e poi si proclama l'emergenza. Non ha molto senso affermare un regime speciale prima che se ne verifichino i presupposti.
«Esattamente. Naturalmente, ci si può sempre dotare di strumenti che verranno utili se e quando l'emergenza si verificasse, ma altro conto è invece instaurarla immediatamente».
Diciamo che ci si può «apprestare» a un'eventuale emergenza.
«Uno dovrebbe apprestarsi sempre, cioè predisporre piani, sapere cosa si fa se e quando un'eventualità dovesse verificarsi. Ma non adottare già ora misure pensate solo per il “se" e il “quando"».
Anche perché, nella disgraziata ipotesi di un evento grave, un Consiglio dei ministri si può convocare in mezz'ora.
«Non solo. Provvedimenti urgenti possono essere adottati in quel caso anche a livello locale, ad esempio da un sindaco, oppure, in materia sanitaria, possono essere disposti dal ministro della Sanità. Oppure, tornando al Consiglio dei ministri, misure straordinarie possono essere adottate con decreto legge. Invece…».
Invece?
«Invece c'è da chiedersi se sia giustificata l'attribuzione immediata di poteri che andrebbero esercitati solo in presenza dell'effettivo presupposto dell'emergenza».
A meno di ritenere che siamo in una specie di stato di guerra.
«È diverso. In quel caso la Costituzione consente al Parlamento di conferire al governo i poteri necessari senza definirne i contorni. Si tratta di una situazione letteralmente straordinaria ed eccezionale, per fortuna mai verificatasi, nella quale può anche esservi una difficoltà di riunione dell'assemblea parlamentare. Ma, lo ripeto, è sempre il legislatore che se ne assume la responsabilità politica».
Qual è l'elemento costituzionalmente più delicato, a suo avviso, nell'esperienza che abbiamo vissuto nei mesi passati?
«Certamente, lo riconosco, abbiamo avuto a che fare con un'epidemia straordinaria e assai diffusa, che ha richiesto interventi non ordinari. Però il punto delicato riguarda l'esercizio dei diritti di libertà: i diritti costituzionali non possono essere soppressi o sospesi. È legittimo limitarli, se la legge lo dispone per salvaguardare un altro bene costituzionale come la salute, ma ciò deve essere giustificato, temporaneo, proporzionato al fine da perseguire, con un bilanciamento tra i diritti in gioco».
Possiamo fare un esempio?
«La Costituzione lo dice espressamente per la libertà di circolazione: può essere limitata in via generale solo se la legge lo stabilisce. Che lo si faccia per via amministrativa può accadere soltanto in ipotesi molto circoscritte: ad esempio c'è un terremoto, e si limita l'accesso all'area interessata. Al contrario, desta preoccupazione vietare in modo assoluto la libertà di circolazione, o il diritto di riunione».
Esistono esperienze straniere che ci aiutino a comprendere meglio il suo richiamo?
«Il tribunale costituzionale tedesco, su un ricorso diretto (che in quell'ordinamento è ammissibile), ha dichiarato non legittimo un provvedimento che chiudeva gli edifici di culto. Il tribunale ha ritenuto che il divieto assoluto equivalesse alla soppressione della libertà di riunirsi per l'esercizio del culto. A maggior ragione essendo possibili misure diverse di salvaguardia, più limitate e proporzionate. Analogo orientamento è venuto dal Consiglio costituzionale francese, per cui non si può sospendere totalmente una libertà costituzionale».
Lei è stato molto critico sull'uso dei dpcm.
«I dpcm sono provvedimenti amministrativi, come tali impugnabili davanti al giudice amministrativo. Nel nostro caso, in questi mesi, hanno avuto una qualche copertura perché un decreto legge convertito dal Parlamento aveva stabilito che a determinate condizioni tali dpcm potessero essere adottati. Ma il punto nevralgico è illustrare la differenza tra dpcm e decreto legge».
I dpcm tagliano fuori sia il Parlamento sia il capo dello Stato.
«Appunto. Il decreto legge è deliberato dal Consiglio dei ministri. È sottoposto al presidente della Repubblica, e quindi già in quella sede c'è una prima attività di controllo. E poi è affidato al Parlamento per la conversione, con responsabilità politica del governo se la conversione in legge non avviene. È il Parlamento che svolge un ruolo centrale, delibera e discute. E stiamo parlando di uno strumento che ha efficacia immediata con forza di legge, è cioè uno strumento potente che il governo può usare in caso di necessità e urgenza. Ecco, nessuna di queste forme di garanzia esiste per il Dpcm».
Parliamoci chiaro: con quello strumento si è finito per incidere su una mezza dozzina di norme costituzionali, travolgendo principi sacri come la libertà di riunione e quella di movimento. Non hanno toccato solo i colori della bandiera, se mi permette la battuta.
«Lo ripeto: i dpcm non hanno le garanzie che abbiamo spiegato prima per i decreti legge. E, quando si toccano diritti costituzionali e di libertà, temo un rischio di assuefazione, per così dire. Né è sufficiente un'informativa o una comunicazione al Parlamento. È vero, il Parlamento può sempre presentare una mozione, dare un indirizzo, svolgere attività di controllo, ma la sua funzione in questo caso è pur sempre sminuita».
C'è un problema complessivo di sbilanciamento istituzionale?
«Questo già c'è anche a livello di produzione normativa tra governo e Parlamento. Prevalgono nettamente, anche in termini quantitativi, le norme prodotte dal governo, o gli atti normativi di iniziativa governativa. Quest'ultimo punto, in verità, non dovrebbe preoccupare eccessivamente: il governo attua l'indirizzo politico che le Camere hanno approvato attraverso la fiducia, fermo restando il potere di emendamento e di rigetto da parte del Parlamento. Però…».
Però spesso si esagera.
«Si esagera quando il decreto legge diventa uno strumento ordinario. Già nel preambolo occorrerebbe precisare in modo adeguato le ragioni di necessità e urgenza che ne giustificano l'adozione. Dopo di che alcuni decreti legge divengono “monstre" anche per le dimensioni che hanno, il che ne limita l'effettiva possibilità di discuterli in Parlamento. E se poi si aggiunge il vincolo che si pone con la fiducia, ciò determina uno squilibrio palese».
Spostandoci dal terreno strettamente costituzionale ad una valutazione più complessiva, lei non teme un progressivo instaurarsi di una specie di «emergenza permanente»? Un po' per il tentativo di un governo di tenersi vivo, un po' per la sfiducia negli strumenti normativi e amministrativi ordinari, non rischiamo di entrare stabilmente nello stato d'eccezione, il che è già una contraddizione in termini?
«Parlavo prima di un rischio di “assuefazione". Il rischio esiste: si attenuano l'eccezionalità, la temporaneità e la misura che dovrebbero contraddistinguere un'emergenza. A volte si aggiunge il fatto che i provvedimenti adottati vengono iterati in modo non sempre giustificato, direi per inerzia… Al contrario delle leggi fisiche, viene da dire che “tutto si crea e nulla si distrugge"».
Se un cittadino, che vota per il Parlamento, vede questa torsione e si accorge che il Parlamento è di fatto spettatore passivo, questo non rischia di creare sfiducia nella democrazia?
«Mi lasci dire che però questo può dipendere anche dal Parlamento, che avrebbe tutti gli strumenti per affermarsi: adottare atti di indirizzo, fino alla risposta estrema di sfiduciare il governo. Il Parlamento ha tutti i poteri che intenda e voglia esercitare. Anche in questa occasione, se avesse ritenuto opportuno controllare in modo più puntuale l'azione del governo o discuterne politicamente, non gli sarebbero mancati gli strumenti: un uso più forte dell'attività delle commissioni ordinarie, la convocazione dell'aula, la costituzione di commissioni speciali, sia pure temporanee, per seguire l'emergenza in modo orizzontale rispetto alle competenze delle singole commissioni permanenti…».
C'è stato qualche segnale di attenzione del governo per le Camere?
«Ho notato frequenti interventi del ministro della Sanità. Insisto, il punto non è un pericolo già in atto: penso che la tenuta della democrazia sia salda. Ma c'è un rischio: che si crei una consuetudine per cui con atti amministrativi come i Dpcm si finisca con l'incidere su diritti di libertà».