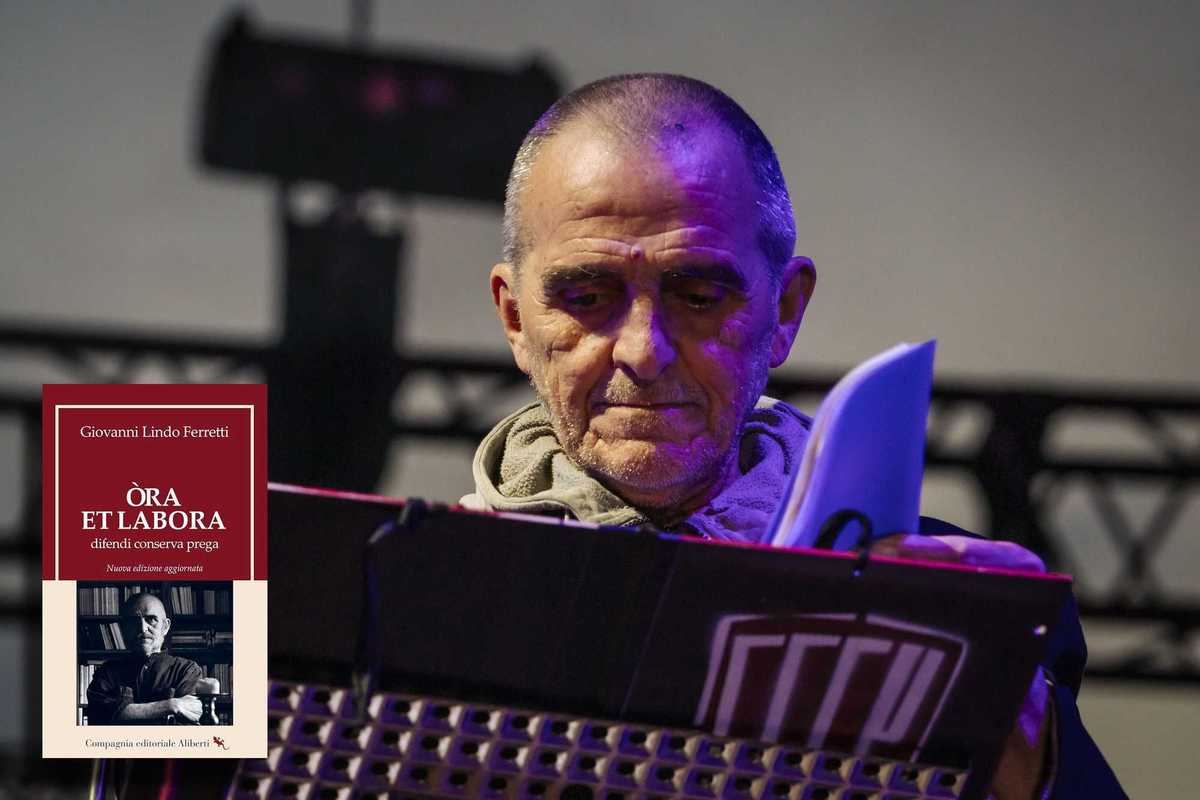«Il regime sovietico è uscito di soppiatto dal teatro della storia, dove era entrato in modo spettacolare». Con queste parole François Furet apre la sua poderosa fatica storica sul passato di un'illusione: il comunismo. Il saggio apparve in Francia nel 1995. Una fucilata indirizzata in pieno petto al gigante dai piedi d'argilla, tirata peraltro da un compagno di strada che nell'illusione comunista, da un po' di tempo, aveva smesso di credere.
Un sistema all'apparenza edificato su fondamenta sin troppo solide, simile ad una muraglia inespugnabile, era venuto giù di schianto. Lo stupore per il crollo prese tutti di sorpresa. Nessuno lo aveva fatto esplodere. Era imploso. E sotto le macerie, Furet lo metteva bene in evidenza, la «memoria» del comunismo si era immediatamente inabissata. «I popoli che escono dal comunismo sembrano ossessionati dalla negazione del regime nel quale hanno vissuto». Partita con la gloriosa rivoluzione del 1917 e finita nell'inglorioso crollo del 1989, la «memoria» del lungo tempo passato assume la fisionomia della tabula rasa. Invece di ricostruirla, la «memoria» del comunismo, nei trent'anni che ci separano dalla sua caduta, è stata cancellata. Il comunismo era finito in una specie di nulla, chiosava Furet. E il cinema, che nella odierna società avvinghiata al presente assolve il ruolo di mettere in scena la «memoria» del passato, del comunismo si è dimenticato.
La breve storia del nazismo è stata rivisitata in ogni possibile forma. A quella lunga del comunismo è toccato il destino opposto: l'oblio. Un oblio ravvivato da pochi lampi lucenti. Come il luminosissimo Cold War del polacco Pawel Pawlikowski. Un bianco e nero struggente. Un formato antico del quadro ridotto. Una misura del racconto scarnificata ed essenziale. La Polonia del 1949 rappresenta una beffa del destino: se ne sono andati gli occupanti nazisti, lasciando morte e distruzione. Ma l'illusione della libertà s'è infranta rapidamente: ora il nuovo ordine è comunista e sovietico. Zula (Zuzanna) e Wiktor vivono una storia d'amore. Lei vorrebbe cantare, lui fare musica.
Ma i canoni impostigli dal regime restringono i loro orizzonti. Canti patriottici, popolari, celebrativi del socialismo e dei suoi eroi li deprimono. Una via d'evasione ci sarebbe: la fuga ad Occidente, via Berlino, durante una esibizione nel 1952. Si danno appuntamento al crocevia della libertà. Zula però non trova il coraggio per presentarsi. Wiktor, invece, raggiunge Parigi. È un altro mondo. La moda esistenzialista sta dilagando. Il jazz e i primi vagiti del rock sono un balsamo squisito, nonostante la squattrinata esistenza. Passa un po' di tempo. Zula si esibisce nella Jugoslavia di Tito. Wiktor compone musica per film e suona in alcuni locali. I due amanti si ritrovano a Parigi. Zula ha sposato un siciliano. Può quindi uscire ed entrare dalla Polonia. Wiktor è un esule. La passione si riaccende.
Ma rancori e incomprensioni minano il rapporto. Il jazz inebria l'esistenza di Wiktor. Zula lo respinge. Le parole di una poetessa toccano nel profondo il musicista. La cantante non le capisce: quel mondo non fa per lei. Decide così di tornarsene a casa. Sono nel frattempo arrivati i primi successi di Adriano Celentano (24.000 baci). Non è il clima roco e conturbante di Saint-Germain-des-Prés. Ma ci si può accontentare. Wiktor non resiste alla separazione. Rientra in Polonia. Affronta il carcere da traditore. L'esistenza dei due amanti è stata sin troppo tormentata. Spesso si sono fatti reciprocamente del male.
Siamo alla metà degli anni Sessanta. Si giurano fedeltà eterna in una chiesa dalle mura divelte, senza l'officiante, senza testimoni, senza nessuno ad assistere. Dio li aiuterà. La Guerra fredda nell'immaginario collettivo è stata una contrapposizione tra blocchi. Un quotidiano scontro tra nemici esterni ed interni. L'hanno combattuta uomini in divisa e in doppiopetto. Spie e traditori. Eroi e ruffiani. Propagandisti della peggior risma e coscienziosi scienziati. Nel film di Pawlikowski a combatterla sono due innamorati anonimi. La strada del loro amore è stata disseminata di macigni posti dal comunismo. Il regime ha chiesto loro di interpretare un ruolo, di indossare un vestito patriottico troppo stretto. Nell'iconografia cinematografica d'abitudine il totalitarismo viene rappresentato attraverso la violenza cieca, la vessazione sistematica, la detenzione brutale, la morte industrializzata.
Ma questo aspetto, certo vero e spaventoso, è solo la parte più appariscente. Per quasi un secolo un segmento consistente del continente europeo è stato sottomesso alle quotidiane vessazioni del comunismo. I processi, le purghe, l'assassinio di massa con vari mezzi, dalla fame al gulag, hanno rappresentato un Moloch che ha inghiottito milioni di esseri umani. Ma altrettanto drammatica è stata l'esistenza quotidiana. Tutto sommato è facile rappresentare la bestialità in un campo di concentramento. L'effetto è scontato. Ci sono pochi carnefici e tante vittime sacrificali. Difficile, difficilissimo, quasi impossibile è mostrare il male di vivere del quotidiano. L'Ovest era l'isola felice. L'Est il vulcano minaccioso.
Come spiegare allora perché Wiktor si adatta a vivere a Parigi e Zula no? Un'ingrata? Un'incapace di apprezzare i frutti gustosi della libertà? Una malata? Una nostalgica? Una personalità propensa al compromesso? La donna a Parigi potrebbe avere successo. Forse addirittura potrebbe diventare una grande artista. Ma si ubriaca. Si concede ad altri. Dà il peggio di sé. E fugge. La verità è che non riesce a sopportare l'accomodamento alla modernità occidentale (un'arte alla moda) così come le è estranea la modernità orientale (un'arte ideologica). C'è solo un posto, un luogo della salvezza e dell'autenticità. L'ultimo viaggio, senza portarsi appresso nulla, Zula e Wiktor lo compiono nella terra della tradizione e del sacro. Sarà dura. Ma ne verranno fuori. È così storicamente è stato.


 Una delle operazioni di pulizia ambientale condotte da Plastic Free Onlus in Giordania
Una delle operazioni di pulizia ambientale condotte da Plastic Free Onlus in Giordania