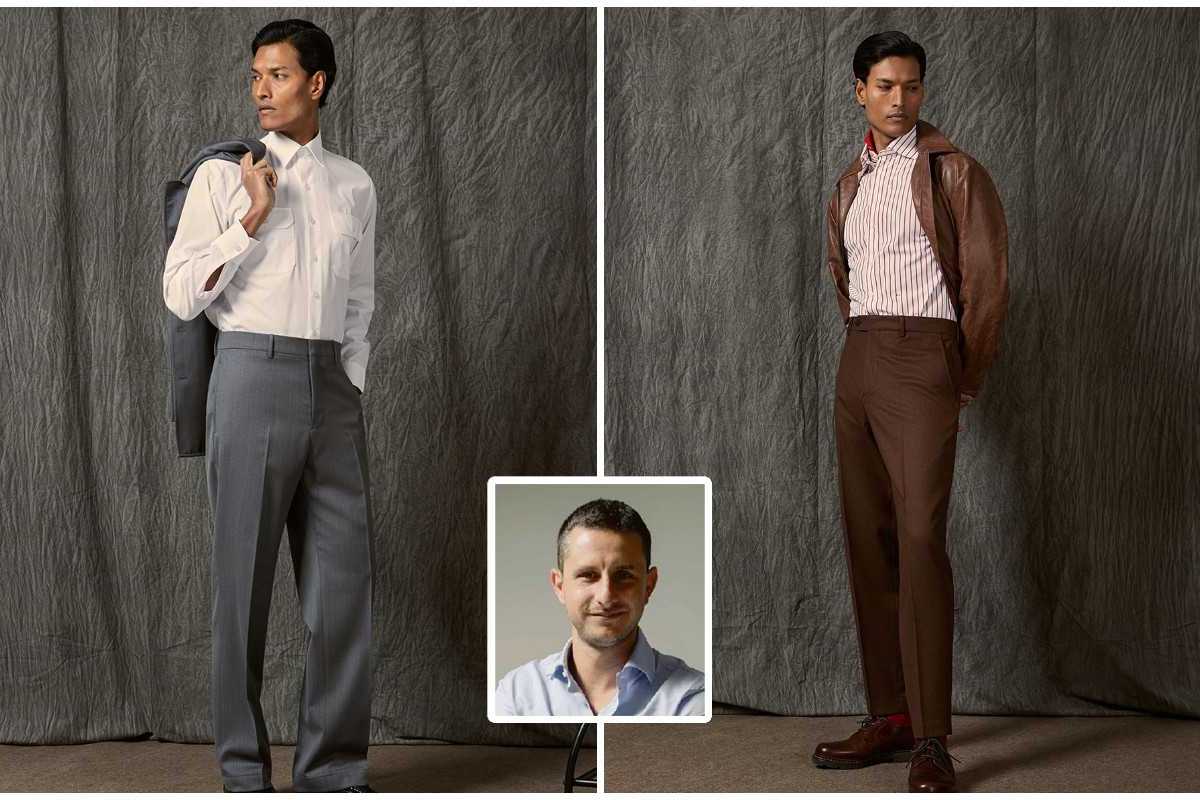L'agresto è il Carnèade (chi era costui?) dei condimenti. È acido, ma non è aceto. È fatto col mosto cotto dell'uva, ma non è aceto balsamico. Né può essergli apparentato. Prima di tutto l'uva per produrre l'agresto, còlta molto acerba, poi il sapore, più acido che agrodolce, infine la tecnica della lavorazione, assai meno complessa, distinguono nettamente l'agresto dal balsamico. Sia l'uno che l'altro vantano un albero genealogico che affonda le radici in epoche lontane, ma mentre il tradizionale (di Modena o di Reggio Emilia) si è costruito un'ottima fama negli ultimi tre secoli diventando uno degli italian food più ricercati nel mondo, l'agresto, dopo secoli di gloriosa popolarità, arrivato alla soglia del XX secolo, è scivolato nell'oblìo fino, quasi, a sparire. Se ancora sopravvive lo deve a minuscole isole di produzione in Toscana e nelle Marche dove approderemo più avanti.
È finito, invece, totalmente nel dimenticatoio un piatto della tradizione italiana, piccioni in umido, che un tempo era considerato una prelibatezza ricercata dai ghiottoni e offerta ad ammalati e inappetenti per rianimarne l'appetito. Citiamo questo piatto per arrivare subito a Pellegrino Artusi che dell'agresto era un estimatore ed è l'ultimo gastronomo di peso ad averne parlato. Il Garibaldi della cucina italiana inserisce la ricetta (è la numero 276) nella Scienza in cucina e l'arte di mangiar bene nel capitolo degli «Umidi»: «Sono i piatti che più appetiscono quindi è bene darsi per essi una cura speciale, onde riescano delicati, di buon gusto e di facile digestione». Artusi, da perfettino qual era, suggellò la ricetta raccomandando: «Al tempo dell'agresto usate quest'ultimo invece del limone seguendo il dettato: Quando sol est in leone, bonum vinum cum popone, et agrestum cum pipione». Traduciamo liberamente dal latino maccheronico: quando il sole è nel segno zodiacale del leone (dal 23 luglio al 23 agosto) abbinate il melone col vino buono e il piccione con l'agresto. Il quale, dunque, ha una stagionalità da rispettare.
Lo stesso suggerimento di Artusi lo diede il grammatico Artemidoro di Tarso millenovecento anni prima. Impegnato a registrare un glossarietto gastronomico Artemidoro consigliò: «Per ottenere il meglio da alcuni piatti di carne usate agresto anziché aceto». Naturalmente la parola usata dal grammatico non fu agresto, ma il condimento da lui citato gli somiglia molto. I Romani chiamavano l'agresto omphacium intendendo sia il succo ottenuto da uve acerbe che quello ricavato dalle olive immature. Di omphacium parla Plinio il Vecchio. Sul metodo di cuocere il mosto d'uva discettano Virgilio e Lucio Columella. Apicio, autore di un libro sulle salse, De condituris, versa su parecchi piatti (fenicottero arrosto, anatra con le rape, murena arrosto...) il defrutum, mosto d'uva cotto che se non era proprio agresto, ne era un consanguineo. È nel basso medioevo che l'agresto prende piede e nome entrando nelle cucine di corte regalando un'apprezzata nota di acidità (i limoni erano merce rara) alle salse per insaporire bolliti e arrosti e nascondendo gli odori di carne marcescente. In estate, con l'aggiunta di spezie e miele, diventava una bibita asprigna e dissetante.
I grappoli dell'uva verde venivano còlti in luglio, pigiati delicatamente (da bambini) per non scempiare gli acini. Il mosto ottenuto, versato in recipienti coperti con teli, era esposto al sole oppure bollito per addensarlo e aromatizzato con spezie, aglio, cipolla e miele. L'agronomo bolognese Piero de' Crescenzi vissuto a cavallo tra il due e il trecento, in un trattato sull'agricoltura dedica un paio di pagine ai due modi di fare l'agresto, liquido e secco. Per ottenere il primo suggerisce di raccogliere le uve acerbe, pestarle in un tino e porre il mosto al sole con l'aggiunta (facoltativa) di sale per garantirgli una durata maggiore. L'agresto secco si fa con uve acerbissime, pestate e poste in un vaso di rame sul fuoco, condensando il mosto fino al punto desiderato. Dopodichè «poni in un vaso disteso e poulo al sole tanto che si secchi».
Il gusto agro, assai gradito al palato medioevale, non lo era altrettanto nella letteratura d'amore. Sono famosi due versi di Dante che in una delle Rime invoca amore per cancellare le aspre pene del cuore: «coi dolci impiastri/ farà stornarvi ogni tormento agresto». Ma non a tutti interessava la rima cuore/amore. Al cardinale camerlengo Ludovico Scarampi Mezzarota, soprannominato cardinal Lucullo per i sontuosi banchetti, interessava più la gola. Il suo cuoco, siamo alla metà del '400, era nientepopodimeno che Maestro Martino da Como considerato il Michelangelo della cucina italiana. Maestro Martino, nel libro De arte coquinaria presenta molti piatti, soprattutto di carne, con salse acidule con l'agresto alla base o con spremute di arance amare. Anticipando di 400 anni Artusi il grande cuoco rinascimentale dettò la ricetta Per fare una crostata di pippioni raccomandando di esaltare i piccioni con una salsa di «bono agresto», brodo grasso, otto uova, da sbattere bene insieme e versare in padella con «petrosillo, magiorana et menta».
Gli risponde il contemporaneo Bartolomeo Sacchi, detto il Platina, gastronomo di Pio II, con il pollo all'agresto «pietanza molto salutare, nutriente e digeribile che fa bene allo stomaco, ai reni, al fegato e alla bile». Bartolomeo Scappi, cuoco di due papa Pio nel '500, usava l'agresto per insaporire lo storione. Oltre al palato l'agresto ha arricchito anche la lingua. Lorenzo Lippi, pittore e scrittore fiorentino del '600, nel poemetto eroicomico Il Malmantile racquistato, racconta che la frase «far la cresta», tanto cara ai profittatori di tutti i tempi, è nata e battezzata dall'acre condimento. «Far' agresto si dice quando uno mandato a comprare roba, dice havere speso più di quello che ha speso, per rubar quell'avanzo. Vien da i contadini, che per rubare al padrone pigliano l'uva non matura (che si chiama agresto) e ne fanno sugo, e lo vendono».
Paolo Petroni, scrittore, presidente dell'Accademia italiana della cucina, istituzione culturale della Repubblica italiana con delegazioni in tutto il mondo, è un esperto di agresto di cui si è occupato in una pubblicazione sulla cucina toscana. «Non è possibile dare una definizione categorica di agresto come non esiste una ricetta codificata. Ogni famiglia contadina toscana lo faceva a modo suo aggiungendo gli ingredienti più vari: noce moscata, sale, pepe, scorze d'arancia o altro ancora. Anche i tempi di raccolta dell'uva non erano gli stessi per tutti. C'era chi la raccoglieva acerba a metà luglio chi rastrellava gli acini immaturi, rimasti sulle viti dopo la vendemmia. Con il mosto di queste uve- le più adatte sono canaiolo e malvasia- si possono fare l'aceto e la salsa d'agresto».
La Toscana è una delle due regioni italiane, l'altra è le Marche, che hanno salvato l'agresto dall'estinzione. Nelle Marche lo fa una cooperativa a Serra de' Conti sulle colline del Verdicchio, in provincia di Ancona. In Toscana lo producono due aziende artigiane di San Miniato, in provincia di Pisa. L'agresto di San Miniato ha ottenuto dal ministero delle Politiche agricole il marchio di Prodotto alimentare tradizionale, Pat. «Abbiamo reintrodotto in Toscana la produzione dell'agresto», dice Aurelio Visconti, titolare dell'azienda Lombardi e Visconti, «dopo che se n'erano quasi perse le tracce. L'agresto ha una storia antica e importante. Molti grandi cuochi e scrittori di gastronomia lo hanno celebrato in passato. L'ultimo alla fine dell'800, è stato Pellegrino Artusi. Abbiamo avuto qualche difficoltà a riproporlo perché sull'agresto c'è tantissima letteratura, ma nessuna ricetta codificata. Siamo partiti da uno studio individuando le caratteristiche di tre tipi: il San Miniato, il Dolceforte di Firenze e le Crete Senesi del quale c'erano solo testimonianze orali».