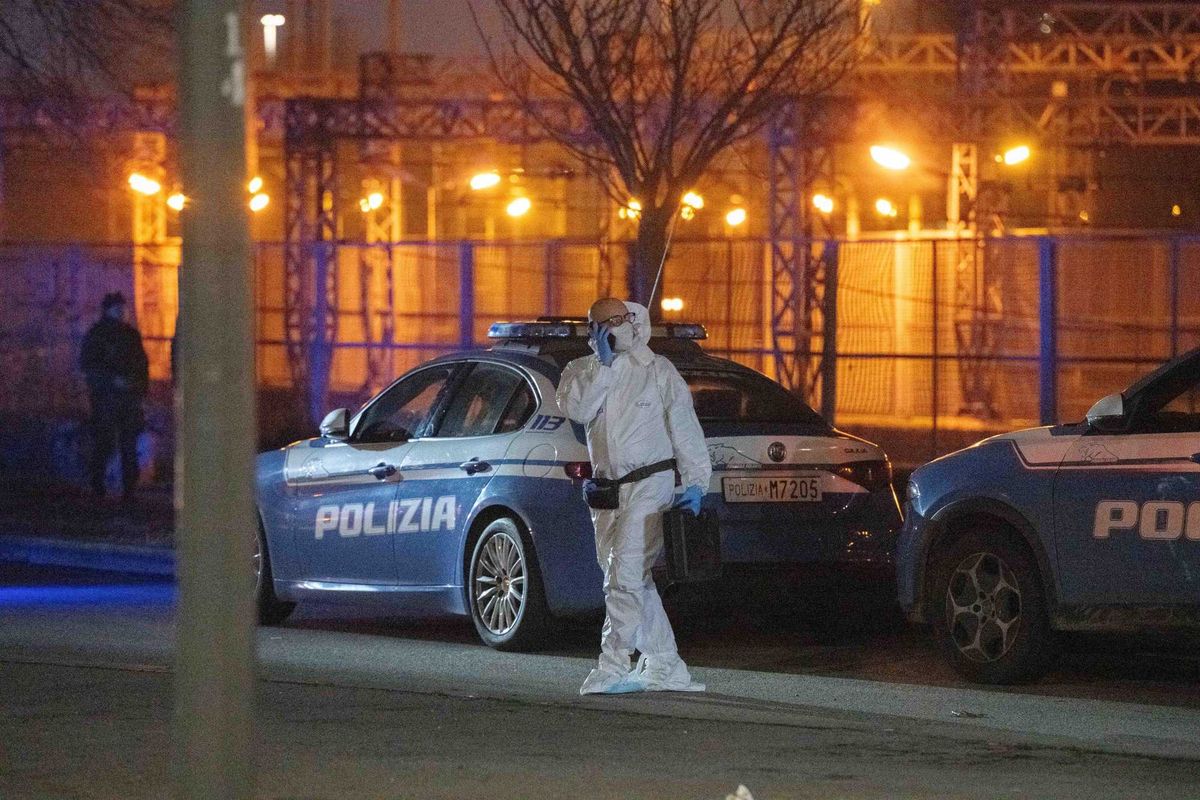True
2019-02-26
Abbiamo 5.569.000 lavoratori sottopagati
Ansa
Bisogna dare atto all'attuale governo di avere imparato a tirare fuori i problemi. A farli emergere. Purtroppo, al momento è complicato dire che sia altrettanto bravo a trovare le soluzioni. Il che non significa che ciò non avverrà in futuro. Nel frattempo, i gialloblù, portando in Parlamento il decretone sul reddito di cittadinanza, hanno imposto al dibattito politico il tema delle paghe dei lavoratori. Il trend dei precari era da anni in costante aumento, e il governo precedente si limitava a celebrare l'aumento costante del dato dell'occupazione.
«Ottimo», diceva Paolo Gentiloni. Peccato che il record di 58% di persone con un'occupazione non corrisponda alla piena occupazione. Per rientrare nella lista, infatti, basta lavorare anche una sola ora a settimana, il che certamente non garantisce uno stipendio degno di tale nome. Il problema dipende da una serie di fattori, tra cui la produttività e l'immenso cuneo fiscale che grava sulle spalle di aziende e lavoratori: qualcosa come il 55%.
La necessità di sostenere le famiglie con paghe sufficienti a stimolare i consumi è un fatto econometrico, ma anche degno di riflessione da parte di un governo. Il reddito di cittadinanza vorrebbe essere una risposta: non sappiamo se funzionerà. Ma rispondere al tema come hanno fatto opposizione e Confindustria appare un po' riduttivo, e pure offensivo: «Gli italiani», hanno detto, «non andranno a lavorare se il reddito varrà più degli stipendi». Forse sarebbe meglio domandarsi perché le buste paga sono così povere, e cercare di alzarle. Non lo si può fare per decreto, ma non ragionarci sarebbe delittuoso dal punto di vista sociale.
Ecco perché il Rapporto sul mercato del lavoro 2018 diffuso ieri da Inps, Istat, Inail e Anpal preoccupa. Sia per il risultato, sia per l'effetto mediatico che rischia di produrre. Nel documento si parla in modo diffuso del rapporto tra impiego e grado di istruzione. Ne risulta che un occupato su quattro è troppo istruito per il lavoro che fa. Nel 2017 circa un milione di occupati ha lavorato meno ore di quelle per cui sarebbe stato disponibile, mentre la schiera dei sovraistruiti ammonta a 5.569.000 persone: quasi un occupato su 4. Viene sottolineato che negli anni il fenomeno risulta «in continua crescita, sia in virtù di una domanda di lavoro non adeguata al generale innalzamento del livello di istruzione, sia per la mancata corrispondenza tra le competenze specialistiche richieste e quelle possedute». Ne consegue che la mancanza di opportunità lavorative adeguate comporti la decisione di migrare all'estero. Un fenomeno in crescita negli ultimi anni: da 40.000 del 2008 a quasi 115.000 persone nel 2017.
Quindi in meno di dieci anni le fughe sono quasi triplicate. Lo studio è di per sé neutro, ma il rischio è che passi un messaggio straniante: serve manodopera meno istruita per rispondere alla domanda di basso livello. Un po' quello che il Pd sembra ventilare quando sostiene che il sussidio debba essere più basso non perché la spesa pubblica sarebbe insostenibile ma perché altrimenti le buste paga sarebbero fuori mercato.
Non stupisce sapere che i lavoratori italiani siano istruiti, ma fa impressione sapere che siano addirittura un quarto degli occupati. Quasi 5,7 milioni di persone. Non è dunque sbagliato ragionare su un reddito di inclusione più ampio. Un sistema politico che prenda atto della formazione di chi non è preparato alle nuove sfide e un sostegno a quelle filiere che sono assetate di lavoratori professionisti e specializzati. Il governo dovrebbe - assieme all'avvio dei cantieri - fare la «rivoluzione del cuneo». Basta tasse così pesanti sul reddito da lavoro. Ammazzano le aziende e azzerano la capacità di spesa. Se si vuole uscire dalla recessione è un passo da fare. Più deficit per portare avanti lo schema? Ecco un tema per cui vale la pena litigare in sede europea. Allo stesso tempo, vale la pena litigare su un altro nodo tanto caro ai sindacati italiani: quello dei contratti nazionali. «Nella stima preliminare del quarto trimestre 2018», si legge nel rapporto diffuso ieri, «torna a crescere lievemente l'occupazione permanente (+0,1%), dopo la caduta del terzo» ma è «il tempo determinato (+0,1%)» a toccare «il valore massimo di oltre 3,1 milioni di occupati». In dieci anni, tra il 2008 e il 2018, i dipendenti con contratto a tempo sono aumentati di 735.000 unità. Dovendo sradicate tali parametri non ha più senso discutere di contratti parificati tra Milano e Palermo. Un modo per adeguare gli importi al costo della vita è quello di dare libero sfogo ai contratti aziendali uniti a quelli regionali. Una sorta di scala mobile della quale l'Italia ora non può fare a meno. I lavoratori non cercano stabilità ma soldi. I vecchi sindacati non accetteranno mai di abdicare alle grandi trattative anacronistiche: firmerebbero la loro definitiva scomparsa. È, però, un freno da rimuovere. Al più presto.
Ogni italiano ha perso 73.000 euro da quando è nata la moneta unica
Premessa doverosa: i rischi non vanno negati ma affrontati, delineando scenari e contromisure adeguate. Tuttavia, come sottolineava ieri l'editoriale del direttore Maurizio Belpietro, colpisce il timing con cui la nostra grande stampa ingigantisce le nubi all'orizzonte, facendo sponda alle voci che dall'estero sembrano interessate a descrivere un'Italia alle corde.
Così, da giorni si alimenta un'emergenza bancaria ben oltre il reale stato delle cose: e, puntualissimo, ieri è arrivato un minaccioso report dello European economy advisory group, un gruppo di economisti guidato da un italiano (Giuseppe Bertola, Università di Torino) ma costituito dall'Istituto tedesco per la ricerca economica (Ifo). E, in supersintesi, che dice questo report? Sceglie il peggiore scenario possibile, la peggiore concatenazione di eventualità, con l'Italia colpevole di un effetto domino. Seguiamo il ragionamento: si parte dalla possibilità di un riaccendersi dello scontro sul bilancio tra governo italiano e Commissione Ue, si immagina un effetto sulle aste dei nostri titoli (con rendimenti drammaticamente al rialzo), e a quel punto si ipotizza un problema di solvibilità del nostro Paese. Non basta? Ancora no: perché, siccome titoli del nostro debito sono in «pancia» alle banche sia italiane sia estere, questo determinerebbe una crisi continentale e un effetto di contagio. Il governo italiano come il «grande untore», insomma.
Ora, lo ribadiamo nuovamente: non c'è dubbio sul fatto che si debbano tenere d'occhio le aste dei nostri titoli e l'andamento dei rendimenti; così come - non da ora - va considerato il tema delicato del portafoglio di titoli pubblici italiani detenuti dalle banche. Ma – una volta tanto – sarebbe anche il caso di considerare la massa di titoli «tossici» detenuti dalle banche tedesche e francesi, foriere di un non meno grave potenziale rischio sistemico. Contemporaneamente, sarebbe il caso di chiedere a Francoforte cosa attenda la Bce a mettere in campo nuove potenti forme di garanzia sui debiti sovrani in euro: il solo annuncio sarebbe un super estintore in grado di spegnere ogni principio d'incendio, e di ridurre il premio di rischio richiesto dagli investitori.
E ancora, rimanendo alla Bce, resta da capire quando Francoforte assumerà la decisione sul nuovo «giro» di Tlro che, secondo quanto si legge testualmente nei verbali dell'ultimo consiglio, «non dovrebbe essere presa con eccessiva fretta». Eppure l'urgenza c'è. Si tratta delle cosiddette operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (Targeted longer term refinancing operations), quindi di finanziamenti a tassi agevolati alle banche affinché facciano credito a famiglie e imprese.
Almeno nelle intenzioni, si tratta di misure volte a sostenere la liquidità delle banche e quindi – in seconda battuta – a ridurre fenomeni di credit-crunch. Sappiamo bene che le banche non hanno funzionato granché come cinghia di trasmissione verso l'economia reale, e quindi non c'è da attendersi effetti miracolosi. Ma senza questa misura le banche italiane sarebbero costrette a imponenti accantonamenti, e quindi a una pericolosa stretta creditizia.
Intanto, mentre i maggiori media italiani sono dediti all'autoflagellazione, ci sarebbe materia per riflessioni ben diverse. Secondo il rapporto «20 anni di Euro: vincitori e vinti» del Centre for european policy di Friburgo, la Germania emerge come principale percettore di benefici, e l'Italia come la maggiore vittima di danni. In media, ogni tedesco ha infatti guadagnato 23.000 euro da quando c'è l'euro, mentre ogni italiano, nello stesso arco di tempo, ne ha persi più di 73.000.
Il report centra un punto nodale: l'impossibilità per l'Italia di giocare la carta della svalutazione competitiva. Di qui una simulazione su quale sarebbe stato il Pil per ciascun paese in caso di mancata adozione dell'euro, e la sua suddivisione pro capite, che genera i guadagni e le perdite che abbiamo menzionato.
Continua a leggereRiduci
Secondo il Rapporto sul mercato del lavoro 2018, un occupato su quattro è troppo istruito per la mansione professionale svolta. Ma allora c'è da intervenire sulle retribuzioni, non evocare manodopera poco qualificata per soddisfare la domanda di basso livello.Il Cep di Friburgo certifica che solo Berlino ha guadagnato con l'introduzione dell'euro.Lo speciale contiene due articoliBisogna dare atto all'attuale governo di avere imparato a tirare fuori i problemi. A farli emergere. Purtroppo, al momento è complicato dire che sia altrettanto bravo a trovare le soluzioni. Il che non significa che ciò non avverrà in futuro. Nel frattempo, i gialloblù, portando in Parlamento il decretone sul reddito di cittadinanza, hanno imposto al dibattito politico il tema delle paghe dei lavoratori. Il trend dei precari era da anni in costante aumento, e il governo precedente si limitava a celebrare l'aumento costante del dato dell'occupazione. «Ottimo», diceva Paolo Gentiloni. Peccato che il record di 58% di persone con un'occupazione non corrisponda alla piena occupazione. Per rientrare nella lista, infatti, basta lavorare anche una sola ora a settimana, il che certamente non garantisce uno stipendio degno di tale nome. Il problema dipende da una serie di fattori, tra cui la produttività e l'immenso cuneo fiscale che grava sulle spalle di aziende e lavoratori: qualcosa come il 55%. La necessità di sostenere le famiglie con paghe sufficienti a stimolare i consumi è un fatto econometrico, ma anche degno di riflessione da parte di un governo. Il reddito di cittadinanza vorrebbe essere una risposta: non sappiamo se funzionerà. Ma rispondere al tema come hanno fatto opposizione e Confindustria appare un po' riduttivo, e pure offensivo: «Gli italiani», hanno detto, «non andranno a lavorare se il reddito varrà più degli stipendi». Forse sarebbe meglio domandarsi perché le buste paga sono così povere, e cercare di alzarle. Non lo si può fare per decreto, ma non ragionarci sarebbe delittuoso dal punto di vista sociale. Ecco perché il Rapporto sul mercato del lavoro 2018 diffuso ieri da Inps, Istat, Inail e Anpal preoccupa. Sia per il risultato, sia per l'effetto mediatico che rischia di produrre. Nel documento si parla in modo diffuso del rapporto tra impiego e grado di istruzione. Ne risulta che un occupato su quattro è troppo istruito per il lavoro che fa. Nel 2017 circa un milione di occupati ha lavorato meno ore di quelle per cui sarebbe stato disponibile, mentre la schiera dei sovraistruiti ammonta a 5.569.000 persone: quasi un occupato su 4. Viene sottolineato che negli anni il fenomeno risulta «in continua crescita, sia in virtù di una domanda di lavoro non adeguata al generale innalzamento del livello di istruzione, sia per la mancata corrispondenza tra le competenze specialistiche richieste e quelle possedute». Ne consegue che la mancanza di opportunità lavorative adeguate comporti la decisione di migrare all'estero. Un fenomeno in crescita negli ultimi anni: da 40.000 del 2008 a quasi 115.000 persone nel 2017. Quindi in meno di dieci anni le fughe sono quasi triplicate. Lo studio è di per sé neutro, ma il rischio è che passi un messaggio straniante: serve manodopera meno istruita per rispondere alla domanda di basso livello. Un po' quello che il Pd sembra ventilare quando sostiene che il sussidio debba essere più basso non perché la spesa pubblica sarebbe insostenibile ma perché altrimenti le buste paga sarebbero fuori mercato. Non stupisce sapere che i lavoratori italiani siano istruiti, ma fa impressione sapere che siano addirittura un quarto degli occupati. Quasi 5,7 milioni di persone. Non è dunque sbagliato ragionare su un reddito di inclusione più ampio. Un sistema politico che prenda atto della formazione di chi non è preparato alle nuove sfide e un sostegno a quelle filiere che sono assetate di lavoratori professionisti e specializzati. Il governo dovrebbe - assieme all'avvio dei cantieri - fare la «rivoluzione del cuneo». Basta tasse così pesanti sul reddito da lavoro. Ammazzano le aziende e azzerano la capacità di spesa. Se si vuole uscire dalla recessione è un passo da fare. Più deficit per portare avanti lo schema? Ecco un tema per cui vale la pena litigare in sede europea. Allo stesso tempo, vale la pena litigare su un altro nodo tanto caro ai sindacati italiani: quello dei contratti nazionali. «Nella stima preliminare del quarto trimestre 2018», si legge nel rapporto diffuso ieri, «torna a crescere lievemente l'occupazione permanente (+0,1%), dopo la caduta del terzo» ma è «il tempo determinato (+0,1%)» a toccare «il valore massimo di oltre 3,1 milioni di occupati». In dieci anni, tra il 2008 e il 2018, i dipendenti con contratto a tempo sono aumentati di 735.000 unità. Dovendo sradicate tali parametri non ha più senso discutere di contratti parificati tra Milano e Palermo. Un modo per adeguare gli importi al costo della vita è quello di dare libero sfogo ai contratti aziendali uniti a quelli regionali. Una sorta di scala mobile della quale l'Italia ora non può fare a meno. I lavoratori non cercano stabilità ma soldi. I vecchi sindacati non accetteranno mai di abdicare alle grandi trattative anacronistiche: firmerebbero la loro definitiva scomparsa. È, però, un freno da rimuovere. Al più presto.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/abbiamo-5-569-000-lavoratori-sottopagati-2629994185.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="ogni-italiano-ha-perso-73-000-euro-da-quando-e-nata-la-moneta-unica" data-post-id="2629994185" data-published-at="1769579731" data-use-pagination="False"> Ogni italiano ha perso 73.000 euro da quando è nata la moneta unica Premessa doverosa: i rischi non vanno negati ma affrontati, delineando scenari e contromisure adeguate. Tuttavia, come sottolineava ieri l'editoriale del direttore Maurizio Belpietro, colpisce il timing con cui la nostra grande stampa ingigantisce le nubi all'orizzonte, facendo sponda alle voci che dall'estero sembrano interessate a descrivere un'Italia alle corde. Così, da giorni si alimenta un'emergenza bancaria ben oltre il reale stato delle cose: e, puntualissimo, ieri è arrivato un minaccioso report dello European economy advisory group, un gruppo di economisti guidato da un italiano (Giuseppe Bertola, Università di Torino) ma costituito dall'Istituto tedesco per la ricerca economica (Ifo). E, in supersintesi, che dice questo report? Sceglie il peggiore scenario possibile, la peggiore concatenazione di eventualità, con l'Italia colpevole di un effetto domino. Seguiamo il ragionamento: si parte dalla possibilità di un riaccendersi dello scontro sul bilancio tra governo italiano e Commissione Ue, si immagina un effetto sulle aste dei nostri titoli (con rendimenti drammaticamente al rialzo), e a quel punto si ipotizza un problema di solvibilità del nostro Paese. Non basta? Ancora no: perché, siccome titoli del nostro debito sono in «pancia» alle banche sia italiane sia estere, questo determinerebbe una crisi continentale e un effetto di contagio. Il governo italiano come il «grande untore», insomma. Ora, lo ribadiamo nuovamente: non c'è dubbio sul fatto che si debbano tenere d'occhio le aste dei nostri titoli e l'andamento dei rendimenti; così come - non da ora - va considerato il tema delicato del portafoglio di titoli pubblici italiani detenuti dalle banche. Ma – una volta tanto – sarebbe anche il caso di considerare la massa di titoli «tossici» detenuti dalle banche tedesche e francesi, foriere di un non meno grave potenziale rischio sistemico. Contemporaneamente, sarebbe il caso di chiedere a Francoforte cosa attenda la Bce a mettere in campo nuove potenti forme di garanzia sui debiti sovrani in euro: il solo annuncio sarebbe un super estintore in grado di spegnere ogni principio d'incendio, e di ridurre il premio di rischio richiesto dagli investitori. E ancora, rimanendo alla Bce, resta da capire quando Francoforte assumerà la decisione sul nuovo «giro» di Tlro che, secondo quanto si legge testualmente nei verbali dell'ultimo consiglio, «non dovrebbe essere presa con eccessiva fretta». Eppure l'urgenza c'è. Si tratta delle cosiddette operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (Targeted longer term refinancing operations), quindi di finanziamenti a tassi agevolati alle banche affinché facciano credito a famiglie e imprese. Almeno nelle intenzioni, si tratta di misure volte a sostenere la liquidità delle banche e quindi – in seconda battuta – a ridurre fenomeni di credit-crunch. Sappiamo bene che le banche non hanno funzionato granché come cinghia di trasmissione verso l'economia reale, e quindi non c'è da attendersi effetti miracolosi. Ma senza questa misura le banche italiane sarebbero costrette a imponenti accantonamenti, e quindi a una pericolosa stretta creditizia. Intanto, mentre i maggiori media italiani sono dediti all'autoflagellazione, ci sarebbe materia per riflessioni ben diverse. Secondo il rapporto «20 anni di Euro: vincitori e vinti» del Centre for european policy di Friburgo, la Germania emerge come principale percettore di benefici, e l'Italia come la maggiore vittima di danni. In media, ogni tedesco ha infatti guadagnato 23.000 euro da quando c'è l'euro, mentre ogni italiano, nello stesso arco di tempo, ne ha persi più di 73.000. Il report centra un punto nodale: l'impossibilità per l'Italia di giocare la carta della svalutazione competitiva. Di qui una simulazione su quale sarebbe stato il Pil per ciascun paese in caso di mancata adozione dell'euro, e la sua suddivisione pro capite, che genera i guadagni e le perdite che abbiamo menzionato.