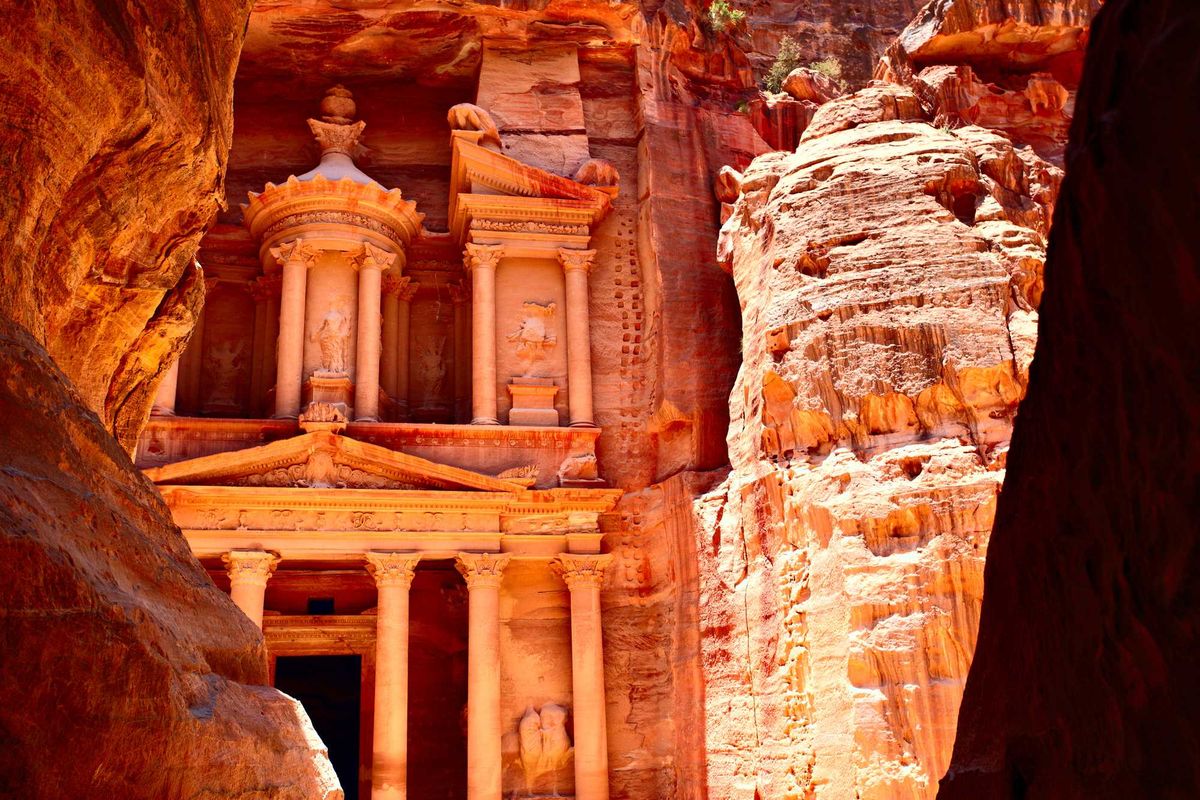Riprendiamo il viaggio intorno al confetto. Nel Rinascimento i confetti sono molto apprezzati nei palazzi delle signorie. Alle nozze tra Beatrice d’Este e Ludovico il Moro vennero serviti 300 chicchi dorati e confettati. Se non erano confetti come quelli degli sposi di adesso, li somigliavano tanto.
Per trovare la mandorla nei confetti dobbiamo attendere la fine del Quattrocento a Sulmona, cittadina abruzzese in provincia de L’Aquila e famosa per aver dato i natali nel 43 avanti Cristo a Publio Ovidio Nasone, uno dei più grandi poeti romani, autore delle Metamorfosi. Ovidio e i confetti sono la gloria e la storia di Sulmona. Nell’archivio del Comune, alcuni documenti datati 1492-1493 testimoniano il primato storico della cittadina abruzzese nel produrre confetti equiparabili ai moderni. La produzione di confetti continua tutt’oggi a Sulmona: non è più solo tradizione e tipicità, è anche un settore imprenditoriale diventato un pilastro dell’economia cittadina. I confetti di Sulmona sono diventati così importanti che anche il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali li ha inseriti nella lista dei Prodotti agroalimentari tipici, attribuendo loro il marchio Pat.
A dare una mano artistica alla fama dei confetti di Sulmona si aggiunse la bravura, nel Cinquecento, delle monache del monastero di Santa Chiara. Mani benedette e abilissime le loro: intrecciando fili di seta e confetti fabbricarono autentici pezzi d’arte: grappoli, spighe, rosari, fiori... Ecco che da allora i confetti non benedirono più soltanto le nozze laiche, ma anche quelle mistiche: lo sposalizio con Dio, i voti di monache e sacerdoti che si consacrano a Dio. Anche i religiosi, come gli sposi, distribuiscono santini e confetti. I bonbon italiani coperti di zucchero e con la mandorla all’interno conoscono presto un successo che valica le Alpi. Entrano nei fastosi salotti delle corti europee dove vengono riposti in lussuose bomboniere cesellate d’oro, d’argento, di avorio o madreperla.
È proprio da questa voce onomatopeica infantile, bonbon, che sottolinea la bontà di un piccolo dolce, che nasce nel Settecento o giù di lì la bomboniera italiana e la bombonnière francese, preziosa scatoletta che conteneva i dolcetti due volti buoni: i bonbon appunto. Alcuni studiosi del costume italiano suggeriscono che la bomboniera fosse già in uso in Italia nel Quattrocento. Si usava nei fidanzamenti principeschi o almeno nobiliari. I futuri sposi e le rispettive famiglie si scambiavano scatolette gioiello porta confetti. Il giorno delle nozze, poi, il fidanzato donava alla prossima sposa una «coppa amatoria», un piatto prezioso contenente confetti.
Quei dolcetti avevano un significato simbolico: portavano gli auguri di fecondità e prosperità nella vita comune che stavano per affrontare. Ma non fu in quell’epoca che nacque l’uso si donare, da parte degli sposi, la bomboniera agli invitati. Anche perché la quasi totalità del popolo aveva appena di che mangiare figurarsi se poteva permettersi di donare regali. A quanto pare questo dono divenne di moda alla fine del’Ottocento quando si sposarono il futuro re d’Italia Vittorio Emanuele III con Elena del Montenegro. Furono loro a distribuire agli invitati il cosiddetto «dono degli sposi», una bomboniera: una tradizione divenuta in seguito popolare, non riservata alla sola borghesia o nobiltà.
Anche chi non aveva da scialare per un’occasione importante come le nozze poteva permettersi di distribuire un po’ di confetti. La tradizione diviene più importante nel dopoguerra, negli anni del boom economico e del boom dei matrimoni. Ecco che compare la bomboniera. Quanti confetti deve contenere? Un numero dispari. Cinque è il numero perfetto perché ogni confetto è latore di un augurio: fertilità, lunga vita, salute, ricchezza e felicità. A tradizione si aggiunge tradizione: molti sposi, durante il banchetto nuziale, passano tra gli invitati distribuendo ancora confetti: la sposa, la quale li dovrà prendere con un grande cucchiaio in argento da un vassoio, anch’esso in argento, tenuto dallo sposo. Infine c’è il lancio dei confetti all’uscita della chiesa (ora si lancia il riso) a favore dei ragazzini che si contendevano i confetti a spintoni e calci. Tanto che in dialetto siciliano tale gazzarra veniva chiamata sciarra (rissa).
La letteratura italiana è seminata di confetti e di scrittori che hanno scritto pagine immortali succhiando golosamente i bonbon con la mandorla. Giovanni Boccaccio li nomina nella terza novella e Folgore da San Gimignano in un sonetto. Una delle pagine più simpatiche è nei Promessi sposi di Alessandro Manzoni. Quando Don Abbondio torna nella sua sagrestia dopo l’incontro con i Bravi che gli proibiscono di sposare Renzo e Lucia, per ordine di Don Rodrigo, e confida terrorizzato a Perpetua quello che gli è successo, lei lo consiglia di andare dall’arcivescovo. Lui, spaventato a morte, le intima di tacere: «Son pareri codesti da dare a un pover’uomo? Quando mi fosse toccata una schioppettata nella schiena, Dio liberi! L’arcivescovo me la leverebbe?». «Eh! le schioppettate non si danno via come confetti: e guai se questi cani dovessero mordere tutte le volte che abbaiano! E io ho sempre veduto che a chi sa mostrare i denti e farsi stimare, gli si porta rispetto».
Giacomo Leopardi era goloso di cannellini, confetti con all’interno un cuore di cannella. Durante il periodo napoletano nel quale fu ospite dei fratelli Antonio e Paola Ranieri poté soddisfare i suoi desideri di gelati e confetti cannellini. Pare che ne fece una scorpacciata anche nel suo ultimo giorno di vita. Qualche studioso riferisce che la sua ultima richiesta fu poter succhiare un confetto, ma molti testimoni, compreso il Ranieri, negano: chiese un gelato che gli fu negato dal medico perché «gli fa male».
Il dono dei confetti è testimoniato in molte opere. Giovanni Verga racconta nella novella Eros: «La marchesa, sempre giovane, ed elegante, la più bella toscana che fosse in Milano, andava a fargli visita una volta all’anno, quando c’erano le corse a Firenze, l’abbracciava, l’accarezzava, gli recava dei confetti, e rimontava in carrozza sorridente». Anche Goethe amava i confetti e regalò alla sua futura moglie, uno scrigno che ne era colmo.
Carlo Collodi regalò a Pinocchio una testa di legno, ma il burattino dimostrava di usarla. Non si lasciò corrompere da una buona donna che gli chiese di portare un’anfora piena di acqua fino a quando, questa non gli promise un confetto col rosolio. «Se mi aiuti a portare a casa una di queste brocche d’acqua, ti darò un bel pezzo di pane». Pinocchio guardò la brocca e non rispose né si né no. «E insieme col pane ti darò un bel piatto di cavolfiore condito coll’olio e coll’aceto» Pinocchio dette un’altra occhiata alla brocca e non rispose né si né no. «E dopo il cavolfiore ti darò un bel confetto ripieno di rosolio». Alle seduzioni di quest’ultima ghiottoneria, Pinocchio non seppe più resistere e disse: «Pazienza! Vi porterò la brocca fino a casa».
Scrissero di confetti anche Giosuè Carducci, Gabriele D’Annunzio, Giovanni Pascoli. Commovente la lettera di quest’ultimo alla sorella Mariù: il giorno prima era la festa della sorella, ma lui si era ritrovato col portafogli vuoto e non aveva potuto comperarle un regalino. «Cara Mariuccia. Ieri non sono stato contento; nel mio cuore turbato e nel mio borsellino vuoto non potei trovare di farti un sorriso e pagarti un cartoccio di confetti; ed era la tua festa; e fu la mia disperazione, povera Mariuccina. Ma via promettimi che t’offra oggi i confetti di ieri, e tu fammi ora il sorriso che allora io non ti potei fare. Non aver ieri quel pochissimo che ti bisogna! Un sorriso e una mano di confetti!».