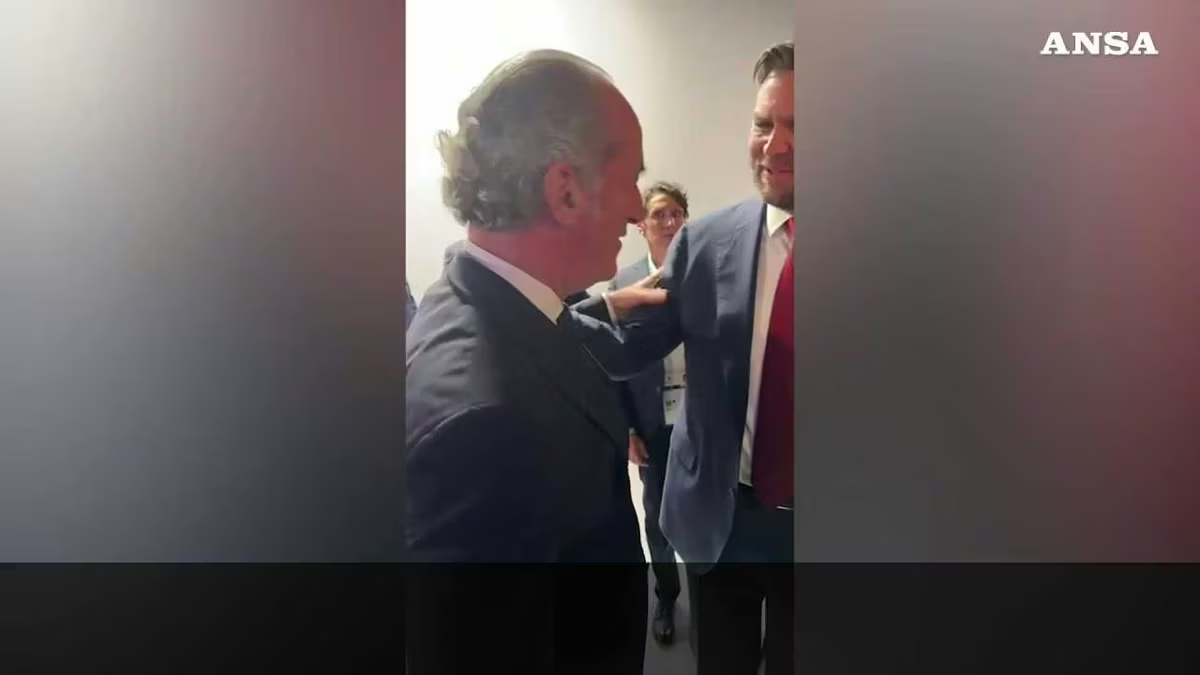Se il 14 febbraio, giorno di san Valentino, i cuori degli innamorati batteranno più forte del solito e miliardi di baci sfideranno il Coronavirus (è proibito baciarsi con la mascherina) la colpa è dei grandi padri della letteratura inglese: Geoffrey Chaucer e William Shakespeare. Il primo, poetando che nel giorno di san Valentino gli uccelli scelgono la loro compagna, inventò di fatto la giornata degli innamorati dando il via alla romantica tradizione durata dal medioevo fino all'avvento del cellulare, di spedire valentine (biglietti decorati o cartoline d'amore) all'amata lei o al bramato lui con la speranza di aprirgli il cuore. Il secondo incrementò la fama del santo patrono degli amanti mettendo in bocca alla dolce, sventurata Ofelia parole traboccanti d'infelice amore: «Sarà domani San Valentino,/ ci leveremo di buon mattino,/ alla finestra tua busserò,/ la Valentina tua diventerò».
Riparte da san Valentino, tra sei giorni in calendario, il viaggio alla scoperta dei dolci dei santi (la prima puntata è uscita sabato 25 gennaio). In tutta Italia il santo patrono dei fidanzati griffa torte, ciambelle, cioccolatini, biscotti. Decorati, glassati, marmellatati, cioccolatati, confettati, ma tutti con la stessa forma: a cuore. San Valentino è il santo più dolce che ci sia. A Terni, sua città natale, le pasticcerie offrono di tutto e di più: dai cuori di pastafrolla guarniti con confettini multicolorati ai cioccolatini al caramello salato. A Bussolengo, piccola capitale degli innamorati sulla strada tra Verona e il lago di Garda, la venerazione del santo patrono al quale è dedicata una magnifica chiesa affrescata del '300, il dolce tipico è il Bacio di San Valentino accompagnato dal detto di Guy de Maupassant: «Il bacio è il modo più semplice di tacere, dicendo tutto». Ogni anno il Comune indice un concorso di pasticceria, aperto ai non professionisti, per premiare il dolce di san Valentino dell'anno. Unico obbligo: dev'essere rosso. Come il cuore.
In calendario c'è una santa che, in tema d'amore, almeno a Livorno, fa concorrenza a san Valentino. È Caterina d'Alessandria, vergine e martire molto venerata nel medioevo. Nella città toscana, il 25 novembre, giorno della santa, si perpetua un'antica tradizione: le livornesi, fidanzate o sposate, regalano ai propri uomini le Mele di santa Caterina, dolcetti di marzapane a forma di pomo. Contraccambiano così i Fruttini d'amore, pure in pasta di mandorle, donati dai loro uomini ad Ognissanti. Il 25 novembre era un giorno speciale nel lunario contadino: lo si considerava, di fatto, il primo giorno dell'inverno, quello in cui si accendeva il fuoco nel camino e le stufe in cotto nelle scuole: «Per santa Caterina», recita il proverbio, «tira fuori la fascina». Come tutti i giorni speciali per la civiltà contadina, anche questo doveva essere celebrato con dolcetti ad hoc. In Romagna, soprattutto nel ravennate, si rispetta ancora l'antica tradizione di donare ai bambini le caterine di pastafrolla decorate con zucchero colorato (oggidì ricoperte di cioccolato) e confettini variopinti: alle femminucce bamboline o galline; ai maschi galletti. Aldo Spallicci, medico e poeta di Bertinoro, in una poesia in romagnolo pubblicata negli anni Venti del '900, invitava i bambini a piangere per avere le caterine: «Par Santa Catarena e gal e la galèna, la bëla bambuzena, pianzi burdel s'avlì di brazadel». E cioè: per santa Caterina il gallo e la gallina, la bella bambolina; piangi bambino se vuoi il biscottino.
Alle caterine di Romagna, l'Emilia risponde, un mese e mezzo dopo, con le Scarpette di sant'Ilario. Il dolce è tipico di Parma dove il santo di Poitiers, patrono della città, è festeggiato il 13 gennaio. Le scarpette nascono da una simpatica leggenda che racconta il passaggio di sant'Ilario (IV secolo) da Parma. Il vescovo francese, ricco di sapienza, ma povero in canna, girava con calzari talmente malridotti che un ciabattino si commosse e gliene regalò un paio di nuovi. Il giorno dopo, quando aprì bottega, il calzolaio trovò al posto delle sbrindellate calzature del santo un paio di scarpe d'oro. Da allora, per ricordare il miracolo, a Parma si infornano e si mangiano, magari intinti nella dolce Malvasia dei vicini colli, biscotti glassati a forma di scarpetta.
Pare impossibile, ma anche Francesco d'Assisi, nella sua santa sobrietà, commise un peccatuccio di gola, ma fu talmente veniale che merita che se ne parli. Quando il Poverello si recò a Roma nel 1210 conobbe Jacopa Frangipane de' Settesoli, una ricca nobildonna che, convertita dalle parole di Francesco, ne divenne una seguace fedele. Tra una predica e l'altra Francesco ebbe modo di assaggiare, grazie a Jacopa, alcuni biscotti «boni e profumosi» tipici dell'Urbe: i mostaccioli. I dolcetti, fatti con pasta di pane, mandorle tritate, un po' di miele e mosto d'uva, piacquero talmente al santo frate che, poco prima di morire, scrisse alla nobildonna romana di venirlo a trovare portandogli un panno e dei ceri per la sepoltura e quei biscotti che aveva mangiato a Roma e che da lui presero il nome: i mostaccioli di San Francesco.
Da san Francesco a santa Chiara il passo è breve anche se dobbiamo scendere nella Penisola fino a Noto, nel siracusano. Nella capitale del barocco siciliano non si può fare a meno di assaggiare i Facciùni di santa Chiara, antichi e godibilissimi dolcetti fatti con pasta reale (di mandorle), pan di Spagna, un pizzico di cannella e ricoperti con una glassa di zucchero o cioccolato decorata a spirale o con diavoletti di zucchero colorato. Si chiamano facciuni perché un tempo venivano avvolti in un incarto che riproduceva il volto paffuto di un angelo; di santa Chiara in quanto la tradizione li attribuisce alle clarisse del locale monastero. La loro storicità è testimoniata dal padre del Verismo, Giovanni Verga, che li citò nella novella La vocazione di Sant'Agnese. I facciùni di santa Chiara sono stati inseriti dal ministero delle Politiche agricole nel registro dei Prodotti agroalimentari tradizionali (Pat) della Sicilia.
Potevano i napoletani lasciare san Gennaro senza dolci? No. 'O dolce 'e San Gennaro è un biscottone fatto a ciambella, morbido al morso, fatto apposta per chi non ha denti buoni. La storia partenopea racconta che 'O biscotto all'uovo e limone, il nome con il quale è più conosciuto perché fatto con farina, uovo sbattuto, limone, zucchero e cannella q.b., cotto in forno chjànu chjànu, sia stato ideato nel tempo che fu dalle angeliche Figlie della Carità, le suore con la tonaca blu e il candido copricapo ad ali d'angelo, dello Spitale 'e San Gennaro 'e Povere, nel quartiere Sanità, per i derelitti pazienti che vi si trovavano ricoverati. Il 19 settembre, giorno del martirio di san Gennaro (fu decapitato sotto Diocleziano nel 304), le caritatevoli monache preparavano il soffice dolce per i malati dell'ospedale, in modo che tutti potessero mangiarlo, far festa e ringraziare il santo patrono della città.
Infine, i brigidini di Lamporecchio. Il nome è legato alle suore del convento di santa Brigida di Pistoia, chiamate brigidine dal nome della mistica svedese vissuta nel 14° secolo e che si festeggia il 23 luglio. La leggenda racconta che le religiose pistoiesi, incaricate di produrre tramite piastre arroventate le ostie da consacrare durante le messe, siano state santamente ispirate a impastare con la farina anche uova, zucchero, miele e semi di anice ricavandone, dopo averle cotte usando lo stesso procedimento usato per le ostie. Non c'è sagra in Toscana sulla quale non aleggi il profumo di anice.