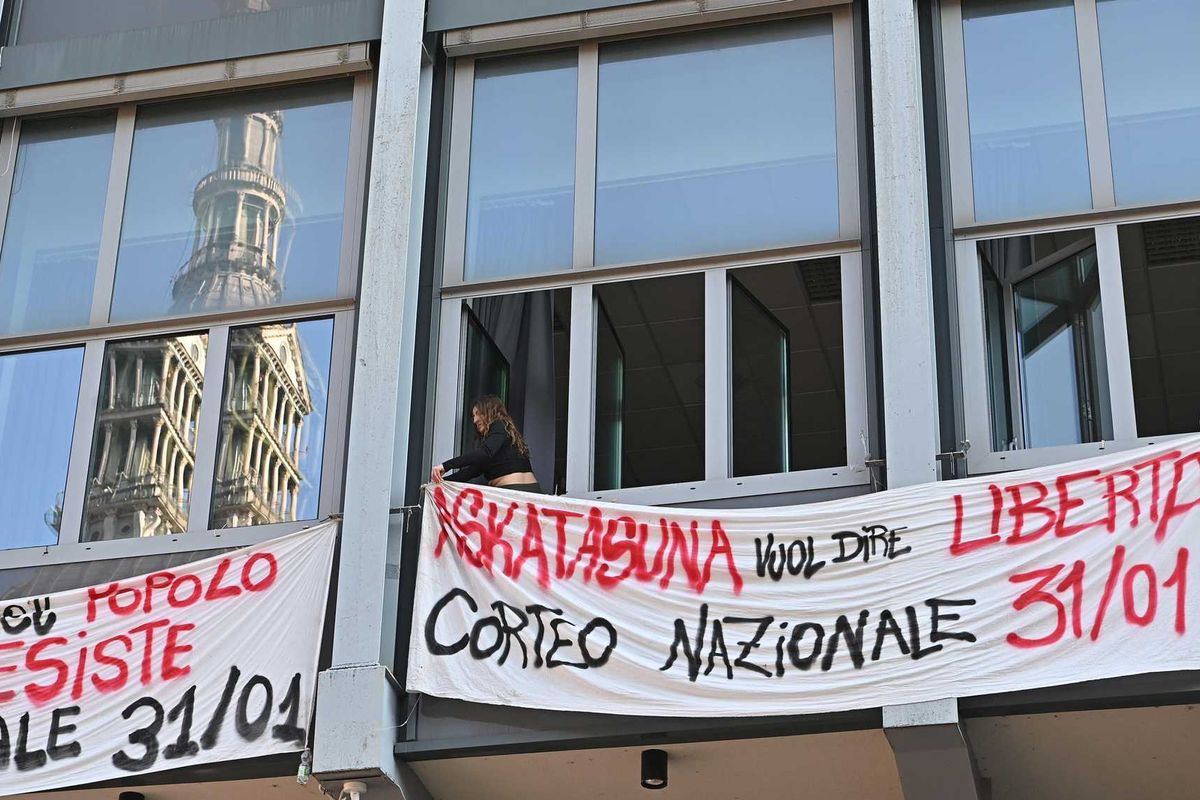Un salvadanaio è anfora e metafora di una vita nella quale finiamo spesso per pesare tutto, per misurarci col resto del mondo, una fessura in cui cerchiamo di infilare l'occhio per spiare la felicità altrui, nella quale spingiamo, a volte forzandone l'ingresso fino a deformarle, le nostre aspettative o le nostre paure da occultare agli occhi indiscreti. Perché? Chi lo ha deciso? Chi sfrutta la buona fede della gente acquisendo e gestendo i nostri risparmi? Come possiamo difenderci, utilizzando la fede e anche il cervello?
Il libro di Riccardo Pedrizzi prova a spiegarcelo ponendo l'essere umano al centro di tutte le analisi, sia rispetto ai guasti di un sistema economico e finanziario immorale che ci asfissia, che nella difficoltà che originano invece dalle aspettative abnormi che il singolo individuo ripone su quello stesso sistema. L'approccio è quello della dottrina sociale della Chiesa, le conclusioni dell'autore sono spesso simili, talvolta diverse, ma non per questo meno interessanti. Il demone del denaro, si intitola uno dei capitoli di questo libro: verrebbe voglia di chiedersi come mai uno strumento che ci aiuta nella vita di tutti i giorni possa apparire all'uomo di fede una minaccia alla propria identità, alla spiritualità e alla pacifica convivenza nella città di Dio. La risposta è nelle Sacre Scritture: «L'amore del denaro è la radice di ogni sorta di cose dannose» (Timoteo 6:10). L'amore, quello che va destinato al prossimo, al mondo, a Dio, non il denaro in sé. La Chiesa, in un mondo in cui la finanza speculativa, i mercati «demoniaci» si alimentano fagocitando illusioni umane di ricchezza - lasciando sul campo un esercito di disperati, sedotti e abbandonati dall'amore per il denaro – ha un compito ancora più importante e significativo degli scorsi anni: accendere la luce sulle coscienze di chi guida le economie globalizzate ma anche sulle menti obnubilate (e spesso disinformate) di chi rincorre chimere di facili guadagni o è ostaggio di demoni ingannevoli di una provvidenza terrena.
I poveri, nel mondo, quelli che non ce la fanno e si umiliano nella ricerca della sopravvivenza o, peggio ancora, si nascondono per la vergogna di non farcela, sono quell'esercito disarmato al quale la Chiesa cattolica e più in generale i leader spirituali riservano da sempre la propria opzione preferenziale. Ma anche ai ricchi frustrati dalla corsa quotidiana all'accaparramento di beni, che percorrono scorciatoie per una felicità lastricata di soldi e di vuoti interiori. A tutti loro il Magistero parla ogni giorno e propone le proprie ricette economiche e spirituali, nelle quali il Pil non si costruisce sul valore dello spread ma sullo «spread» dei valori tra coscienza ed egoismo.
[...] Una società nella quale l'economia è eticamente sostenibile è un obiettivo possibile, secondo Pedrizzi, che cita Papa Bergoglio, da sempre in prima fila nel condannare le logiche oligarchiche dell'economia global di questa epoca: «Il potere economico è uno strumento che produce tesori che si tengono solo per sé, nascondendoli agli altri, esso produce iniquità, perde la sua originaria valenza positiva», ha scritto recentemente. [...] Del resto, interrogarsi oggi sulla genesi del pensiero economico dei cattolici, in una società in ostaggio dei mercanti del tempio, è un esercizio di Realpolitik prima ancora che di fede. Il pensiero di colui che è considerato la «testa» cattolica più lucida del secolo scorso, il filosofo spagnolo Donoso Cortés, diceva allora ciò che oggi è evidente, anche dalla lettura di questo libro, quando ammoniva sulla difficoltà di conciliare «le utopie liberali con le leggi naturali della vita, con i dogmi della fede cattolica, con la stessa realtà quotidiana», come ricordava Pedrizzi nel suo «I Proscritti».
Il libro «Il salvadanaio», invece, guarda avanti, parla all'uomo, al cristiano, prima ancora che al politico, al banchiere, al finanziere, al legislatore, al controllore. Lo fa nel segno della Dottrina sociale della Chiesa che richiama il senso alto della solidarietà, della generosità, nell'utilizzo dei beni, del profitto stesso, indicando un legame invisibile e pur profondo fra guadagno e dono, che il peccato e l'egoismo spesso recidono, spazzano via. Compito dei cristiani è guardarsi intorno, analizzare, concludere, ma prima ancora rendersi conto della realtà che li circonda, che cambia, che va compresa prima di essere giudicata. «Poca osservazione e molto ragionamento conducono all'errore; molta osservazione e poco ragionamento conducono alla verità», è una famosa frase del biologo francese, convertitosi al cattolicesimo, Alexis Carrel, nelle sue «Riflessioni sulla condotta della vita», ma anche il motto di Pio XI: il suo «Osservare, giudicare ed agire» può restituire bene l'idea di quanto possa rivelarsi utile un libro che pur presentandosi come un vero e proprio manuale di economia e finanza che dovrebbe avere come caratteristica peculiare l'aridità delle cifre, ospita nelle sue righe lo spirito dei grandi papi della dottrina della chiesa: Leone XIII, Pio XI, san Giovanni Paolo II, papa Ratzinger, ma che esprime anche la sensibilità di grandi pensatori cattolici, quelli che ammonivano dalle tentazioni rivoluzionarie, come De Maistre e Peguy, che consideravano tutte le rivoluzioni come delle vere e proprie epifanie del male e del peccato, responsabili, quindi, dell'instaurazione di un sistema che ha messo sull'altare il nuovo idolo, il denaro.
La fede è l'antidoto, certo, ma perfino prima c'è l'etica, che per l'economista cattolico contemporaneo, Francesco Vito, doveva essere considerata prioritaria rispetto a tutti gli altri temi economici, «di fronte alle perversità del mercato», al punto da dover essere inserita tra gli obiettivi di politica economica dello Stato.
Pensatori come lui, considerati non ortodossi rispetto al pensiero «unico» del profitto, sono da porre al centro di ogni riflessione, perché credere in Dio, oggi, vuole dire anche credere in se stessi, nella propria spiritualità, nella propria capacità di leggere la vita, e anche l'economia, con gli occhi della solidarietà, senza per questo negare l'esistenza e talvolta la necessità di innescare meccanismi economici di risparmio, all'interno di sistemi complessi nei quali il denaro è strumento di arricchimento per alcuni più che per altri.
«Non sappiamo se chi è rimasto coinvolto nei più recenti scandali bancari e finanziari abbia sentito un qualche rimorso per le sue malefatte, certo è che l'insegnamento evangelico potrebbe essere collocato a chiusura del dispositivo delle sentenze che ne dovessero pronunciare la condanna», scrive il senatore Pedrizzi in uno dei capitoli in cui analizza gli scandali bancari e i «tradimenti» consumati ai danni dei risparmiatori. È vero. Ha ragione: chi svolge un'attività economica non può non avere la consapevolezza di essere prima di tutto al servizio della comunità e della economia nazionale, se vuole che l'uomo resti e sia al centro dell'impresa. La morale non è solo personale, quando si gestiscono soldi e sacrifici altrui, è pubblica, è da porre sotto i riflettori, da sottoporre al vaglio della res pubblica, e per chi ha il dono, anche della fede. «L'economia, infatti, come ogni altro ambito umano, ha bisogno dell'etica per il suo corretto funzionamento, non di un'etica qualsiasi bensì di un'etica amica della persona» è un brano dell'Enciclica di Benedetto XVI «Caritas in Veritate»), concetti che hanno anticipato le riflessioni sull'etica della finanza di Papa Francesco in «Laudato si'». Da non dimenticare le parole che San Giovanni Paolo II rivolse ai vertici di un importante gruppo bancario italiano nel 2004, riprese ne «Il salvadanaio», quando incitò il mondo del credito a non limitarsi al perseguimento del massimo profitto ma a far riferimento ai valori superiori del vivere umano, «se si vuole essere di aiuto alla crescita vera ed al pieno sviluppo della comunità».
[...] Leggere nel volume di Pedrizzi di regole, di trasparenza, di valori da portare in dote nella jungla della finanza, può riscaldare il cuore del cristiano, così come immergersi su temi come la famiglia, l'assistenza, la solidarietà, la cooperazione, la sussidiarietà, la partecipazione.
La recente crisi finanziaria poteva essere l'occasione per sviluppare una nuova economia più attenta ai principi etici e per una nuova regolamentazione dell'attività finanziaria, neutralizzandone aspetti predatori e speculativi e valorizzandone il servizio all'uomo, alla comunità locale e nazionale, invece sembra tornare un egoismo miope e limitato al corto termine. Dove le vie d'uscita? Equità, trasparenza, eticità degli interessi, sostenibilità di ogni operazione finanziaria, responsabilità, educazione e formazione adeguata degli operatori dell'ente erogatore del credito e di chi lo riceve, queste le risposte. Ma, in primis, un sentimento di imbarazzo, dolore, inadeguatezza, da provare, tutti noi, senza ipocrisia quando si pronuncia una parola come «povertà», rispetto all'indifferenza e alla faciloneria di chi ne annuncia l'abolizione per legge.