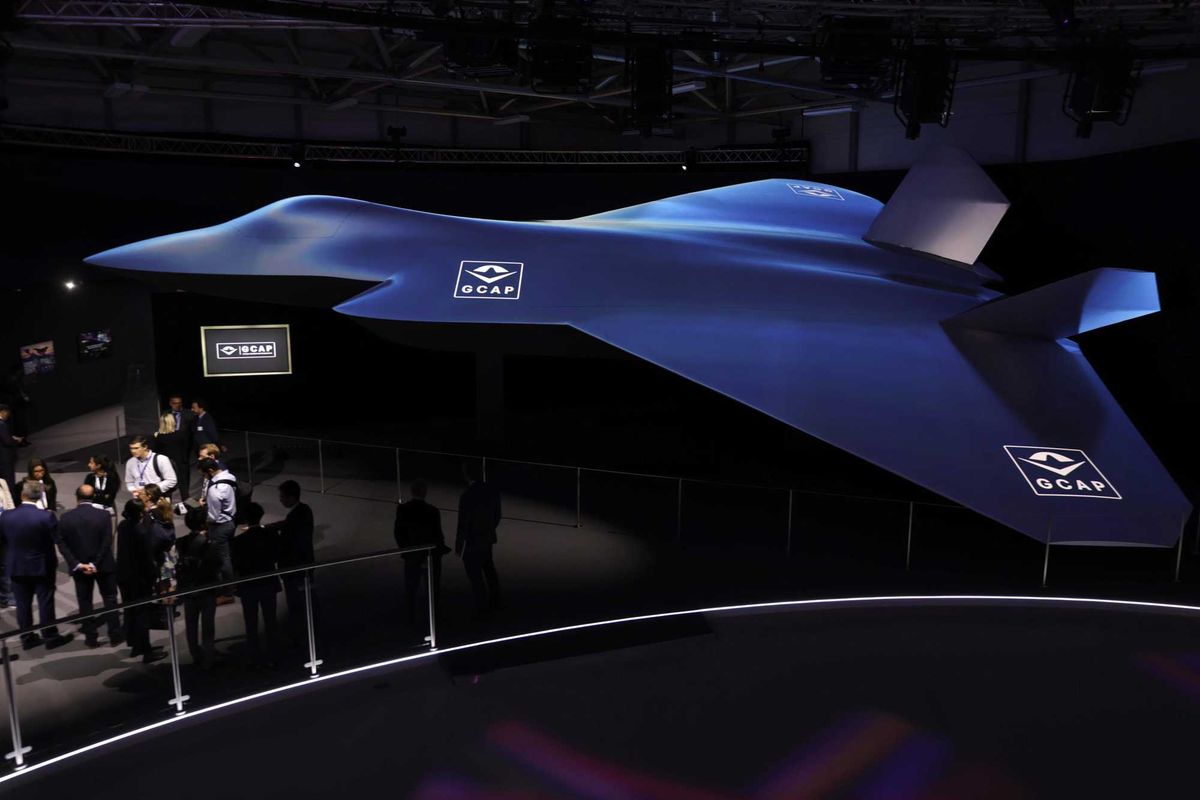Un salasso continuo per i nostri conti. Spesi 58 miliardi per aiutare gli altri

In principio fu il Fondo di stabilità economica e finanziaria (Efsf), istituito dall'Ecofin del 9 maggio 2010 in piena crisi economica. Mesi cruciali durante i quali la tenuta dell'eurozona sembrava in pericolo, con la Grecia ben instradata sulla strada del default e Irlanda e Portogallo a seguire a ruota. Più di due anni ci separavano dal fatidico «whatever it takes» di Mario Draghi e il quantitative easing era ancora in mente Dei. Fu così che, nel tentativo disperato di salvare capra e cavoli, i ministri delle Finanze dell'area euro decisero di mettere in piedi un «pacchetto complessivo di misure per preservare la stabilità finanziaria in Europa». L'Efsf, nato per durare fino al 31 dicembre 2012 (fu poi prorogato per sei mesi), aveva una potenza di fuoco pari a 500 miliardi di euro, 440 dei quali erogabili tramite una società veicolo speciale garantita dagli Stati dell'area euro sulla base delle quote del capitale nella Bce.
L'attivazione degli altri 60, invece, era soggetta a termini e condizioni simili a quelli dell'assistenza finanziaria erogata dal Fondo monetario internazionale. Solo una parte di questa montagna di soldi è stata effettivamente versata: dei 28,5 miliardi di euro totali, 5,1 sono stati corrisposti dall'Italia, terza dopo Germania (7,7 miliardi) e Francia (5,8). Secondo l'ultimo rapporto di Banca d'Italia Finanza pubblica: fabbisogno e debito, il nostro Paese ha sborsato per i prestiti agli Stati in difficoltà erogati tramite l'Efsf o in modalità bilaterale la bellezza di 43,9 miliardi di euro, una cifra pari al 2,6% del Prodotto interno lordo ed equivalente pressappoco all'importo di due leggi di stabilità. Una cifra che va a incrementare direttamente il nostro debito pubblico. Nel maggio 2010, immediatamente dopo la sua costituzione, l'Efsf contribuì al programma di aiuti alla Grecia, elargendo 80 miliardi di euro (altri 30 furono versati dal Fmi). A febbraio 2012 il Fondo, su un totale di 130 miliardi, versò ad Atene altri 102 miliardi di euro (la restante parte sempre a carico del Fmi). Gli altri Paesi a beneficiare dell'Efsf furono l'Irlanda a novembre 2010 (85 miliardi di cui 23 Fmi), e il Portogallo a maggio 2011 (78 miliardi, 26 Fmi).
Nel marzo 2011, il Consiglio europeo deliberò l'istituzione del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) in sostituzione dell'Efsf. Ciò fu possibile grazie alla modifica del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), ratificata nei mesi successivi da ogni Paese membro dell'Ue. L'adesione dell'Italia si ebbe a luglio 2012 quando a capo del governo c'era Mario Monti. Ai tempi la Camera approvò la norma con 380 voti a favore e 59 contrari (solo la Lega Nord) a seguito di un dibattito parlamentare piuttosto frettoloso. La scelta di modificare il Tfue non fu casuale e ha permesso di attribuire al Mes una forza senza pari nel corpus delle istituzioni europee.
Parlamento e Commissione sono esclusi dall'intero processo decisionale, cosa che se da un lato rende il Meccanismo di stabilità un'autorità indipendente dalla politica, dall'altro lo sottrae al controllo degli unici organi con una parvenza democratica nella Ue. Il concetto è rafforzato dall'articolo 35, che concede a tutto il personale la cosiddetta «immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio ufficiale delle funzioni» e «l'inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti».
La contribuzione anche in questo caso è proporzionale alle quote Bce, e per il nostro Paese vale 14,33 miliardi di euro (su un totale di 80,55 miliardi). L'articolo 9, tuttavia, prevede che in caso di necessità il Mes possa richiedere in qualsiasi momento il capitale non versato, che per l'Italia è pari a ulteriori 111 miliardi di euro. Sommando il contributo all'Efsf con quello del Mes, il totale dell'obolo versato da Roma per la stabilità finanziaria dell'eurozona è pari dunque a 58,2 miliardi di euro, vale a dire il 3,4% circa del Pil. Senza questi importi, il nostro rapporto debito/Pil scenderebbe sotto il 130%.
Ma l'aspetto più inquietante dei prestiti Mes è la rigorosa condizionalità politica alla quale questi sono subordinati. Detto in altri termini, vige la regola «pagare moneta, vedere cammello». Ne sa qualcosa la Grecia, che dal Fondo ha ricevuto 61,9 miliardi di euro in 12 tranche dal 2015 al 2018 in cambio di riforme lacrime e sangue (gli altri beneficiari sono la Spagna con 41,3 miliardi e Cipro con 6,3 miliardi). Senza contare la strettissima sorveglianza post programma, che di fatto limita enormemente lo spazio per attuare qualsiasi politica fiscale espansiva, e che dura finché non è stato ripagato almeno il 75% degli importi erogati. Non perde occasione per ricordarlo ai malcapitati greci l'austero amministratore delegato del Mes, il tedesco Klaus Regling.
Quello che a prima vista può sembrare un innocuo e anonimo settantenne, in realtà è uno al quale piace usare frusta e pugno di ferro. Conscio della sua posizione dominante (il Mes è infatti il primo creditore della Grecia), Regling non perde occasione per minacciare Atene in caso di deviazione dalla retta via, proprio come ha fatto all'indomani delle elezioni politiche svoltesi a luglio: «La cosa più importante è garantire l'avanzo primario concordato (3,5% del Pil, ndr) perché è la condizione necessaria per la sostenibilità del debito». Come si suol dire: uomo avvisato, mezzo salvato.