«Un giro d’interessi anche politico che nessuno intende scardinare»
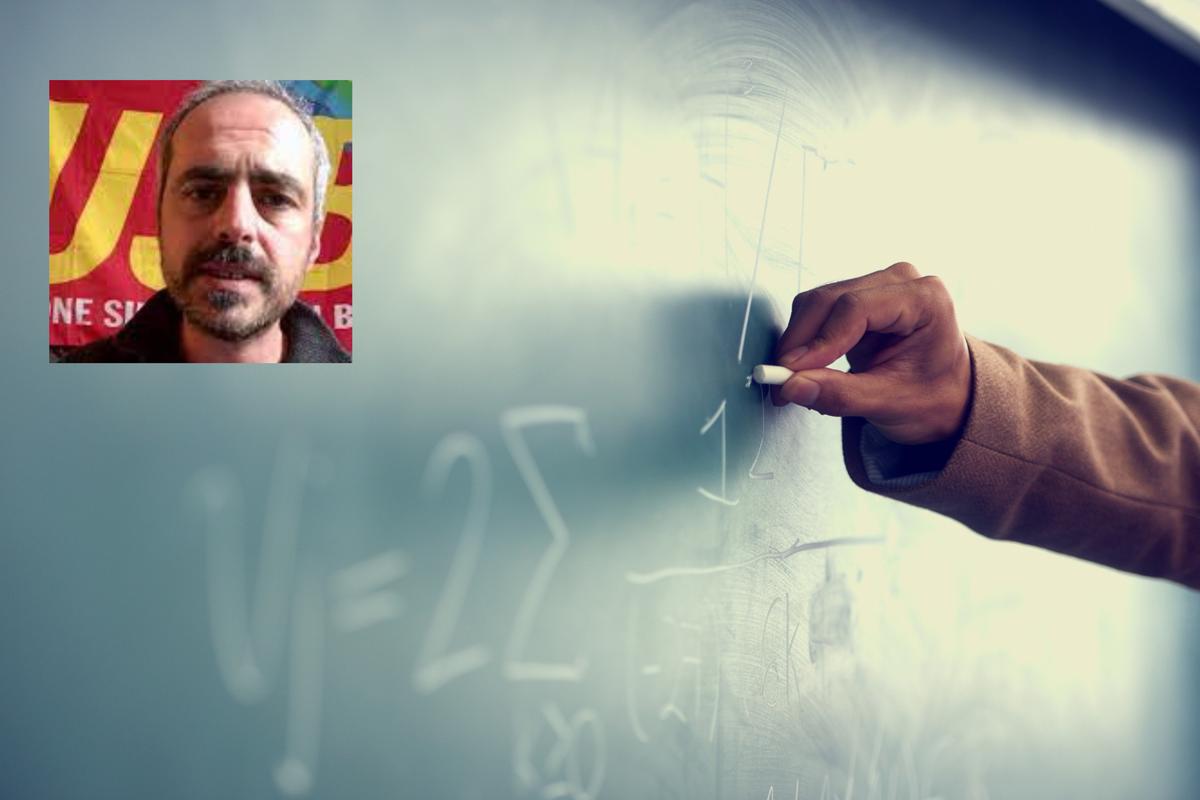
«Attorno agli assistenti all’autonomia e alla comunicazione forniti dalle cooperative c’è un giro di interessi politico-economici difficile da scardinare». La denuncia è di Fabio Perretta, coordinatore nazionale del sindacato Usb.
Interessi di che tipo?
«A Roma, durante l’amministrazione di Virginia Raggi, una petizione raccolse oltre 12.000 firme di educatori delle cooperative romane che chiedevano di essere assunti in Campidoglio. Tutti tremarono perché ciò avrebbe significato sottrarre alle coop questo servizio, che è anche una macchina di consensi e voti. Appena è cambiata la giunta, il percorso si è bloccato. Il Pd ha accantonato il tema. Perfino la stampa, che aveva usato quel problema per attaccare i 5 stelle, arrivato il sindaco Gualtieri ha messo la sordina».
Potrebbe risparmiare il Comune di Roma assumendo gli assistenti invece di pagare le cooperative?
«Abbiamo calcolato che il costo orario con la gestione diretta degli assistenti scenderebbe dagli attuali 21-22 euro a circa 18. Considerando una media di 38 ore settimanali per circa 2.500 operatori, in una situazione ideale in cui tutti lavorano a tempo pieno, il risparmio sarebbe di circa 7 milioni di euro. È un calcolo approssimativo perché l’utilizzo del personale, in realtà, è part time involontario».
Quale è il rapporto tra insegnanti di sostegno e assistenti?
«Sono due figure distinte. L’insegnante di sostegno è garantito dal ministero dell’Istruzione e si occupa della didattica degli alunni con handicap. L’assistente affianca l’insegnante e ha il compito, definito dalla legge 104, di aiutare il ragazzo a sviluppare forme di comunicazione e favorire l’integrazione nella classe. La stessa legge 104 prevede che Comuni e Province facciano i programmi di integrazione scolastica, quindi gli assistenti dovrebbero rientrare nei loro organici. Invece questo servizio negli anni Novanta, sull’onda delle privatizzazioni, è stato esternalizzato».
Quale è la retribuzione di un assistente?
«Le cooperative pagano gli assistenti a cottimo, cioè quando prendono in carico un alunno. La media retributiva è di 7,5-9 euro l’ora in base all’anzianità di servizio. Al Centro e al Sud può scendere fino a 5 euro l’ora perché le coop li inquadrano a livelli più bassi. I capitolati di appalto tendono a risparmiare non riconoscendo i corretti inquadramenti da contratto nazionale. Durante l’estate, con la chiusura delle scuole, l’attività si ferma».
E il guadagno della cooperativa?
«A Bologna e provincia l’ora venduta dalla coop all’ente pubblico costa 21-22 euro. All’assistente ne arrivano al massimo 9, il resto è margine lordo della coop. L’ultimo bando triennale del Comune di Bologna, da settembre 2020 a settembre 2023, con opzione di rinnovo per altri due anni scolastici, ha stanziato 64,75 milioni di euro. In ballo ci sono circa 800 lavoratori che, se inquadrati nel contratto del pubblico impiego, costerebbero meno. Con un tempo pieno, l’amministrazione risparmierebbe circa 3 milioni di euro».
All’assistente è richiesta una specializzazione, una laurea specifica?
«In teoria dovrebbe essere laureato in scienze dell’educazione. Ma siccome sono pochi, spesso la loro attività è svolta da persone con altri titoli di studio. Finché non c’erano concorsi nel pubblico impiego, i laureati che aspiravano a diventare insegnanti nonché quelli appena usciti dalle università in attesa di un impiego accettavano comunque questa occupazione per non restare disoccupati».
Quindi può accadere che il ragazzo con handicap sia seguito da personale senza specializzazione?
«Gli appalti ai quali partecipano le cooperative prevedono che il personale sia formato e specializzato, ma poi si sa come vanno le cose. Se manca un insegnante di sostegno, può capitare che le sue ore siano coperte da un assistente anche se questo non dovrebbe occuparsi della didattica. C’è una grande confusione di ruoli determinato dalla scarsa organizzazione e dalla mancanza di personale qualificato. La specializzazione ha un costo e si è sviluppato un mercato molto redditizio di enti e università che forniscono corsi».
Come si acquisisce la specializzazione?
«C’è il business degli enti di formazione. I corsi per insegnanti di sostegno sono svolti da università, istituti privati ed enti bilaterali gestiti da cooperative e Cgil, Cisl, Uil. La legge di bilancio 2017 ha previsto che chi in tre anni consegue 60 crediti formativi di corsi universitari in materie pedagogiche può essere equiparato all’assistente professionale che ha studiato scienza dell’educazione. Alcune università chiedono anche 3.000 euro, ma ci sono corsi online che rilasciano un attestato per poche centinaia di euro».






