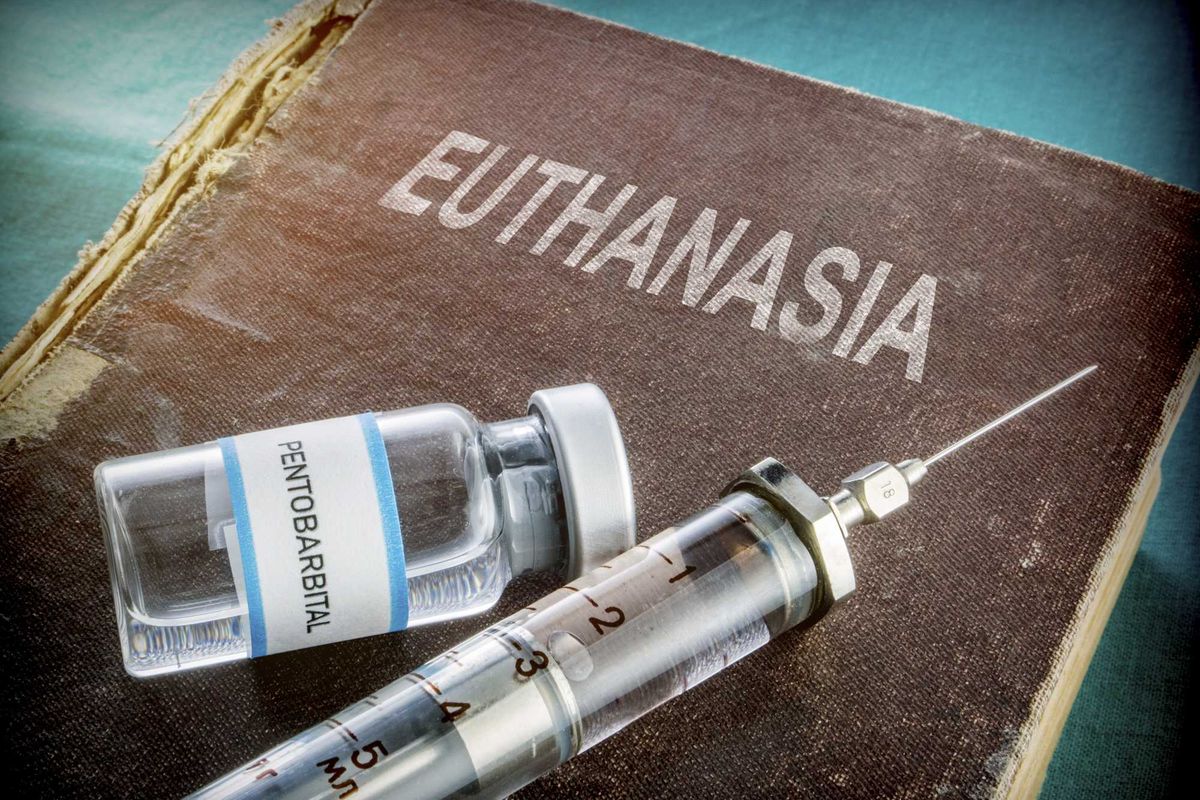In principio era il brodo primordiale. Mescolato lentamente a fuoco basso per miliardi di anni dal Divin Cuoco - che di tanto in tanto lo assaggiava e, trovandolo insipido, aggiungeva nel calderone un pizzico di idrogeno qui, una manciata di ossigeno là, azoto e carbonio q.b. - da quel minestrone prebiotico ebbe origine la vita sulla Terra. Il brodo che si cucina sui nostri fornelli non genera la vita come il primordiale, ma la rigenera. Il brodo è una forza della natura, una potenza vivificante. Generoso di sapore, ricco di virtù salutari, ristretto lo si porge ai malati per aiutarli a guarire più in fretta, grasso si dà agli inappetenti affinché ritrovino l’appetito e agli anemici per arricchirli di buoni globuli. Il brodo è il rimedio della nonna per i nipoti che si beccano un malanno stagionale: rinvigorisce il fisico, tonifica, corrobora.
Liscio, ma sempre bello caldo, si prende come antipasto prima dei grandi pranzi delle feste (e il brodo di Natale è il più rituale) per preparare lo stomaco alle successive pietanze. Lo sanno bene i mantovani che considerano il sorbir d’agnoli il miglior antipasto del mondo, accettando tutt’al più di allungarlo con il lambrusco trasformando il sorbir in bevr’in vin: la somma di vino più brodo, assicurano, è uguale a un doppio beneficio. A seconda delle necessità il brodo si adegua: ristretto o lungo; magro o grasso; leggero o pesante; consommé, che poi è un ristretto detto alla francese, o broda; di carne o di verdura; con aromi o spezie; da sorseggiare come bevanda nella tazza con doppia impugnatura o da usare per cuocere pasta, riso, pesce, carne.
Il brodo è un cibo senza tempo, sempre di moda come i tailleur di Coco Chanel da quando fu inventato da qualche homo sapiens migliaia di anni fa. Chi fu il benemerito a capire che, tuffando nell’acqua bollente pezzi di ciccia o verdure, si otteneva un liquido saporito? Mah… Gli antropologi parlano di cibo sciamanico, cucinato da stregoni e stregonesse nei loro pentoloni per curare gli ammalati della tribù. Gli studiosi di storia della gastronomia non si discostano molto, affermando che la cottura tramite l’acqua avvenne per estrarre dalle carni o dai vegetali le forze benefiche in essi contenute, l’essenza della carne, il segreto stesso della vita.
Giovanni Ballarini, docente emerito dell’Università di Parma, ricercatore scientifico dell’alimentazione umana, ne La cucina dei numeri primi sostiene che l’invenzione del brodo non abbia un padre, ma una madre: «Se lo spiedo e la griglia con l’azione diretta e spesso brutale del fuoco sono maschili, la pentola dove il fuoco agisce con una più dolce e delicata intermediazione dell’acqua, è femminile».
Chi afferma che la tradizione non esiste, annega in una scodella di minestra. Il brodo è tradizione e innovazione in cucina. Lo dimostrò Gualtiero Marchesi cuocendo il riso del suo piatto icona, il risotto con la foglia d’oro, in un «brodo leggero». E lo dimostrano i cuochi pluristellati inventando brodi con gli ingredienti più diversi: tutto fa brodo. Il brodo non è un cibo qualsiasi, è storia, memoria, mito. Questa preparazione culinaria tanto modesta quanto preziosa conobbe il momento d’oro nella Parigi della seconda metà del Settecento quando vennero aperti parecchi restaurants à bouillon, ristoranti da brodo, locali pubblici dove si servivano brodi ristoratori a ogni ora del giorno, capaci di ripristinare le forza indebolite di donne incinte e di cittadini malaticci, ma apprezzati anche da clienti sani.
Lo racconta Jean-Pierre Poulain nella sua Storia della cucina e dei cuochi. In buona sostanza il ristorante, se è divenuto tale, se da participio è diventato un nome, lo deve al brodo. Con un bisticcio, Ballarini mette i puntini sulle «i» sul rapporto tra il brodo e il ristorante: «Cosa ci ristora al ristorante? Il grande ristoratore del ristorante è il brodo di cui in Italia piangiamo la progressiva riduzione». È vero, anche se cuochi illustri preparano brodi stellari, sono sempre meno i ristoranti che lo mettono in menù come prim’attore, tutt’al più come spalla: tortellini in brodo, agnolini in brodo, trippa in brodo e così via.
È consolante, però, sapere che sta recuperando alla grande nei focolari domestici. Costanzo Compri, consigliere dell’Associazione macellai veronesi, dal suo importante osservatorio (a Verona, il brodo di carne è fondamentale per la salsa pearà, servita con i bolliti): «Un tempo il primo compito di un cuoco era preparare il brodo. Adesso soltanto i più bravi lo fanno. Molti, bastandone poco per le loro preparazioni culinarie, usano il dado. C’è anche chi, il brodo, proprio non lo fa. Mi è capitato di chiedere in un locale un piatto di tortellini in brodo. Mi è stato risposto che li avevano solo asciutti». Nelle famiglie il brodo buono si fa ancora? «È così, soprattutto quando c’è freddo. In macelleria vendo brodo già pronto, ma moltissime donne, anche giovani, chiedono cappone, muscolo, copertina, carni con tessuto connettivo perché fa la differenza. Non si alzano alle 6 del mattino come le loro mamme e nonne a preparare il brodo schiumandolo più volte, lo preparano nella pentola a pressione, ma è giusto così».
In Italia il brodo è molto apprezzato fin dall’antichità. Nel Medioevo veniva preparato con carni, spezie e zucchero nei castelli e nei palazzi aristocratici; con rape, cipolle e varie erbe di campo nei miseri tuguri dei servi della gleba. Nel Cinquecento Teofilo Folengo, mantovano e poeta, descrive nel poema epico maccheronico Baldus il paese di Cuccagna dove scorrono fiumi di brodo e dove le ninfe soffiano nella pentola appesa alla catena perché la fiamma troppo alta fa uscire il brodo: «Fogo multo saltat brodus extra pignattam». Il brodo va preparato a fuoco lento per un risultato eccellente.
Pellegrino Artusi a fine Ottocento mette in chiaro che, per ottenere un buon brodo, bisogna mettere la carne nell’acqua fredda e far bollire il tutto pian pianino, in modo che non trabocchi. «Se poi, invece di un buon brodo, preferiste un buon lesso, allora mettete la carne ad acqua bollente». Una regola sempre valida. I tagli bovini migliori per fare un buon brodo? Muscolo posteriore, sotto spalla, polpa di spalla, petto, collo e muscolo anteriore. Anche un osso spugnoso, con tanto di midollo, dà gusto al brodo rilasciando aromi, parti grasse, calcio e la lecitina che regola il colesterolo nel sangue e favorisce lo sviluppo cerebrale.
Artusi ne La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene detta la ricetta per un brodo per gli ammalati e si scaglia contro i medici che svilivano il brodo sostenendo che non nutre e che serve più che altro a promuovere nello stomaco i succhi gastrici: «Io, non essendo giudice competente in tal materia, lascerò a essi la responsabilità di questa nuova teoria che ha tutta l’apparenza di ripugnare al buon senso».
Aveva ragione. A cavallo tra Otto e Novecento il brodo sarà vilipeso come alimento e addirittura calunniato. Nel 1938, nella sua prima edizione, il Larousse Gastronomique, enciclopedia gastronomica francese, scriverà che il brodo, considerato uno degli alimenti tra i più ristoratori, ha perso la reputazione perché, in base alle analisi chimiche, sembra non possedere alcun valore nutritivo, anzi contiene sostanze che, a forti dosi e in talune condizioni, avrebbero potuto comportarsi come tossiche. Ma il «buon senso» reclamato da Artusi alla fine prevale e, nella stessa Francia, ci sarà una levata di scudi pro brodo. Il cuoco tristellato Michel Troisgros, uno dei massimi esponenti della Nouvelle cousine, dichiara che i benefici del brodo trascendono il gusto: «Il brodo fa bene all’intelletto». Cosa, oggi, dimostrata scientificamente. E il grande Paul Bocuse, insignito della Legion d’Onore dall’allora presidente Valéry Giscard d’Estaing, gli dedicherà un brodo di tartufo nero che, in onore del presidente francese, chiamerà Soupe VGE.