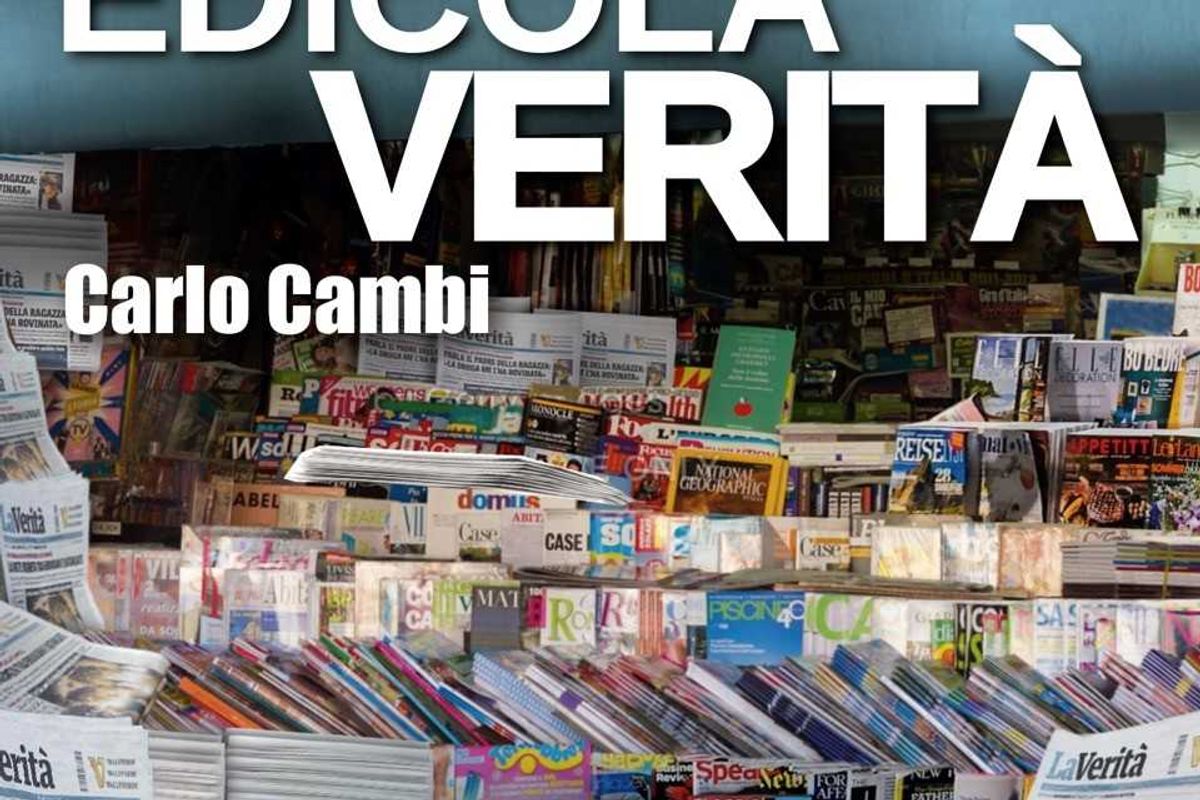Volevano diventare i Mogol e i Battisti di San Giorgio a Cremano e Portici. Finirono con il rivoluzionare la comicità in uno dei programmi più innovativi della televisione italiana. A 25 anni dalla morte di Massimo Troisi, Enzo Decaro ricorda gli anni felici della loro giovinezza quando, insieme a Lello Arena, diedero vita a La Smorfia, «gruppo d'assalto napoletano», come veniva definito ai tempi di Non stop. Una mostra fotografica e multimediale, in corso a Roma al Teatro dei Dioscuri, dal significativo titolo Troisi poeta Massimo, è l'occasione per Enzo per confrontarsi con il suo passato e aprire il cassetto dei ricordi.
Quando ha conosciuto Massimo Troisi, quanti anni aveva?
«Ero alla fine del liceo, avevo 17-18 anni. Lui e Lello avevano 5 anni più di me».
Come vi siete conosciuti?
«Amici comuni hanno voluto che ci incontrassimo per scrivere canzoni. Io venivo dal mondo della musica. Massimo aveva e ha una valenza poetica, non ancora pienamente conosciuta. Non è una coincidenza che abbia terminato la sua vita artistica e umana con la visione poetica de Il postino. È stato ed è un grande poeta, sempre coerente con il suo essere profondamente rivoluzionario nel pensiero».
Avete poi scritto delle canzoni?
«Sì. Una decina di anni fa, abbiamo donato le canzoni all'associazione che Massimo ha sostenuto in vita, Bambini cardiopatici nel mondo».
Lello Arena quando iniziò a collaborare con voi due?
«Il Centro teatro spazio, dove ci siamo conosciuti, era un punto di incontro di varie persone, li chiamerei giovani ricercatori. Si faceva teatro, ma non solo. Eravamo un gruppo di una decina di persone, molto attive su vari campi. La formazione a tre è stata casuale perché nel gruppo eravamo interscambiabili, gli attori si sostituivano l'uno all'altro nei vari spettacoli. Era un momento storico-politico molto particolare e avere la possibilità di incontrarsi era qualcosa di speciale perché c'era la necessità di non essere complici di quello che avveniva intorno. Da una parte, c'era la ricerca, l'arte, la musica, il teatro, dall'altra, la lotta armata. I carabinieri, che erano nostri vicini, non sono stati mai veramente convinti di cosa facessimo fino alle 3 di notte! La Napoli di fine anni Settanta, volendo fare dei paragoni, era una piccola Firenze rinascimentale».
C'erano La Smorfia, La Nuova Compagnia di Canto Popolare, Napoli Centrale, Teatri Uniti…
«Roberto De Simone, i fratelli Bennato, Pino Daniele e molti altri grandi artisti. Era fondamentale la possibilità di comunicare pensieri, allora non era scontato come oggi. Era difficile trovare dei luoghi dove poterlo fare. Infatti noi siamo andati a Roma, dove si faceva il cabaret. A Napoli non esisteva una tradizione di questo tipo. Abbiamo fatto uno sketch al riguardo. Il critico di Paese Sera, Enrico Fiore, è venuto a vederci e ha cominciato a parlare del nostro cabaret, allora Massimo gli ha chiesto se questo cabaret fosse “un fatto buono o no", Enrico Fiore gli ha risposto che era una cosa buona e che dovevamo andare a Roma. Così un lunedì sono andato a Roma a vedere cosa fosse il cabaret, alla Chanson di Marcello Casco, e non ho trovato nessuno… ho pensato che le code, il successo, fossero leggende che si raccontavano a Napoli, poi ho saputo che i lunedì i cabaret erano chiusi! Però ho parlato con Marcello, il quale si è accorto di questo ragazzo che si aggirava nei dintorni e mi ha chiesto chi fossi, che cosa facessi, e ci ha dato l'opportunità di esibirci qualche giorno dopo e di ritornare la settimana successiva. Da quelle parti passavano i funzionari Rai che stavano preparando Non stop e così siamo stati scoperti».
Quindi la prima volta vi siete esibiti a Roma, non a Napoli.
«Ci abbiamo provato, ma era molto difficile per questo tipo di spettacolo. I luoghi dove esibirsi a Napoli erano appannaggio di un teatro più tradizionale. Poi era vivente e regnante il grande Eduardo. Noi avevamo presente la nostra tradizione teatrale, ma tentavamo di destrutturarla».
Com'era Enzo Trapani, il regista di Non stop?
«È stato geniale. Ha avuto delle piccole, ma fondamentali, intuizioni tecniche, cinematografiche, perché quando abbiamo fatto lo sketch su San Gennaro - di solito i pezzi si facevano solo una volta -, ha intuito che gli sarebbe piaciuto un punto di vista che non fosse quello del pubblico. Allora ha fatto riposizionare le telecamere a 3 metri di altezza e ci ha chiesto di rivolgerci direttamente alle camere».
Come quando Don Camillo parlava al Crocifisso.
«Esattamente. Credo che nel varietà non ci fossero stati mai precedenti. Le telecamere avevano sempre il punto di vista del pubblico. Questa intuizione ha aiutato molto a comunicare quello che volevamo dire, perché una delle nostre tematiche era il disagio di fronte a un potere religioso che teneva soggiogate le persone».
Giocavate anche con le credenze popolari, la superstizione...
«La nostra generazione non si identificava con un certo trend, l'oleografia, gli stereotipi non li sopportavamo più».
In Ricomincio da tre Troisi aveva ironizzato sul napoletano che, quando viaggia, deve per forza essere un emigrante.
«Quello che ci premeva era proprio questo: fuggire da credenze scambiate per verità. Così come lo stereotipo della sceneggiata napoletana. Dove era possibile, cercavamo di colpire un sistema che non permetteva di crescere».
Quali erano i rapporti con i comici lanciati da Non stop, da Verdone ai Giancattivi?
«Non c'era il senso della rivalità e della concorrenza, c'era uno spirito di gruppo, ci si sentiva parte di un movimento che stava rinnovando la comicità tradizionale. Non conoscendoci, era anche l'occasione di scoprire cosa facessero gli altri cani sciolti che pensavano di essere soli. Sapere che c'erano altri come noi è stato un bell'incoraggiamento. Per arrotondare noi comici di Non stop ci esibivamo in un localino di Torino, Il Centralino. È stata un'occasione per conoscerci e frequentarci e sono nate amicizie».
Facevate delle prove prima della trasmissione?
«C'erano delle prove comuni, ma noi in realtà le vere prove le facevamo in teatro. Sperimentavamo e provavamo per cercare di capire se uno sketch funzionasse o no, sera per sera, nei teatrini nei quali ci esibivamo. Già era difficile mettere d'accordo tre personalità così diverse come le nostre, per cui una battuta o un pensiero che andava in scena doveva avere l'avallo di tutti e tre, e non era la cosa più semplice. Quando lo sketch era perfetto, veniva consegnato alla televisione».
Quindi non c'erano forme di controllo o di censura preventiva? Non c'era il funzionario di turno che vi diceva: “Questo potete dirlo, questo no˃?
«Più che il funzionario di turno, c'era la magistratura che ci ha sottoposto a due processi per vilipendio alla religione di stato. In via preventiva no perché, quando ci chiedevano i copioni dei nostri testi, non c'erano! Io e Lello Arena abbiamo letto i nostri testi per la prima volta quando sono stati pubblicati vent'anni fa da Einaudi».
Caratterialmente com'eravate?
«Noi abbiamo sempre discusso molto. La cosa che ci univa era fondamentalmente l'identità di gruppo. Pur con le nostre diverse personalità, avevamo delle condivisioni di base».
Quando è venuta meno l'idea del gruppo che vi aveva tenuto uniti?
«Quando Massimo ha avuto la possibilità di fare cinema e ha conseguito un successo imprevedibile».
Vi avevano offerto di fare un film tutti insieme?
«Sì, ma non abbiamo mai trovato, nelle proposte ricevute, l'occasione di portare il nostro pensiero e di tener fede ai nostri ideali. Ci hanno chiesto di partecipare a progetti in cui erano coinvolti altri attori».
Il successo delle vostre partecipazioni televisive è stato immediato?
«Eravamo tutti e tre insieme e facevamo lo stesso tragitto dalla pensione alla Rai di Torino, che avevamo percorso fino al giorno prima, e improvvisamente è diventato difficile passare inosservati. C'è stata subito un'affezione molto forte, ma più che la gratificazione del successo, questo ci ha permesso di approfondire quello che stavamo portando avanti, come abbiamo fatto negli anni successivi».
Prima di raggiungere il successo, avevate dei lavoretti?
«Io ogni tanto facevo il pianista a teatro, Lello credo frequentasse l'università, Massimo andava a scuola. Ha fatto l'istituto per geometri fino a 23 anni! È stata una tragedia! Anche dopo il successo suo padre, don Alfredo, mi è venuto a parlare per dirmi: “Qua il ragazzo non si prende la licenza, non va da nessuna parte"»!
Poi l'ha presa?
«Dopo 10 anni».
Non ha mai praticato?
«Per fortuna no! Massimo diceva di avere con la scuola un rapporto di odio e... odio! Molto del suo portato non era legato tanto allo studio e all'applicazione, che non erano proprio il suo percorso, quanto da una formidabile capacità intuitiva nel trasformare in straordinario l'ordinario».
Aveva una grande capacità affabulatoria, di cogliere la battuta del suo interlocutore e di rilanciarla, con un uso sapiente della lingua.
«Fra le doti ricevute in natura c'era sicuramente l'uso del pensiero laterale. Non so quale parte del cervello usasse: la destra o la sinistra! Era sorprendente. Massimo non è mai stato diverso da quello che era. Non si è mai sforzato di cambiare e apparire diversamente. Una coerenza perfetta».
Cosa ti manca di lui a distanza di 25 anni?
«A noi che l'abbiamo conosciuto come amico, fratello, maestro, ci è sempre stato accanto, non voglio dire come un giudice, ma sicuramente tante volte mi sono confrontato su come avrebbe fatto lui quella determinata cosa. Nel miglior modo possibile perché questa era la nostra prerogativa. Di fronte a un'idea non bisognava mai accontentarsi della prima o della seconda soluzione, ma portarla alla sua espressione più alta. Rimanere fedeli a sé stessi: questo è stato il suo più grande lascito».