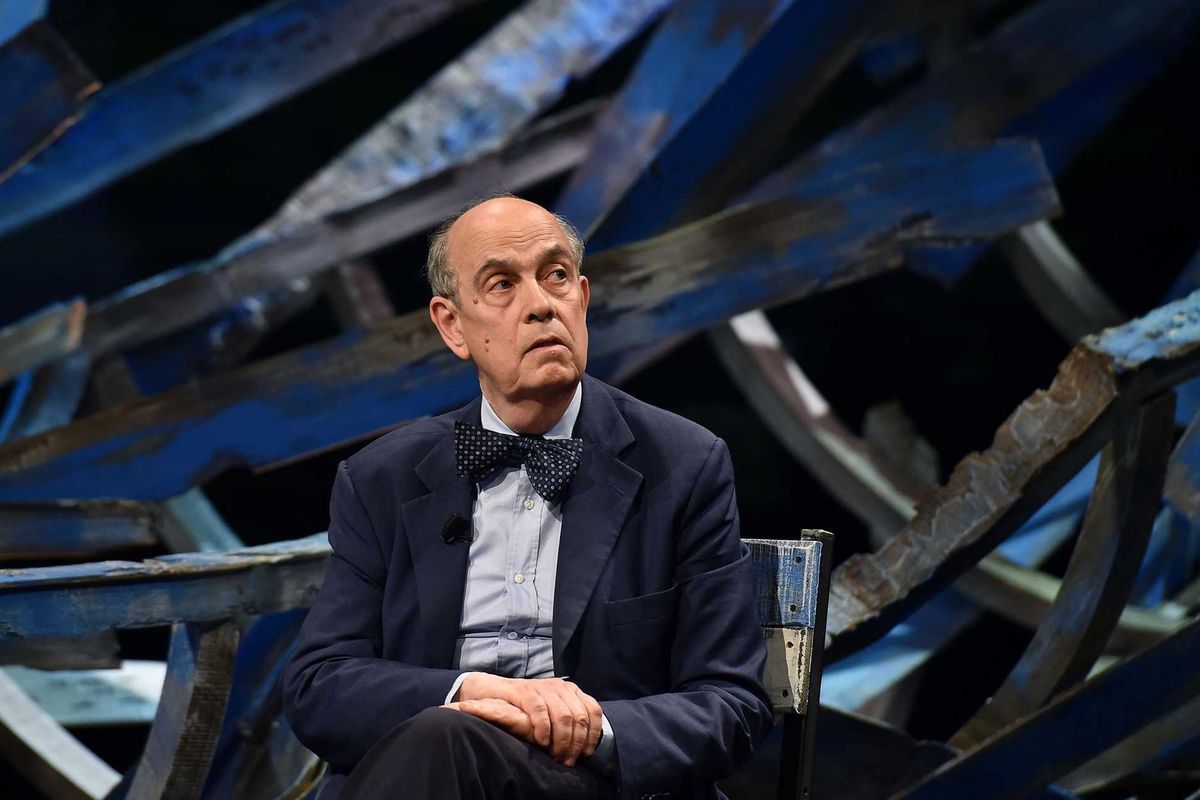Sant'Antoni chisolér, al vegn al darsét da snér. Sensa chisöl a da so al solér. Croato? No, dialetto mantovano. Traduciamo: «Sant'Antonio focacciaro arriva il diciassette di gennaio. Senza focaccia crolla il solaio». Manca la rima e tradurre è sempre un po' tradire, ma il significato è chiaro: chi nel giorno di Sant'Antonio Abate, il santo del porcellino, patrono degli animali, molto venerato nelle pingui campagne e nelle stalle intorno al Mincio, non rispetterà la tradizione di mangiare il chisöl, focaccia dolce che in origine veniva preparata senza lievito, con farina, onto (grasso rilasciato dal cotechino durante la cottura), uova e un po' di zucchero, rischia di passare grossi guai.
L'antichissimo proverbio contadino, rimbalzando di generazione in generazione, è arrivato fino a noi. Nelle terre che furono dei Gonzaga la tradizione è tuttora vivissima: ogni 17 gennaio s'intinge una fetta di chisöl nel latte o nel lambrusco - dipende dall'età - recitando la filastrocca dialettale. La focaccia di Sant'Antonio non è più povera. Oggi si prepara con il lievito e il burro al posto dell'onto. Oltre allo zucchero dell'impasto si cosparge la superficie con quello in granella. La tradizione è molto sentita anche a Lonato, paesone del basso Garda in provincia di Brescia devoto al santo abatel. Nell'impasto del chisöl bresciano viene aggiunta uvetta.
Calendario alla mano troviamo molti santi con l'aureola imbrattata di farina, marmellata e zucchero: chi ha il nome legato a una torta, chi a biscotti e chi a focacce, ciambelle, frittelle, bignè e ad altri cento tipi di dolci. Il prossimo santo «pasticciere» in agenda è San Biagio che si festeggia il 3 febbraio, giorno in cui fu martirizzato nel 316. San Biagio, miracolando un bambino che stava soffocando per una lisca piantata nella trachea, è il santo protettore della gola. Alla quale perdona molti peccatucci. In Molise, ad Acquaviva Collecroce, lo si venera gustando i colaci, ciambelline dolci. In Abruzzo si chiede la protezione della gola gustando i «tarallucci di San Biagio». A Caronia in provincia di Messina prima si benedicono e poi si distribuiscono al popolo i «cudduri di San Brasi», ciambelline fatte di mandorle, nocciole e miele. Restando in Sicilia, a Comiso, si mangiano le «cannarozze», dolci simbolici a forma di trachea. A Cavriana, sui colli morenici mantovani, non c'è caffè e pasticceria che non metta in vetrina per la fiera del santo martire la «torta di San Biagio», crostata di pasta frolla con un ripieno di cioccolato e mandorle tritate. La tradizione è talmente sentita che lo stesso vescovo di Mantova arriva a Cavriana per benedire una torta da guinness dei primati. Tagliata in centinaia e centinaia di pezzi, viene distribuita alla folla. Milano è più sobria: per San Biagio c'è la tradizione di consumare una fetta di panettone appositamente avanzata a Natale.
Soltanto due giorni dopo San Biagio, il 5 febbraio, ecco Sant'Agata, la vergine martirizzata a Catania nel 251 dopo aver patito orrende sevizie, tra cui l'asportazione dei seni con le tenaglie. Raffigurata con due mammelle su un vassoio è patrona di Catania, protettrice delle balie e delle allattanti. La venerazione per Sant'Agata è enorme, e non solo in Sicilia dove la devozione si fonde con la tradizione e la pasticceria. Risultato di questa fusione sono gli squisiti dolcetti tondi, a forma di seno, ricoperti di candida glassa con sopra, a mo' di capezzolo, una ciliegia candita rossa: le «minne di Sant'Agata» o, per la piccola taglia, «minnuzze di Sant'Agata». Le pastarelle nascondono sotto la glassa un amalgama di pan di spagna imbevuto di rosolio, ricotta di pecora, gocce di cioccolato e pezzetti di arancia candita. Palermo, dove le chiamano «minni ri virgini», ne rivendica la primogenitura: le avrebbero create qualche secolo fa le monache del convento di Santa Maria delle Vergini nella loro pasticceria segreta. Agrigento risponde che fu, sì, una religiosa un po' sfacciatella, suor Virginia Casale di Rocca Menna, a creare il dolce nel 1725, ma che l'invenzione avvenne nel convento di Sambuca. Giuseppe Tomasi di Lampedusa cita le «impudiche paste delle vergini» nel Gattopardo dove sono servite durante il gan ballo dei Pantaleone.
Spalancano le porte del paradiso dei golosi (e della glicemia) le «chiavi ri San Pietru», antico biscottone a forma di chiave con miele, burro, zucchero variamente colorato, confettini all'anice che vengono vendute il 29 giugno, festa del principe degli Apostoli, in molte pasticcerie di Palermo. Nel capoluogo siciliano il santo protettore dei pescatori veniva un tempo celebrato nel quartiere di Castellamare. Una tenera, antica, usanza, ormai dimenticata, spingeva i giovanotti palermitani a donare alle morose una dolce chiave di San Pietro impreziosita con ogni bendidìo: serviva ad aprire il loro cuore all'amore del picciotto in questione. Anche l'altro santo celebrato il 29 giugno, San Paolo, vanta dolci devozioni. In provincia di Siracusa, a Palazzolo Acreide di cui l'Apostolo delle genti è patrono, onorano il santo con la «cuddura di San Paulu», un ciambellone con la superficie decorata da solchi simbolici a forma di serpente. Negli Atti degli Apostoli si racconta, infatti, che San Paolo, naufragato a Malta, fu morso da una vipera, ma non ne patì alcun danno. Per questo è considerato protettore contro il morso dei serpenti. La «cuddura di San Paulu», inserita dal ministero delle Politiche agricole e agroalimentari nella lista dei Prodotti agroalimentari tradizionali (Pat) della Sicilia, è una ciambella taumaturgica: mangiandola si supplica una grazia. E se non si è esauditi? Pazienza. Si sa che non tutte le ciambelle riescono col buco.
Le «dita degli apostoli» sono cannoli di pasta ripieni di ricotta, albume d'uovo, zucchero, cioccolata fondente, spolverati di zucchero a velo e cannella. Il dolce, di origine conventuale, quindi molto antico, tipico soprattutto del Salento, non fa torto ad alcun discepolo di Gesù: li comprende tutti. Una delle prime ricette di queste fritelline si trova ne Il cuoco galante (1773) di Vincenzo Corrado, gastronomo e scrittore di origine brindisina.
Santa molto amata dai bambini del Veneto, di Bergamo, Brescia, Mantova e dell'Emilia Romagna, è Santa Lucia. È lei che arriva con i doni il 13 dicembre, giorno del suo martirio nel 304. Molti dolci portano il suo nome. Le «frolle di Santa Lucia» sono biscotti tipici di Verona di varie forme- stella, abete, bambino, luna...- fatti di pasta frolla e cosparsi di zucchero a velo. In Lessinia e a Quaderni di Villafranca, sopravvive la tradizione dei «puoti (bambolotti) di Santa Lucia». Un tempo le mamme della frazione villafranchese, preparavano in casa, alla vigilia del 13 dicembre, i puoti di pasta frolla che poi andavano a cuocere di notte nel forno di Armando Vanoni, l'ospitale panettiere.
Essendo patrona della vista (Lucia deriva da luce), raffigurata con due occhi su un vassoio, molti dolci fanno riferimento a questo suo patrocinio. Tipici pugliesi sono gli «occhi di Santa Lucia», tarallucci dolci ricoperti da una glassa di zucchero. Stesso nome in Abruzzo per dei biscotti all'anice. In Sardegna è tradizione benedire i «biscocros de Santa Luchìa», biscotti rotondi con una mandorla (o con un po' di marmellata di mirtilli) posta nell'incavo centrale per simulare la pupilla. A Palermo e a Siracusa, per ricordare la grazia fatta dalla santa in occasione di una grande carestia (arrivarono navi cariche di grano che gli affamati siculi mangiarono bollito) ogni 13 dicembre si prepara la «cuccìa di Santa Lucia»: chicchi di grano bollito, ricotta, zucchero, cioccolato fondente e arancia candita.