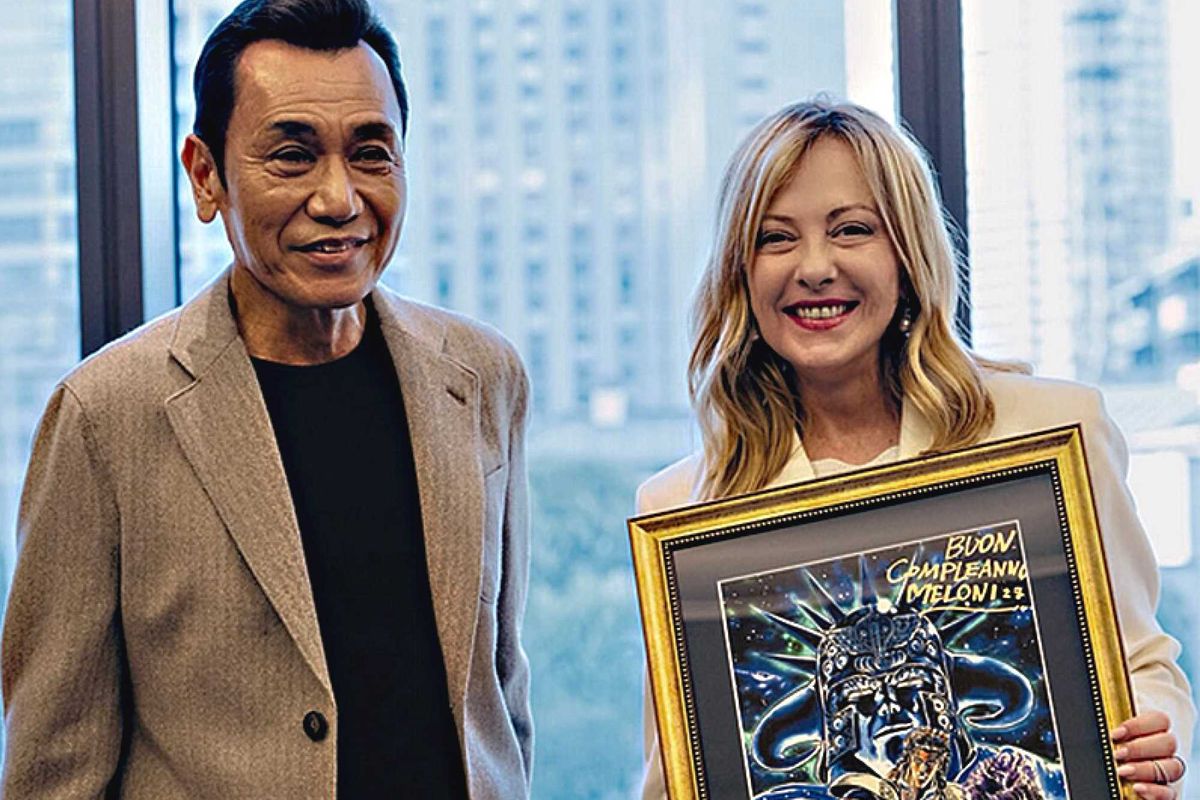«La civiltà della critica farà soffrire, perché l’uomo ha bisogno di certezze, di deduzioni, di cause finali e di un centro su cui ruotare come un pianeta intorno al Sole. Egli è assai simile alle carpe che godono e si irrobustiscono ad avere una pietra posata al centro del loro specchio d’acqua, intorno a cui volgere giri su giri armoniosi». Elemire Zolla (1926-2002) scriveva queste parole nel 1971, e davvero non ci sarebbe bisogno di altro per chiarire quale sia la sciagurata origine di tanti mali del nostro tempo. La civiltà sull’orlo del baratro a cui il grande studioso guardava con compatimento è appunto quella che venera la critica, cioè «l’acido capace di sbriciolare la ferma pietra della Tradizione». Ecco il punto: cancellando la tradizione, l’uomo non può vivere o può farlo solo degradandosi, e rinunciando di fatto a sé stesso.
Zolla aveva formulato la diagnosi perfetta per i nostri tempi in un denso saggio intitolato Che cos’è la tradizione, che fu ripubblicato una prima volta da Adelphi nel 1998 e ora finalmente ritorna grazie a Marsilio in un bel volume a cura di Grazia Marchianò. Non potrebbe esserci momento migliore per la riedizione: oggi la guerra alla tradizione si combatte su tutti i fronti. Ciò che conta, ai nostri giorni, è decostruire, eliminare ogni legame con il passato, cancellare ogni metafisica. Bisogna ribadire che tutto è creazione umana (compresi il corpo e il sesso) e dunque modificabile, storicizzabile. Al contrario, «Tradizione è ciò che si trasmette, specie di progenie in progenie, quanto a dire la radice di quasi ogni stato o atto umano, vivi essendo piuttosto i morti che non coloro nei quali scorre il loro sangue, facilmente illusi di inventare ciò che è pura riviviscenza, di creare discorsi che commuovono con l’apparenza della novità nella misura in cui è obliata l’arcaica voce che già ebbe a pronunciarli in antico». Tradizione è ciò che si trasmette, e da sempre si passa da una generazione all’altra soprattutto ciò che vi è di più importante, cioè la conoscenza «dell’oggetto ottimo e massimo», ovvero «dell’essere perfettissimo». Ovvio che queste parole al pubblico odierno possano sembrare inaccettabili. Già nel 1998, quando Adelphi rieditò il capolavoro di Zolla, ci fu chi lo accolse con rabbia. Umberto Galimberti su Repubblica scrisse che il testo in questione era «non solo inutile per le ragioni che abbiamo cercato di esporre, ma un libro che non coglie neppure lontanamente nel segno il senso del nostro tempo». Quanto si sbagliava. Basta guardarsi intorno per rendersi conto di quanto Zolla avesse ragione.
«Il dogma della storicità ha corroso l’arte, ambito che fra tutti pareva doverne restare immune», scriveva. «Ma sono caduti altresì dalla memoria dell’uomo, in ossequio al dogma, il diritto di natura, il tribunale d’appello dei deboli e degli oppressi, la logica quale era stata codificata dagli antichi, cioè la garanzia della salute mentale e la stessa economia quale scienza dei bisogni naturali. E con il rifiuto dell’idea di natura in tutte le sfere della vita non resta alcun criterio per discernere la diversa qualità degli avvenimenti o degli oggetti, che misuri il grado d’approssimazione dei fatti contingenti ai valori e pertanto la qualità viene ridotta a quantità, e invece d’un giudizio perenne domina l’utopia, che distrugge il senso dell’eterno con il rinvio al futuro».
Se viene meno il rapporto con i valori immutabili, con ciò che è importante fin dalla fondazione del mondo, semplicemente si perde il metro di giudizio, non si può più distinguere il bene dal male. Ci si consegna alle speranze vane, si cede alle lusinghe dell’utopia che promette il paradiso in terra a chi ignora che cosa sia davvero il paradiso. Si cede alle lusinghe del primo imbonitore politico. E più il tempo passa più l’umanità è permeabile a questo genere di manipolazione: «Oggigiorno non le ci vuole nemmeno una speranza particolareggiata, non ha bisogno di una pittura precisa del paese di Cuccagna, e nemmeno chiede apocalissi anabattistiche; basta un sussurro, un fischio, uno schiocco come quello rivolto alle galline, e se ne sta soddisfatta: “Il progresso, la scienza, l’umanità, l’evoluzione, il punto Omega”».
Zolla scriveva immediatamente dopo il 1968, osservando la contestazione universitaria, turbato dalle masse inneggianti ai regimi. Individuava i dogmi della nuova falsa religione, tra cui l’uguaglianza:
«La dea Uguaglianza brama ciò che è ancor più prezioso del sangue di cui era assetato Baal: la differenza specifica fra le anime, spesso simili, mai uguali. Che essa sia una divinità falsa appare evidente soltanto che si posi l’occhio pietoso sui miseri giovinetti indrappellati e conguagliati da qualche regime totalitario: ogni volto, sia esso suggestionato fino al consenso e al godimento della propria servitù, sia viceversa immalinconito dalla farsa cui viene piegato, testimonia della falsità dell’Uguaglianza, la quale è inoltre bugiarda in modi insidiosi, spacciandosi per una manifestazione della carità». Allora era il comunismo a irreggimentare. Oggi abbiamo l’appiattimento portato dalla globalizzazione e l’ideologia del neutro. «Invero uguagliabili», dice Zolla, «appaiono gli uomini soltanto nella misura in cui sono congegni fisiologici, la distruzione della dignità ancor prima che dell’individualità è il fine del culto ugualitario». Non è questo che siamo oggi? Macchine, congegni?
Così sono ridotti gli uomini che hanno voluto sovvertire e sradicare la tradizione accusandola di essere oppressiva, fautrice di una ingiusta gerarchia: sono ingranaggi di un sistema, meno liberi di prima. Motivo? Chiunque «non agisca per scopi che si possano ricondurre all’idea della sua perfezione, quindi di una sua beatitudine, ubbidisce di necessità alle parole d’ordine». Finisce cioè preda delle mistificazioni, degli slogan, del lavaggio del cervello. Tutto va bene, «basta che la parola esprima la negazione; il ripudio del criterio di discriminazione tra bene e male e la rinuncia a precisare la causa finale».
In questo quadro, inevitabilmente domina l’intellettuale, il professionista della critica e della decostruzione, «una creatura ibrida, impaurita, superba, forse prossima all’estinzione, incarnazione del pedante che non ha la serietà di un onesto operaio, mancando la perizia nelle arti che sarebbero sue proprie, la retorica e la grammatica».
Non sono oggi i cosiddetti intellettuali a imporre la tirannia del politicamente corretto, a cancellare la verità per sostituirla con la mistificazione totale? Per Zolla, la modernità è il dominio della truffa, a utopie di laboratorio che vendono felicità e producono schiavitù. «I tecnici imbevuti di ideologia sansimoniana manterranno una produzione di beni sempre più automatizzata e il tempo libero trascorrerà nell’allucinazione. La formula del tempo libero sarà visibile in due pillole sacramentali della nuova fede: l’una staccherà l’erotismo dalla procreazione, l’altra la psiche dalla realtà oggettiva. Il gregge così allucinato fornirà ai tecnocrati il materiale umano per gli esperimenti di trapianti d’organi e di ingestioni d’allucinogeni e la manipolabilità di tali cavie dovrà tendere all’infinito: uomini a più teste o a più braccia, con memorie altrui, con sentimenti combinati a capriccio, con arti artificiali di forza inaudita, di vitalità illimitata. Come il progresso della meccanica serviva a intrattenere gli ozi dei re cinesi o dei satrapi dell’età alessandrina con ordigni dove la fantasia imprimeva il proprio delirio al ferro e al legno, così l’oligarchia futura potrà visitare nei giardini antropologici fourieristi uomini a più teste, con strane amputazioni e bizzarre aggiunte».
Sembra la descrizione di un dipinto di Bosch, ma a ben vedere è un quadro abbastanza fedele del nostro mondo. Che ha creduto di emanciparsi abbandonando la tradizione, e si è reso volonteroso schiavo dei propri vizi.