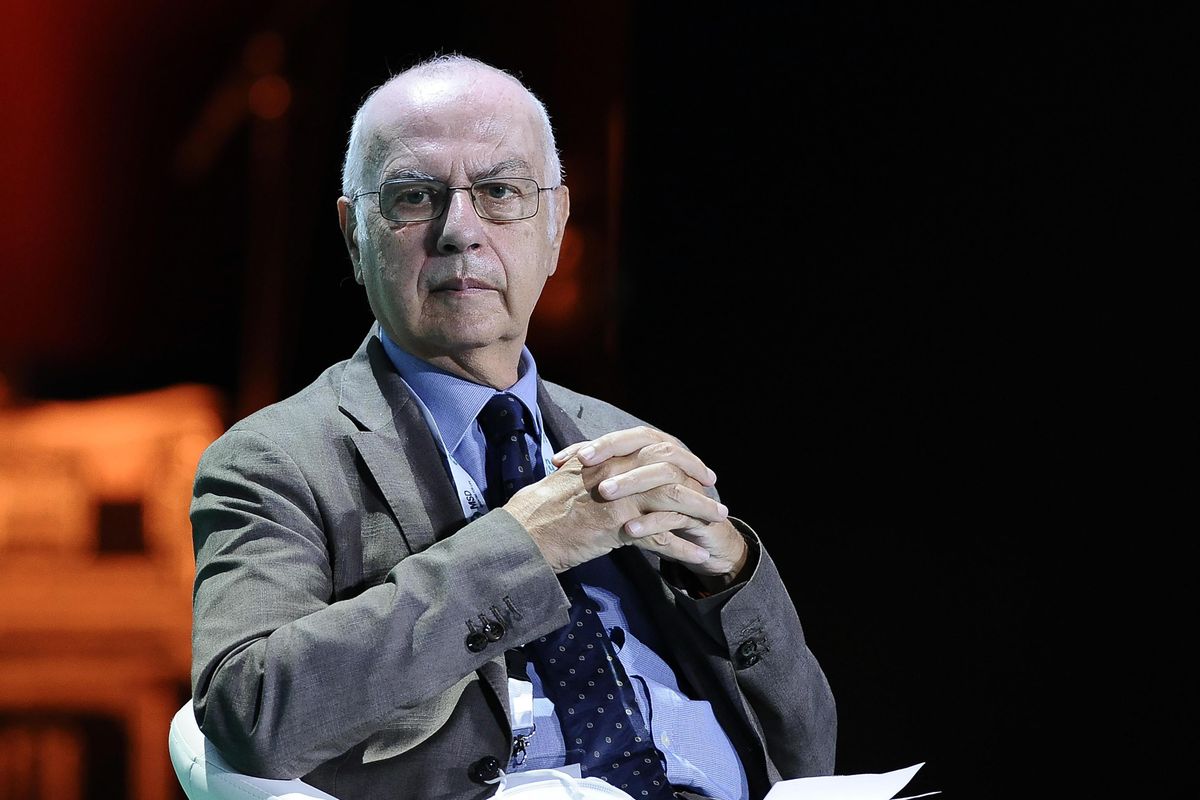
«C'è una perdita di autorevolezza diffusa e c'è una sfiducia nei confronti di chi ha responsabilità e in qualsiasi professione. È palese l'importanza dei social media, una volta ci lamentavamo dei giornalisti, e abbiamo scavalcato qualunque forma di intermediazione delle informazioni». Così ha detto ieri il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, intervenendo a un forum sulla sanità nella Capitale.
Chissà da dove arriva tutta questa sfiducia, questa perdita di autorevolezza. Chissà se Rezza segue i talk show, legge le interviste dei virologi sui giornali. Chissà se anche Rezza fa il cosiddetto debunking di quello che dicono gli alfieri mediatici della guerra al Covid. Intanto basterebbe leggere La Verità, dove ieri in un editoriale il direttore Maurizio Belpietro ha smontato con i numeri le parole del virologo Fabrizio Pregliasco che su La 7 ha spiegato che l'80% dei ricoverati per Covid è costituito da persone non vaccinate. Peccato che i dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità dicano tutt'altro: nel mese di ottobre, in corsia sono finiti 2.890 pazienti non vaccinati, 144 vaccinati con una sola dose, 1.774 vaccinati con ciclo completo entro sei mesi, 618 vaccinati con ciclo completo dopo più di sei mesi e 17 persone che avevano ricevuto anche la terza dose. Lo stesso Pregliasco qualche giorno fa, nel programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, rispondendo a un ospite che parlava di anticorpi per spiegare come mai non fosse stato vaccinato, aveva detto che «il test sierologico è un'indicazione quantitativa, ma non standardizzata e vediamo il calo di efficacia su studi rispetto al numero di persone che si reinfettano passando il tempo». Tradotto: il sierologico per appurare gli anticorpi anti Covid serve a poco. Poi però cambiando canale si trovava Massimo Galli intento a spiegare che «stiamo basando tutte le decisioni su studi che riguardano la risposta anticorpale. Bisogna avere il coraggio di dire che il sierologico è indispensabile». Il 6 novembre anche il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, è inciampato su una fake news quando ha detto che «fino a 59 anni nessun vaccinato è finito in terapia intensiva». Ma nel mese che precede il 27 ottobre, nella fascia di età indicata da Locatelli (12-59) gli intubati non vaccinati sono stati 142, quelli vaccinati con ciclo incompleto 7 e quelli che avevano ricevuto sia la prima che la seconda dose 16. Ossia, circa il 10% dei contagiati che rischiano la vita. Confusione. Caos. Esperti che danno i numeri. Risultato, se ne è accorto pure Rezza: la sfiducia aumenta. E aumentano anche i balletti di percentuali, gli errori e le amnesie di chi si è sempre mostrato col mantello da esperto in prima linea a denunciare le fake news sul Covid.
Prendiamo gli ultimi giorni. A Omnibus su La 7 interviene Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. Durante il suo intervento, Andreoni spiega: «È vero, abbiamo anche pazienti che si ricoverano che sono vaccinati, ma che sono persone che non muoiono». E invece è falso perché secondo il rapporto dell'Iss del 10 novembre negli ultimi 30 giorni risultavano decedute 384 persone vaccinate con ciclo completo. Sempre in tv è gettonatissima l'immunologa Antonella Viola. L'altra sera a Otto e mezzo ha dichiarato che «Non ci sono persone giovani sane vaccinate che finiscono in ospedale». Non è così. Nella fascia 12-39, negli ultimi 30 giorni sono finite in ospedale 97 persone. Erano già malate da prima? Ad alimentare confusione sono anche scambi un po' surreali come quello avvenuto nel salotto di Agorà su Rai 3 tra l'infettivologo Matteo Bassetti, convinto che l'obbligo vaccinale «evidentemente non è possibile farlo», dimenticandosi che l'obbligo esiste già per i medici e per gli operatori sanitari, e il governatore della Liguria, Giovanni Toti, per il quale l'obbligo vaccinale significherebbe «vedere l'esercito tradurre verso gli hub vaccinali con i camion e le manette le persone che non si vogliono vaccinare».
Nel frattempo, dopo la lezione sui tamponi svolta dalla cattedra televisiva di Fabio Fazio, Roberto Burioni si è meravigliato del clamore suscitato dal suo intervento. Che, ricordiamolo, era il seguente: «I tamponi per altro sono anche costosi e fastidiosi, e come tutte le pratiche mediche non sono privi di rischio: ci sono studi secondo cui ogni milione di tamponi ci sono 12 eventi avversi non lievi, come emorragie o se si rompe c'è bisogno di un intervento chirurgico, in un caso una persona ha perso del liquido cerebrale». Su Twitter Burioni ha quindi cinguettato: «Qualcuno è rimasto sorpreso del fatto che a seguito di un tampone si sia verificata una lesione grave che ha portato alla perdita di liquido cefalorachidiano», con tanto di link all'articolo sul caso pubblicato dal Journal of the american medical association il primo ottobre 2020. Una settimana dopo, l'8 ottobre del 2020, lo stesso Burioni rispondeva così sempre su Twitter a Claudio Borghi (Lega) che definiva il tampone un esame invasivo per essere di routine: «Onorevole, il tampone rinofaringeo può essere fastidioso (specie in pazienti con ipertrofia dei turbinati o deviazione detto nasale) ma non è considerato invasivo. Invasiva è una biopsia epatica, per esempio».
Una menzione speciale va però all'epic fail di Belardino Rossi, direttore dell'Asl di Aprilia, che ieri è stato intervistato da una giornalista di Agorà (Rai 3), davanti alla sede dell'azienda. Tema: l'efficacia della mascherina all'aperto. «È una misura importante per dare il segnale che l'epidemia non è passata», risponde Rossi. Ma per dirlo si toglie la mascherina e viene rimproverato dalla giornalista.






