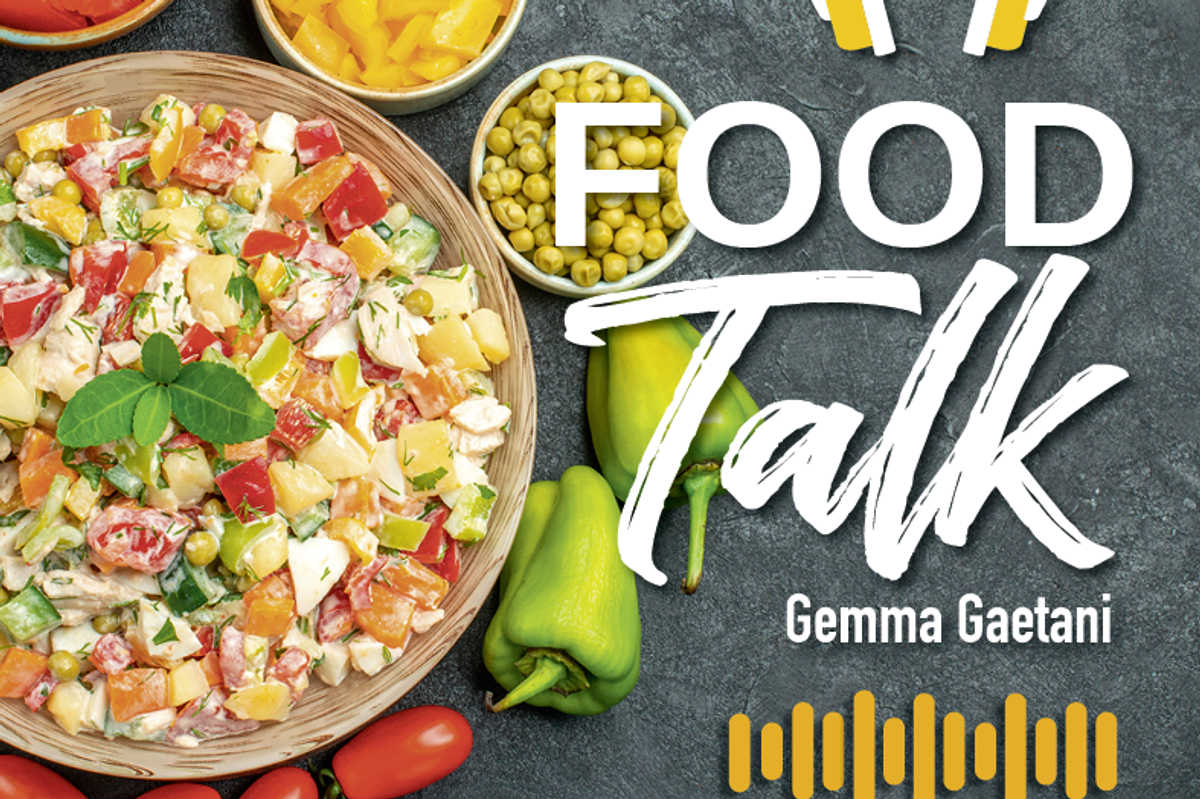2024-12-16
«Una Chiesa “femminista” non riavvicina le donne»
Nel riquadro, la sociologa Stefania Palmisano (IStock)
La sociologa Stefania Palmisano spiega in un libro le cause dell’addio alla pratica religiosa: «Ritenere ingiusto il sacerdozio solo maschile riflette una visione errata della relazione tra sessi».Col libro Donne e religioni in Italia (Il Mulino, 2024), scritto insieme alla sociologa Alberta Giorgi, Stefania Palmisano, 48 anni, docente di Sociologia della religione all’Università di Torino, si conferma una delle studiose più interessanti del fenomeno religioso. La Verità l’ha contattata a partire da questa sua ultima pubblicazione, per approfondire il delicato rapporto che intercorre oggi tra donne, Chiesa e secolarizzazione. Professoressa, nel suo libro segnala come le donne, tradizionalmente più religiose degli uomini, siano oggi coloro che più abbandonano la Chiesa. Come mai?«La risposta va rintracciata nei più ampi processi di mutamento – demografico ed economico, sociale e culturale – che hanno accompagnato il passaggio dalla società industriale a quella postindustriale, e che si sono riverberati sulla vita delle donne e sulle relazioni tra i generi. Non a caso, le teorie che si propongono di fornire una spiegazione al fenomeno della secolarizzazione femminile prendono in esame le molte sfaccettature del processo di mutamento poc’anzi richiamato».Quanto pesa, in questo allontanamento, la rivoluzione culturale e sessuale iniziata negli anni Sessanta? «Le teorie che mirano a spiegare l’allontanamento delle donne dalle chiese nei Paesi cristiani chiamano in causa la rivoluzione culturale e sessuale degli anni Sessanta e il sorgere delle istanze femministe – fuori e dentro le chiese –, almeno quanto l’entrata delle donne nel mercato del lavoro. È unanime la convinzione che la conquista della libertà sessuale e del diritto di decidere di sé stesse e del proprio corpo abbia spinto le donne ad abbandonare i modelli di femminilità ispirati all’idea cristiana di pietas. Il nuovo ordine morale si è tradotto in una scarsa partecipazione alla vita delle chiese, come si evince anche dalle statistiche della popolazione che rivelano una diminuzione dei battesimi e dei matrimoni religiosi e un aumento delle nascite da convivenze more uxorio. L’agenda femminista, inoltre, si è fatta presto strada nelle chiese».Come? «Inducendo le donne a criticare il cristianesimo in quanto tradizionale bastione del patriarcato: le battaglie storiche avvenute in molte chiese per l’ordinazione femminile, la recente mobilitazione per l’entrata delle donne in ruoli di governo e il nodo critico degli abusi su bambini e religiose hanno contribuito a risvegliare nuova consapevolezza, oltre che nuove rivendicazioni. Più influente, poi, di ogni crisi della fede, è stata all’entrata delle donne nel mercato del lavoro, avvenuta nei Paesi occidentali a partire dai primi anni Sessanta del Novecento. Per alcuni studiosi è semplicemente una questione di mancanza di tempo; per altri, invece, non è il poco tempo a indurre a sacrificare la partecipazione religiosa. L’abbandono è, piuttosto, il frutto di una decisione deliberata, maturata in un clima in cui il lavoro diventa, per le donne, “un antidoto a quella deprivazione sociale che le porta a cercare conforto nella religione” o, anche, “un sostituto della religione come fonte di stima”».Questo processo di allontanamento riguarda solo l’Italia o lo possiamo considerare, per così dire, occidentale?«Sicuramente europeo. E si abbina a un processo, spesso poco studiato, di parziale riduzione delle differenze di genere nel cristianesimo. Da una parte, il processo di modernizzazione – che, a partire dal tardo XIX secolo, ha visto le donne acquisire i diritti formali e ottenere uno status sociale – ha incoraggiato una riduzione delle differenze di genere e un orientamento sociale maggiormente egualitario tra i sessi in tutti gli ambiti, compreso quello religioso. Dall’altra, la crescita della secolarizzazione – che ha segnato la perdita di influenza della religione sulle politiche della morale, relative, ad esempio, alla famiglia e alla sessualità – ha ridotto l’impatto delle convinzioni religiose sui ruoli di genere».Nei Paesi nordeuropei - dove alcune chieste protestanti hanno aperto anche al sacerdozio femminile - la secolarizzazione non sembra essersi arrestata, anzi, procede assai speditamente. Forse le «aperture» dottrinali, in cui anche nel mondo cattolico non pochi guardano con fiducia, non sono poi un gran rimedio al processo di cui parla? «I dati quantitativi disponibili per la Fennoscandia – in cui alcune chiese, ormai da decadi, hanno aperto alle donne il ministero ordinato – non fanno che confermare il già noto piano inclinato che simboleggia il declino della partecipazione religiosa, pure femminile. Quell’apertura non arresta l’emorragia delle donne e, d’altra parte, non può neanche essere perseguita come “ultima spiaggia” per trattenere le fedeli. Il fatto, tuttavia, che per una crescente porzione di donne l’impossibilità di accedere al sacerdozio sia percepita come una discriminazione ingiustificata innescata da un trattamento diseguale dovrebbe sollecitare, nel mondo ecclesiastico, un serio ripensamento del modo di concepire la relazione tra i sessi, scardinando la classica dialettica della gerarchia tra i sessi che una certa teologia insegna non avere alcun fondamento teologico battesimale».Visto da vicino, l’allontanamento dalla Chiesa delle donne è una vera e propria secolarizzazione oppure corrisponde anche all’avvicinamento di queste giovani alle spiritualità alternativa e neopaganesimo? «Credo sia più opportuno leggere la secolarizzazione in termini di scristianizzazione perché quello cui stiamo assistendo è la crisi della religione in forma confessionale e non la crisi della religione tout court. Siamo in un’epoca di boom religioso: il senso del sacro non si è perso. La Chiesa cattolica, e altri attori religiosi, hanno assecondato forme “degenerate” di sacro – semplificate, mercificate, brandizzate – e ora si trovano battute da chi fa l’offerta ancora più allettante. Lo testimonia, anche in Italia, il successo delle “spiritualità contemporanee” cui può essere rubricato il neopaganesimo. Se per i giovani – e per le giovani – l’approdo alla neo-stregoneria o al neo-druidismo si configura, spesso, come un consumo ludico e ricreativo appagato dal trovare in internet il tutorial per costruirsi il proprio altare domestico o dal partecipare a rituali online insieme ad altri praticanti più o meno solitari, per le donne più adulte tale approdo implica, in maggiore misura, una conversione, se così la possiamo chiamare».In che modo avviene questo avvicinamento al neopaganesimo e al mondo della stregoneria? Che caratteristiche hanno le donne protagoniste di queste dinamiche? «L’affiliazione delle donne – tendenzialmente adulte – alle correnti della neo-stregoneria è spesso motivata dal fatto che queste tradizioni permettono loro di officiare e di amministrare il sacro diventando, all’interno delle congreghe, “sacerdotesse”, “facilitatrici” o “guide”, e quindi di ricoprire ruoli di leadership negati in altri percorsi religiosi, in primis dal cattolicesimo da cui molte di loro provengono – essendo state, spesso, credenti e praticanti. Non poche affermano di trovare in questa “tealogia” una visione del corpo e della sessualità più friendly rispetto alla religione che hanno abbandonato. Va sottolineato che si tratta di donne adulte, anche perché i servizi, le pratiche, i trattamenti e i corsi per avviarsi all’iniziazione sono tendenzialmente a pagamento e, per di più, questo stesso milieu olistico diventa per molte di loro uno sbocco professionale; tant’è che alcuni hanno parlato di un vero e proprio processo di genderdizzazione della neo-stregoneria che alimenta una maggiore presenza di donne nei ruoli gestionali, spirituali e no».A ben vedere, comunque, l’Occidente dove le donne si allontanano dalla Chiesa è pure quello in cui nascono sempre meno bambini e in cui i matrimoni, non sono religiosi, sono in caduta libera. Non sarà che, forse, la vera crisi è quella del «per sempre» e della fiducia nel futuro? «La nostra è un’epoca in cui la “svolta soggettivistica” della cultura moderna mostra i suoi effetti in tutti i campi della vita sociale, dall’istruzione alla cura, dal mercato alla famiglia. Non sorprende, dunque, che anche nella religione le persone vogliano decidere per sé in base al sentore del momento, in accordo alla logica dell’autenticità: “Scegliere quello che funziona per me in questo momento della vita”».Anche in casa cattolica sembrano esserci dei sorprendenti ritorni, come quello dell’antico ordine delle vergini consacrate, che oggi vede oltre 4.000 religiose nel mondo, con segnali di crescita anche in Occidente. Forse, nell’era liquida di cui parlava Bauman, la «fede forte» può dire la sua? «Questa tesi è piuttosto controversa. È vero che, come affermano alcuni studiosi, la “fede forte” – non annacquata, le cui comunità di riferimento alzano le barriere all’accesso chiedendo ai loro membri un impegno esigente e radicale – attira le nuove giovani generazioni, come testimoniano le vergini consacrate, gli ordini contemplativi e ora anche molti sacerdoti e parroci “secolari” in tutto il mondo. Ma è anche vero che comunità e gruppi di questo tipo, dopo essersi distinti negli ultimi anni per un certo successo derivante da un alto tasso annuale di reclutamento, stanno ora scontando un progressivo indebolimento».
Intervista con Barbara Agosti, chef di Eggs, la regina delle uova che prepara in ogni modo con immensa creatività
Francesco Saverio Garofani (Imagoeconomica)
Annalisa Cuzzocrea (Ansa)
Elon Musk e Francesco Saverio Garofani (in foto piccola) Ansa