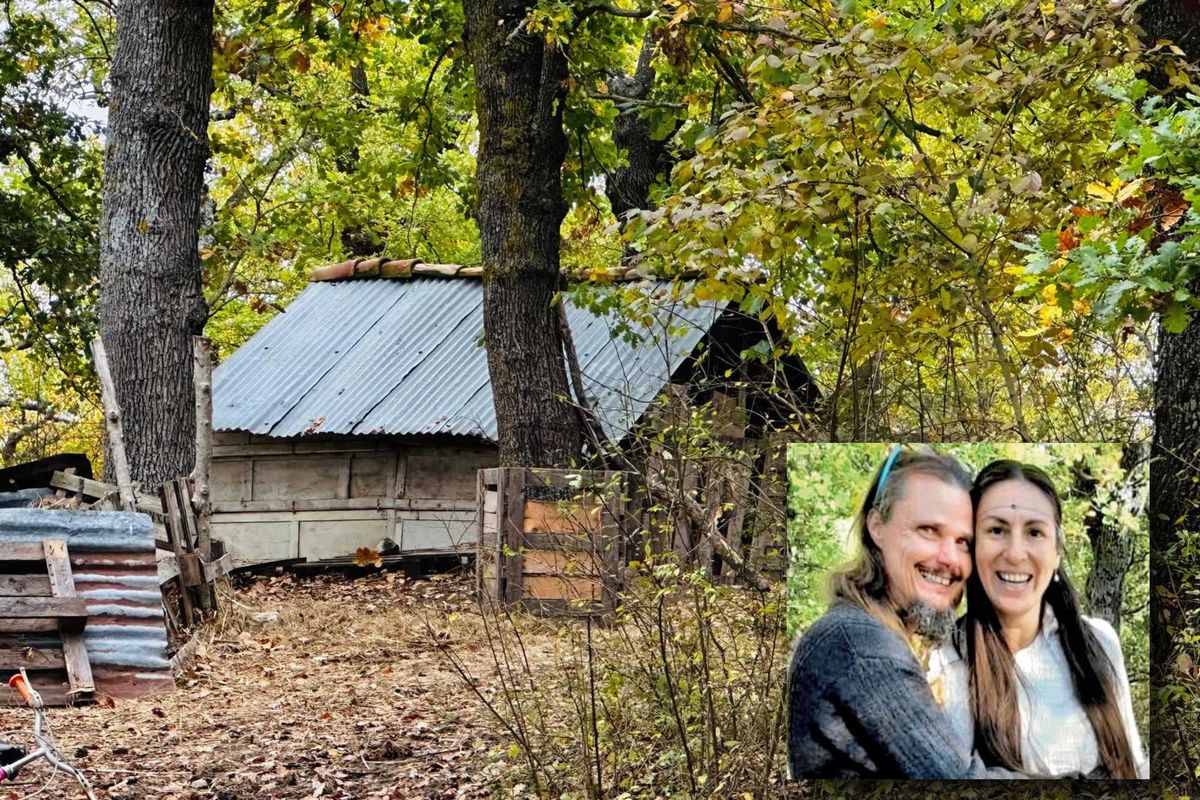2025-08-18
Da Nilin a Solzhenitsyn, il ribelle è chi non accetta la menzogna
Aleksandr Solzhenitsyn (Getty Images)
Prima di «Arcipelago Gulag», uno scrittore mise in luce la crudeltà del modello sovietico in un romanzo che paradossalmente in Urss fu un successo. Ora viene ripubblicato in Italia e ha molto da insegnare anche a noi.Aleksandr Solzhenitsyn, al solito, era andato dritto al cuore del problema. Aveva capito perfettamente - anche perché ne aveva sperimentato sulla carne l’oppressione - quale fosse il vero motore del comunismo reale: la menzogna. Una menzogna pervasiva, diffusa, a cui tutti i sudditi del regime loro malgrado partecipavano. «Ciò che ci sta addosso non si staccherà mai da sé se continueremo tutti ogni giorno ad accettarlo, ossequiarlo, consolidarlo, se non respingeremo almeno la cosa a cui più è sensibile. Se non respingeremo la menzogna», scriveva l’autore di Arcipelago Gulag. «Ed è proprio qui che si trova la chiave della nostra liberazione, una chiave che abbiamo trascurato e che pure è tanto semplice e accessibile: il rifiuto di partecipare personalmente alla menzogna. Anche se la menzogna ricopre ogni cosa, anche se domina dappertutto, su un punto siamo inflessibili: che non domini per opera mia!».Secondo Solzhenitsyn chi rifiuta la menzogna - cioè la verità imposta dal regime con la forza e il ricatto, una verità falsa e disumana - può davvero contribuire a smontare l’intero sistema. «È questa la breccia nel presunto cerchio della nostra inazione: la breccia più facile da realizzare per noi, la più distruttiva per la menzogna», diceva. «Poiché se gli uomini ripudiano la menzogna, essa cessa semplicemente di esistere. Come un contagio, può esistere solo tra gli uomini. Ognuno di noi dunque, superando la pusillanimità, faccia la propria scelta: o rimanere servo cosciente della menzogna (certo non per inclinazione, ma per sfamare la famiglia, per educare i figli nello spirito della menzogna!), o convincersi che è venuto il momento di scuotersi, di diventare una persona onesta, degna del rispetto tanto dei figli quanto dei contemporanei».E come in Solzhenitsyn, anche in Crudeltà, capolavoro del romanziere sovietico Pavel Nilin, al centro di tutto sta la menzogna. O, meglio, la scoperta di un sistema basato sulla menzogna la cui profonda e terribile essenza si disvela quando crollano le illusioni che gli facevano da maschera. Questo libro, coraggiosamente ripubblicato dalla interessante casa editrice Readerforblind, uscì in Russia nel 1956 e paradossalmente (fra poco vedremo perché) fu un successo. In Italia venne tradotto da Feltrinelli, ma presto se ne persero le tracce. Ed è un vero peccato perché Crudeltà è non soltanto un libro di toccante lettura, ma anche un atto di condanna precocissimo verso l’Unione Sovietica e il suo tallone opprimente.Superficialmente si tratta di un giallo ambientato negli anni Venti e ruvido come un western o un poliziesco contemporaneo. Una entusiasmante caccia all’uomo nelle distese siberiane che diventa esplorazione esistenziale. Il protagonista è il giovanissimo poliziotto investigativo Veniamin «Ven’ka» Malyšev, di servizio a Dudari e impegnato assieme ai colleghi, poco più che ragazzini, nella repressione del banditismo locale. Nilin conosceva bene il fenomeno: nato in Siberia nel 1908, era stato corrispondente di guerra e giornalista, dunque aveva vissuto prima che osservato la realtà di quei luoghi.Come scrive nella prefazione alla nuova edizione del romanzo Antonella Nocera, «gli anni Venti furono in Siberia lo scenario della faticosa e pervicace fase di irreggimentazione delle province remote della Russia al verbo comunista. Regioni per loro natura selvagge e poco addomesticabili, in ogni senso. Luoghi dove tutte le contraddizioni della recente guerra civile, della resistenza armata dei kulaki e dei muzik, dei reparti della vecchia armata bianca, componevano una massa umana pronta a esplodere e a conflagrare di fronte alle nuove istanze che i commissari del regime imponevano sul territorio, in roccaforti sempre più capillari». Nel romanzo, «i banditi imperversano nei meandri della taiga e su tutti troneggia “l’imperatore di tutta la taiga”, Kostja Voroncov, capo della banda più violenta. Il regime sovietico deve ripulire il campo affinché il sogno di rinnovamento e modernizzazione, fomentato dal riformismo della Nep, venga accettato come idea, proiezione mentale, prima che come progetto teorico, politico anche in queste remote regioni del mondo, dove i contadini vivono di latte appena munto, nelle izbà innevate, insieme ai loro animali, di semplici cose illuminate dalla meravigliosa natura del caliginoso oceano della taiga».La polizia che cerca di avere ragione dei banditi è l’incarnazione di uno Stato che diviene onnipervasivo e deve sottomettere, schiacciare il diverso e il dissenziente. Nilin, che pure non era anticomunista e fu anche acclamato in patria, coglie questo aspetto spaventoso del regime in cui vive, e lo fa prima di molti altri. Il personaggio più negativo del romanzo non è guarda caso un bandito ma un giornalista, Jakov Uzelkov, simbolo della menzogna, della mistificazione della realtà, della propaganda. Alle sue esagerazioni e bugie si contrappone la fede del poliziotto Ven’ka nella verità dell'essere umano. Ma è esattamente questa verità che il regime nega, e Ven’ka suo malgrado se ne accorge. A un certo punto della storia lo sentiamo dire: «Non possono esistere tesi in base alle quasi si debba mentire e punire chi non è colpevole, soltanto per dimostrare qualcosa a qualcuno. Non è possibile. Per me, la menzogna è segno di paura. I borghesi vi ricorrevano perché temevano che la verità fosse contro di loro. Noi invece possiamo dire sempre la verità, non abbiamo nulla da nascondere. Questo lo comprendo benissimo, non mi occorre alcuna tesi. Però non sono in grado di spiegarlo». Quello di poter dire sempre la verità in Urss si rivela un sogno, una speranza decisamente mal riposta. Un pezzo alla volta, sotto gli occhi di Ven’ka, le promesse rosse si sciolgono.«Nilin sceglie una porzione storica scomoda e difficile da snocciolare, proprio perché ne ha una conoscenza profonda ed è consapevole di creare un cortocircuito», scrive ancora Antonella Nocera. «Collocati negli anni Venti, i fatti di cui narra appaiono come i prodromi di una storia che è giunta alla sua parabola finale, ma non ha ancora chiuso il sipario. La sua operazione letteraria pone in atto un confronto forzato, ben prima della denuncia ufficiale dei crimini, costringe a rivedere il punto d’inizio, le premesse, gli ideali ora in frantumi, le verità trapassate in menzogna, gli errori, le responsabilità. Questo cortocircuito determina uno straniamento di cui egli è perfettamente padrone, sia a livello stilistico che contenutistico. Come introiettare questo convincimento posticcio, innescare la credenza, sostituire un mondo arcaico con il sogno aurorale del nuovo comunismo?».La crudeltà vera è dunque quella del regime della menzogna che sostituisce - con la violenza - valori artificiali ai valori tradizionali profondamente umani. Valori che sopravvivono nei singoli, pure nei fuorilegge che il «poliziotto buono» insegue.«Ven’ka si perde, in questa insanabile contraddizione», dice la Nocera. «Lui cellula infima del komsomol, che crede ingenuamente in una pietas che non esiste più nelle città delle fabbriche statalizzate, nella risoluta avanzata dell’ideologia di partito. Resiste, ancora, nelle comunità rurali, dove brilla quell'ultimo residuo di počva (ciò che Dostoevskij chiamava suolo, la terra a cui ancorarsi, ndr) che tanto fu decantata dalla generazione degli scrittori ottocenteschi. In questo eroe della libertà etica, si consuma l’eterno e insanabile conflitto tra moralità e realpolitik: lui sceglie di stare dalla parte dell’etica trasversale, che può appartenere al bandito muzik, come al più alto dei dirigenti del komsomol. Tuttavia, scegliere non è consentito nella forma altamente gerarchizzata dell’apparato di potere. E chi sceglie per sé, paga».Crudeltà non è (ancora) un romanzo del dissenso, ma anticipa i temi degli scrittori protestatari. Coglie l’intima violenza del regime e lancia un avvertimento. Un appello a non abbandonare la verità che - seppure viviamo in un contesto molto diverso e meno feroce ma stranamente simile - è rivolto anche a tutti noi.
Alessandra Coppola ripercorre la scia di sangue della banda neonazi Ludwig: fanatismo, esoterismo, violenza e una rete oscura che il suo libro Il fuoco nero porta finalmente alla luce.