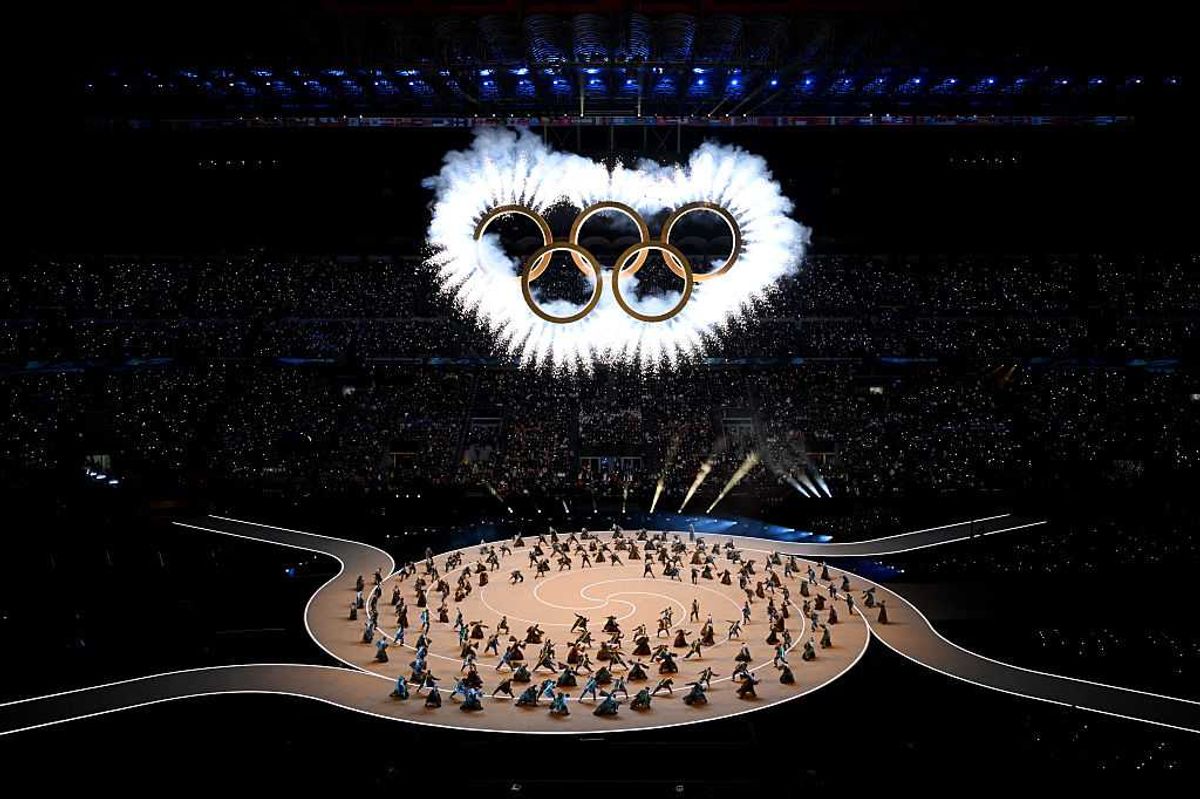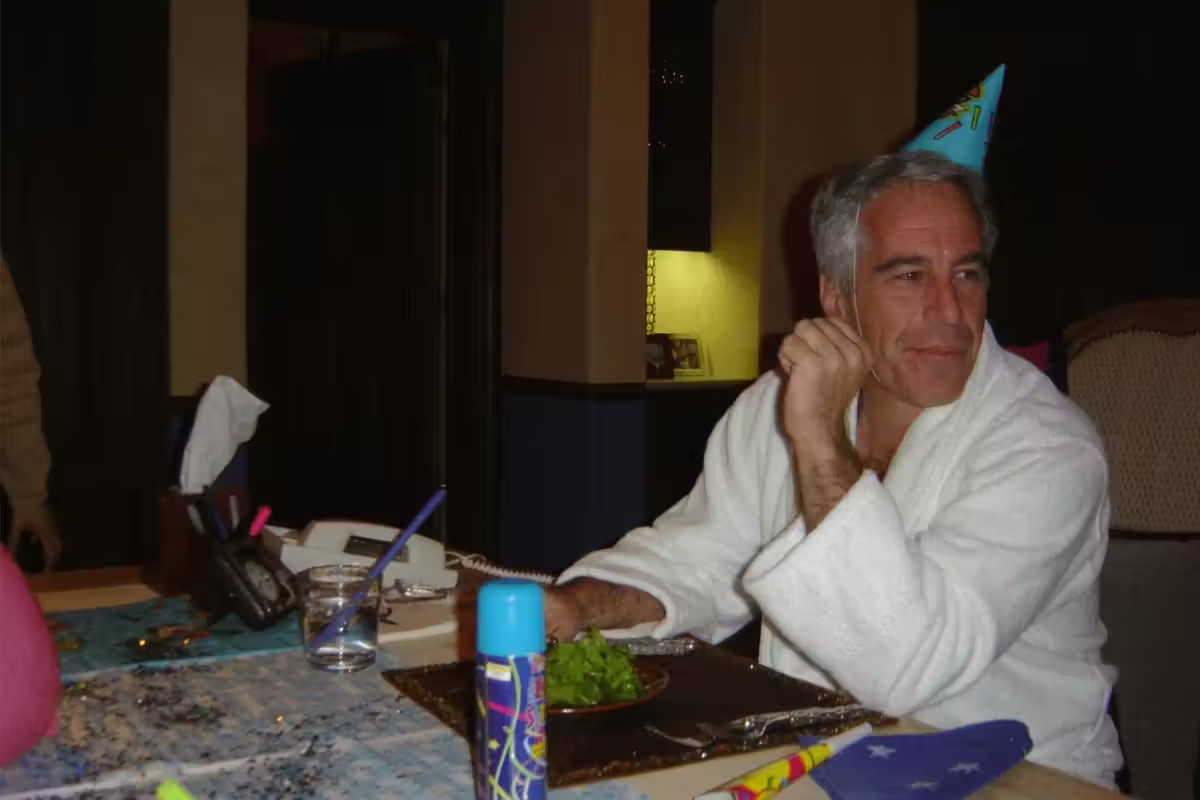«Fermati mentre scoprivamo il sistema mafia-appalti che coinvolgeva la sinistra»

Il suo vecchio comandante, l’allora tenente colonnello Mario Mori, rimase colpito da lui perché nella Palermo del 1987, giovane tenente, catturò, rincorrendolo per i vicoli della città, un rapinatore armato. Ma quando riuscì a bloccarlo, per ottenere aiuto, fu costretto, in una città omertosa, a puntare una pistola contro una signora alla finestra per convincerla a chiamare il 112. Il colonnello (non è mai stato promosso generale) Giuseppe De Donno, 60 anni, originario della provincia di Bari, non ama i riflettori e quando gli chiediamo una foto per questo articolo ci invia un’immagine in bianco e nero con Giovanni Falcone.
Forgiato alla scuola della Nunziatella e all’Accademia di Modena, ha percorso gran parte della sua carriera nel Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri, prima di passare al Sisde, i servizi segreti interni, nel 2001, quando divenne direttore il suo amico Mori, agenzia dove è rimasto sino al 2007. Poi ha lasciato l’Arma e da allora fa il consulente aziendale.
Negli anni ’90 è stato in prima linea nella lotta a Cosa nostra al fianco di Falcone e Paolo Borsellino. Per quella sua attività investigativa è stato imputato, sempre insieme a Mori nell’inchiesta sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia.
I due sono stati assolti in via definitiva e adesso hanno dato alle stampe un duro j’accuse, intitolato La verità sul dossier mafia-appalti, ovvero il rapporto su cui i due lavorarono e che ritengono possa essere all’origine dei loro guai giudiziari, ma soprattutto la vera causa dell’eliminazione di Falcone e Borsellino.
Perché lei e il generale Mori avete scritto il libro solo adesso?
«Semplice: essendo stati assolti dalle accuse che ci avevano rivolto, non possono esserci dubbi sulla nostra buona fede. Sarebbe stato troppo facile per qualcuno dire che “parlavamo” per interessi processuali».
È vero che Borsellino, contrariamente da quanto sostenuto da alcuni magistrati, conosceva perfettamente il rapporto mafia-appalti?
«Borsellino (in realtà De Donno, quando nomina i magistrati, aggiunge sempre il titolo accademico di dottore, ndr) lo conosceva benissimo perché all’indomani della consegna dell’elaborato a Falcone ne chiese una copia, che su autorizzazione dell’amico Giovanni, gli venne consegnata. Era interessato ad alcuni appalti che ricadevano nella sua giurisdizione di procuratore di Marsala e certamente aveva avuto modo di confrontarsi sul tema con Falcone».
Quel dossier è la causa della morte di Borsellino?
«Dalle ultime risultanze processuali sembrerebbe proprio di sì. Pare che proprio la sua determinazione a rivitalizzare quell’indagine, soprattutto unendo gli sforzi con i magistrati della Procura di Milano, sia stata la causa ultima della sua condanna a morte».
Poche ore dopo la morte di Borsellino il procuratore Pietro Giammanco ha controfirmato la richiesta di archiviazione di un filone importante di quel fascicolo e in pochi giorni il giudice ha accolto l’istanza. Si può dire che quell’inchiesta si sia spenta con Borsellino?
«A parte altre possibili e più inquietanti motivazioni, nessuno ha più guardato a quell’indagine con la determinazione e la prospettiva di Borsellino. Il nostro lavoro andava certamente sviluppato, ma serviva, però, il coraggio di approcciare i fatti in modo diverso. Noi ritenevamo che le componenti di quel sistema, politici imprenditori e Cosa nostra, fossero “soci” in affari. Non esisteva estorto o minacciato, ma tre parti che si spartivano gli affari da buoni amici e ciò comportava che il reato a tutti addebitabile fosse il 416 bis. Questo era l’approccio giusto. E per averne la conferma basterebbe leggere le dichiarazioni rese da Falcone (spesso citato a sproposito) davanti alla commissione Antimafia in audizione a Palermo poco prima di trasferirsi al ministero a Roma, in cui indicò chiaramente che la sua strategia di attacco a Cosa nostra era imperniata sul contrasto alla illecita gestione degli appalti pubblici».
Che cosa vi siete detti con Borsellino nella caserma Carini di Palermo il 25 giugno 1992, pochi giorni prima della sua uccisione?
«Borsellino chiese di vedere il generale Mori e me alla caserma Carini e non in Procura e già questo significa molto. In quel breve ed emozionante incontro il dottore, che si era fermato prima di farmi entrare nella stanza alcuni minuti da solo con Mori, mi disse che gli avevano parlato molto male di me, che gli avevano riferito che ero un pazzo fuori controllo, ma che lui aveva fatto le sue verifiche e sapeva che non era vero e che se di me si era fidato Falcone poteva fidarsi pure lui. Proseguì dicendo che era sua intenzione riprendere tutta l’indagine mafia-appalti e mi chiese la mia disponibilità. Risposi: “Non chiedo altro”. Precisò che il tutto andava fatto a una sola condizione: che comunicassi solo ed esclusivamente con lui e che non parlassi di quell’attività con nessuno in Procura. Risposi: “Io già non parlo con nessuno in Procura”. Concordammo che mentre lui si trovava in Germania per una rogatoria, io avrei predisposto un piano con tutto quello che ritenevo necessario per riprendere il lavoro e che ci saremmo rivisti al suo rientro. Non ci fu, purtroppo, nessun altro incontro».
Che cosa pensa dei verbali del Csm diventati pubblici solo quasi trent’anni dopo la loro stesura?
«Quelle carte, che per decenni ci sono state precluse, sono state conosciute solo per l’ostinazione con cui le abbiamo cercate. È incredibile che per così tanto tempo non siano state consultabili».
E che cosa raccontano quegli atti?
«Intanto dimostrano l’acredine che moltissimi magistrati nutrivano nei confronti di Falcone e Borsellino. Leggere le audizioni sui “veleni palermitani” permette di capire che aria malsana si respirasse e come venisse descritto soprattutto Falcone, che dopo la sua morte è diventato “Giovanni” per tutti. Non credo di svelare nessun mistero dicendo che l’arrivo di Borsellino in Procura a Palermo non avesse suscitato l’entusiasmo di tutti. Sono note le liti con il procuratore Giammanco, la mancata assegnazione della competenza sul territorio palermitano, l’assenza di comunicazione all’interno dell’ufficio ecc. Grazie a quei verbali abbiamo potuto ricostruire la famosa riunione del 14 luglio in cui Borsellino chiese conto ai suoi colleghi delle mancate attività sul nostro rapporto mafia-appalti e la circostanza che nessuno gli riferì che il giorno prima era stata firmata una richiesta d’archiviazione per parte di quel fascicolo».
L’ex pm Roberto Scarpinato, il quale chiese personalmente la chiusura di quel filone, si è giustificato dicendo che a quella riunione non era presente…
«Sì, ma probabilmente avrebbe potuto riferirglielo in altre occasioni».
I vostri detrattori dicono che nella prima versione del dossier, consegnata nel febbraio del 1991 e utilizzata per arrestare appena cinque persone, non c’erano nomi di politici. Ma lei nel libro scrive che prima di quell’informativa ne avevate consegnate altre due, in cui erano citati personaggi eccellenti, a Falcone, ma anche ad altri pm…
«Si è spesso detto che leggendo il rapporto del 1991 tutti potevano rendersi conto che di politico c’era poco, segno che a cercare la polemica eravamo noi Carabinieri. Ma già nell’agosto 1990 avevamo dato a Falcone, a Giuseppe Pignatone e a Guido Lo Forte due annotazioni con allegate tutte le intercettazioni telefoniche e le prime risultanze che riguardavano esponenti politici di rilievo regionale e nazionale. In quelle carte specificavamo che, non avendo ancora effettuato gli opportuni riscontri, per evitare inutili speculazioni, inviavamo il materiale ai magistrati per una prima valutazione».
Nel libro riportate le dichiarazioni di alcuni pentiti che accusano Pignatone e Giammanco di aver spifferato i segreti di mafia-appalti ad ambienti vicini a Cosa nostra. L’ex “ministro dei lavori pubblici della mafia”, Angelo Siino, uno dei cinque arrestati nel primo troncone dell’inchiesta, avrebbe evidenziato le presunte collusioni famigliari di Pignatone con la Piovra e avrebbe definito Lo Forte un “corrotto”, mentre, per lui, Scarpinato era “uno che non capiva niente”. Tutti questi signori, escludendo Giammanco, sono oggi considerati campioni della lotta alla mafia. Non è sbagliato riportare in un libro certe dichiarazioni contraddette dalle archiviazioni?
«Abbiamo dato ampio risalto al fatto che le indagini svolte dall’autorità giudiziaria di Caltanissetta non abbiano raccolto sufficienti prove di colpevolezza nei confronti di nessuno. Ci siamo limitati a raccontare la storia di quella indagine per come risulta dagli atti ufficiali. Credo sia corretto riportare tutti gli elementi utili a offrire un quadro completo. Anche noi siamo stati assolti, ma c’è chi continua a rinfacciarci le contestazioni che ci erano state rivolte. E io non mi ritengo certo diffamato se il racconto è rispettoso dei fatti».
È vero che il procuratore Giammanco inviò una copia del dossier al ministro della Giustizia Claudio Martelli, indicando, in una nota, che quel rapporto aveva «un interesse politico e non giudiziario»?
«Sì è vero. E qui domando: ma se, come si sostiene, quel rapporto era privo di valenza politica, perché una persona tanto acuta come Giammanco ha sentito il bisogno di spedirlo ad autorità politiche violando il segreto investigativo in maniera così plateale? Forse perché andava conosciuto e letto da altri? Io non so spiegarlo».
Come è iniziata la sua collaborazione con Siino?
«Il nostro rapporto partì da uno scambio di occhiate al processo, in cui intuii che Siino volesse parlarmi e di lì si sviluppò tutto in maniera confidenziale perché lui non voleva assolutamente collaborare in modo ufficiale perché, se lo avesse fatto, ci avrebbero ammazzati entrambi».
Nel libro racconta di appuntamenti clandestini…
«Sì. Quando si spostava dal tribunale al carcere gli chiedevo di fermarsi in una nostra caserma con la scusa di dover andare urgentemente in bagno e così ci incontravamo. Alcuni colloqui sono avvenuti anche nella toilette dell’ospedale in cui era ricoverato. Poi ad un certo punto decise di collaborare con la Procura di Palermo, la quale, invece, di affidarlo a noi, come sarebbe stato logico, avendo noi svolto tutte le indagini sul suo conto e sul contesto a lui collegato, lo fece gestire alla Guardia di finanza. Il motivo andrebbe chiesto a quei magistrati, anche se da un punto di vista formale la Procura di Palermo poteva prendere tale decisione».
Antonio Di Pietro, sentito tre giorni fa in commissione Antimafia, ha dichiarato che «Siino era stato defenestrato da Filippo Salamone» e ha aggiunto: «Cannai io, ma pure loro». Cioè voi del Ros. Significa che avevate sopravvalutato l’importanza di Siino, uno che aveva la terza media, mentre Salamone era un ingegnere?
«Di Pietro credo si riferisca al fatto nella nostra prima informativa non capimmo che alcune intercettazioni telefoniche facevano riferimento a Salamone e non a Siino. A Salamone arrivammo solo in un secondo momento».
Salamone aveva un fratello magistrato a Brescia che incriminò Di Pietro. Pensa che sia stato un caso?
«Non lo so, andrebbe chiesto ai protagonisti di quella vicenda».
L’inchiesta mafia-appalti aveva un filo rosso che la legava a quella nota come Mani pulite della Procura di Milano?
«Le due indagini erano collegate. Alcuni personaggi comparivano in entrambi i procedimenti e in entrambi il convitato di pietra era Cosa nostra. Sarebbe stato esplosivo il coordinamento investigativo tra le due Procure».
E come mai non si è perfezionata la collaborazione con Di Pietro e il pool di Tangentopoli?
«Questo andrebbe chiesto a Di Pietro e ai magistrati palermitani. Ad ogni modo dopo la morte di Borsellino, che spingeva in quella direzione, e nonostante le nostre sollecitazioni (Di Pietro ha confermato in dibattimento che noi del Ros abbiamo fatto di tutto per spingerlo ad occuparsi delle vicende palermitane) non si pervenne a nessun coordinamento operativo».
Nella «madre di tutte le tangenti», quella Enimont, una quota era destinata al politico siciliano Salvo Lima, considerato interlocutore della mafia… come lo spiega?
«Non mi stupisce, soprattutto se si considera che siamo stati noi del Ros a dimostrare il collegamento tra la famiglia Buscemi, legata a Cosa nostra, e la Calcestruzzi del gruppo Ferruzzi, guidato all’epoca da Raul Gardini, all’epoca un vero e proprio impero. Tanto da far dire a Falcone che la mafia era entrata in Borsa.
Quel gruppo divenne socio nelle cave di marmo di Carrara di Antonino e Salvatore Buscemi, due mafiosi. Le imprese che operavano al Nord erano le stesse che agivano al Sud».
Perché Gardini secondo lei si è suicidato? Per Tangentopoli o per i rapporti delle sue aziende con uomini legati a Cosa nostra?
«Non ho elementi sufficienti per darle una risposta. A detta di Di Pietro, però, il giorno in cui si tolse la vita, Gardini avrebbe dovuto confessargli i legami con Cosa Nostra. Forse non sapremo mai la verità».
Perché in questi anni si è cercato solo di approfondire i link tra la mafia e Berlusconi e non quello con altri grandi imprenditori?
«Questo andrebbe chiesto a chi ha condotto quelle indagini».
C’era un legame tra la sinistra e la cosiddetta Onorata società?
«Ciancimino nelle sue dichiarazioni all’autorità giudiziaria spiega perfettamente come tutti i partiti avessero i propri canali di finanziamento illecito collegati alla criminalità organizzata. Le varie indagini che si sono succedute credo che abbiano confermato ampiamente tale assunto. Ad esempio nelle investigazioni svolte con la Procura della Repubblica di Napoli abbiamo dimostrato come anche le cosiddette coop rosse fossero inserite in questo sistema illegale di gestione degli appalti pubblici».
È vero che l’ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino aveva fatto proposte di collaborazione in cambio di un regime carcerario meno duro? Ci può raccontare come andò?
«Dopo il suo arresto, Mori e io lo convincemmo a collaborare con la Procura di Palermo. Rese un fiume di dichiarazioni raccolte dai magistrati in numerosi verbali. In quell’ambito gli venne chiesto anche del famoso incontro tra Giulio Andreotti e Salvatore Riina. Nella prima fase negò che potesse essere vero perché sosteneva che Lima, referente andreottiano in Sicilia, non avrebbe mai permesso tale abboccamento. Poi, però, un giorno, avendo appreso che il pentito Francesco Marino Mannoia aveva datato il presunto incontro, riferì che in quell’anno era successo qualcosa che avrebbe potuto spingere Lima a rischiare davvero di organizzare il famoso meeting tra Andreotti e Riina. Quindi disse che avrebbe fornito gli elementi di sua conoscenza solo se fosse stato portato fuori dal carcere, in una qualsiasi caserma o struttura controllata e scelta dalla Procura, dove potesse stare al caldo ed essere curato (sempre sotto costante vigilanza e controllo dei carabinieri o di qualsiasi altra forza di polizia) e aspettare l’esito degli accertamenti. In caso di riscontro positivo delle sue parole sarebbe stato sottoposto a un programma di protezione, in caso contrario sarebbe rientrato in carcere».
Detta così, una proposta ragionevole…
«Ma tale richiesta non fu accolta, nonostante i nostri ripetuti solleciti. E Ciancimino non disse mai ciò che sapeva. Posso pensare che la Procura non si fidasse della genuinità della sua collaborazione e per questo non aderì alla proposta, che comunque non ritengo contenesse alcun profilo di rischio o di illiceità».
Ciancimino negava di essere un uomo d’onore. È questo il motivo per cui non è stato possibile un accordo con lui?
«Probabilmente sì. Forse la Procura, in quel momento guidata da Giancarlo Caselli, stretta nei suoi rigidi convincimenti, riteneva che dovesse dichiarare la sua appartenenza formale a Cosa nostra, circostanza che lui decisamente negava pur non nascondendo i suoi rapporti con quel mondo. Non si giunse mai a discutere di un programma di protezione».
Perché era così importante Ciancimino?
«Era l’uomo politico più importante della Sicilia del tempo. Era depositario di immensi segreti. Avrebbe potuto diventare un’arma potentissima nella lotta a Cosa nostra e al malaffare in generale».
Un altro sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, all’epoca campione della lotta alla mafia con il suo movimento, La Rete, rischiò grosso, ma il pm che indagava su di lui, Alberto Di Pisa, fu disarcionato dall’accusa di aver propalato veleni con anonime missive… fu una coincidenza?
«Nel libro raccontiamo quanto è successo. Se fu un caso non lo so ma le coincidenze temporali sono certamente impressionanti. In quella indagine, svolta mentre a Palermo era in pieno sviluppo un movimento di riscatto della città, noi dimostrammo che i maggiori appalti del Comune di Palermo erano ancora nelle mani di Ciancimino, che venne raggiunto, insieme da altri, da due distinte ordinanze di custodia cautelare richieste e ottenute da Falcone. Indagare il sindaco Orlando, come fece Di Pisa, significava sferrare un colpo devastante a una narrazione politica che coinvolgeva ampi strati della società civile palermitana dell’epoca e che dichiarava di voler voltare pagina rispetto agli intrecci politica-mafia. Nel momento in cui si declarava un cambio generazionale si scopriva che ancora nella città di Palermo gli affari rilevanti passavano da un gruppo di persone, tra cui il notissimo Vito Calogero Ciancimino. E non vanno dimenticati gli attacchi che, forse, proprio per queste attività investigative, investirono Falcone e anche l’Arma».
La Trattativa Stato-mafia, con i Carabinieri come ambasciatori, c’è stata e non costituisce reato o non è mai stata intavolata?
«Credo che la sentenza della Corte di cassazione risponda benissimo alla sua domanda. Per quanto mi riguarda non è mai esistita nessuna trattativa per come è stata rappresentata, raccontata e divulgata in questi anni. E continuare a sostenere una tesi tanto aberrante significa continuare a infangare non noi come persone fisiche, ma quella parte di Paese e di istituzioni che, invece, dovrebbe essere meritocraticamente elogiata per aver sostanzialmente vinto la guerra contro Cosa nostra».
Lei, il giorno in cui morì Falcone, avrebbe dovuto essere in macchina con il magistrato...
«È vero. Per una casualità della vita, dovetti scendere a Palermo il giorno prima e lo attendevo là. Una delle ultime telefonate di Giovanni fu a me. Ogni tanto penso a quello strano destino. Oggi potrei avere delle piazze intitolate. E invece sono vivo e sono stato processato come un criminale qualsiasi. Ma sono contento così».