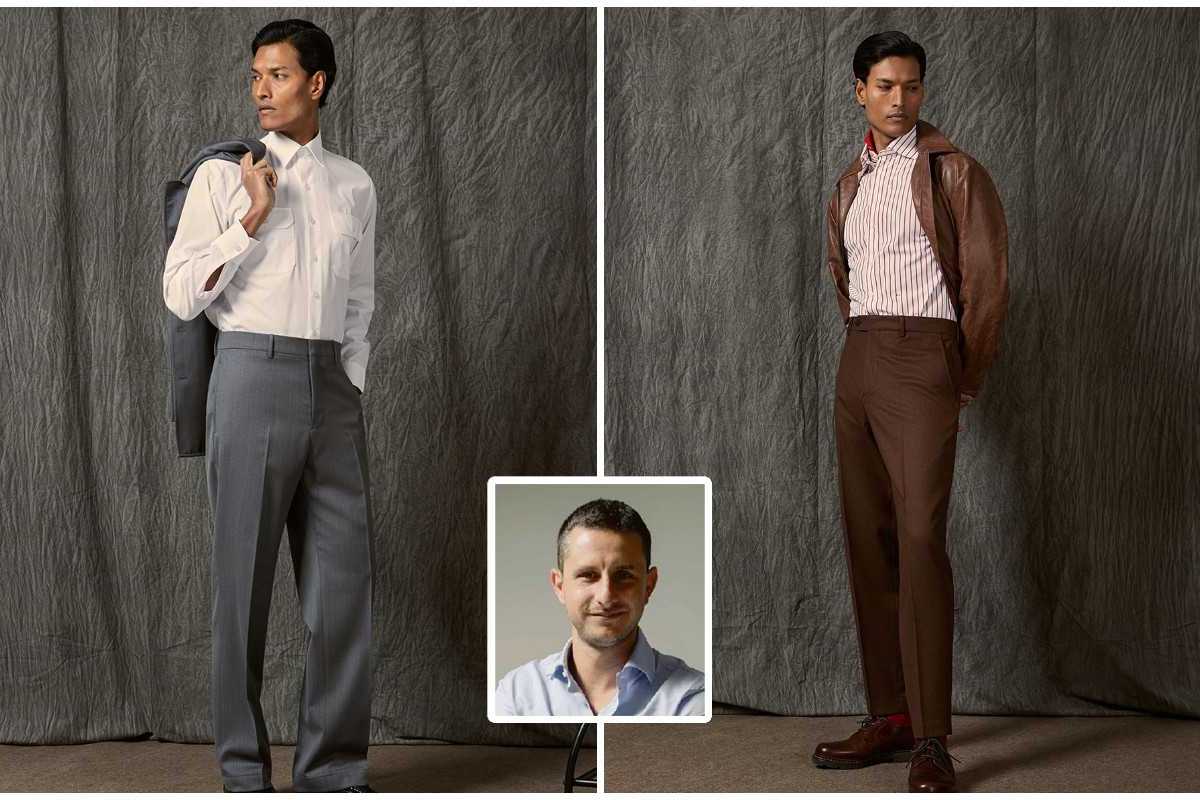I partiti della coalizione di destra in Italia hanno colto che c’è un cambio di mondo che richiede una governabilità precisa, positiva ed innovativa. Quelli di sinistra non lo stanno facendo, diventando un problema per la stabilità e il funzionamento della democrazia.
In sintesi, emerge come rischio destabilizzante per la nazione l’irrazionalità sempre più spesso violenta o troppo conflittuale dei movimenti di sinistra, partitici e sindacali, divergenti dalla ricerca di una formula di buon governo. Scrivo questo perché ritengo che una democrazia - la forma più complessa e fragile di organizzazione sociale - possa sopravvivere, fornire libertà ed opportunità crescenti agli individui, tutti, se ogni parte politica compete per il meglio.
Devo dire che il rischio degenerativo qui individuato fu oggetto di analisi nel lontano 1994 quando Edward Luttwak, Giulio Tremonti ed io ci trovammo in un convegno sul Lago di Como: concordammo, pur con analisi da punti di vista diversi, che nello scenario futuro a 25 anni c’era il rischio di un impoverimento delle democrazie che le avrebbe destabilizzate. Disegnammo sui tovaglioli di un ristorante le tendenze negative e decidemmo di scrivere insieme, con capitoli separati, un libro che sia mostrasse il rischio sia le possibili soluzioni. Tremonti volle come titolo Il fantasma della povertà (Mondadori, 1995). Ci parve corretto per il fatto che tale spettro lo vedevamo in via di materializzazione. Il punto, qui: con mia sorpresa fui invitato da Alfredo Reichlin, prestigioso politico del Partito comunista dei tempi, a presentare il libro, e il mio saggio al suo interno, «Crisi e riforma del capitale», a una platea di gente di sinistra. Quando ci incontrammo si disse sorpreso che un liberista come me si ponesse un problema di tutela del capitalismo di massa, perfino suggerendo soluzioni, che egli riteneva una missione cognitiva e di offerta politica esclusiva della sinistra. E voleva capire cosa stasse succedendo nella destra. Gli risposi che la costruzione del capitalismo di massa, o più accademicamente «capitalismo diffuso socialmente», è il pilastro della democrazia perché induce destra liberale e sinistra socialista a trovare modi per realizzarlo. E se non ci riesce, la democrazia salta a causa dell’aumento degli impoveriti, o senza speranza o comunque con forti motivi rivendicativi perché il consenso si sposta all’estrema sinistra o destra, ambedue con offerte di verticalità inefficiente e inefficace, con incremento dei linguaggi nazionalisti aggressivi per compensare il gap di ricchezza diffusa.
Gli mostrai gli scenari fatti dal mio gruppo di ricerca che mostravano come in tutte le democrazie, chi più chi meno, c’era la tendenza a passare da una configurazione di 2/3 di ricchi (capacità di risparmio) e 1/3 di poveri, ma con speranza di diventare ricchi, a 1/3 di molto ricchi e al resto in impoverimento con un aumento dei poverissimi e senza più speranza. Aggiunsi i dati proiettivi della mobilità ascendente (il figlio guadagna più del padre) che stava calando per confermare le tendenze, pur solo agli inizi, nel mondo. Concordò che la sinistra dovesse cambiare, ma disse che anche la destra liberale avrebbe dovuto farlo. Concordammo, pur mantenendo la diversità: io predicai la trasformazione del welfare redistributivo in uno di investimento (meno tasse e più stimoli al privato portando l’assistenza solo a casi di vero bisogno) e lui si disse convinto che il welfare redistributivo poteva essere armonizzato con un’economia della crescita. Bene, competiamo per lo stesso obiettivo, dissi, ma nella diversità concorrenziale condividiamo l’idea che il capitalismo sia buono se è per tutti e cattivo se solo per pochi. Rispose: sì, possiamo competere e dialogare per il medesimo obiettivo.
Lettori, questa era una sinistra seria, avversaria, ma competente e convergente con la destra liberale sui requisiti di stabilità e miglioramento della condizione umana. Ora non vedo più una sinistra concorrente per competenza. Ne vedo una isterica, irrealistica e violenta. Ne capisco il nervosismo: cresce nelle democrazie la tendenza dei poveri o di chi è in ansia a farsi rappresentare dalle destre piuttosto che dalle sinistre, caso recente più evidente le elezioni presidenziali in America. La gente impoverita e/o pessimista vuole soluzioni forti. All’interno delle destre io temo il protezionismo o degenerazioni peroniste. Per rafforzare la destra liberale - che per nostra fortuna in Italia è solida - penso ci voglia una sinistra competitiva sul piano del realismo economico. Sentire il leader della Cgil che invoca insurrezioni mi fa venire i brividi. Vedere la leder del Pd inseguire il consenso verso le estreme anche. Osservare i contenuti irrealistici M5s mi riempie di pessimismo. Tutti questi cercano di cavalcare la crisi di ricchezza nel sistema non cercando l’inversione del declino, ma la loro sopravvivenza senza cercare nuovi modelli di governo realistico.
In sintesi, promettono più soldi a tutti senza spiegare come si crea la ricchezza poi socialmente diffondibile. Pericolosi? Gli impoveriti potrebbero cadere nella trappola illusoria della sinistra oppure alimentare una destra altrettanto irrazionale. La destra pragmatica ora al governo in Italia è razionale e sta affrontando una missione difficilissima di revisione di un modello impoverente ormai esaurito. Nelle contingenze vi invito a votare destra, ma il cambiamento necessario del sistema nel medio e lungo termine richiede una competizione di qualità per il medesimo obiettivo tra destra e sinistra: la ricchezza di massa e l’ottimismo per raggiungerlo. Gente di sinistra, cambiate i vostri leader cercandone di migliori, salvate la democrazia.