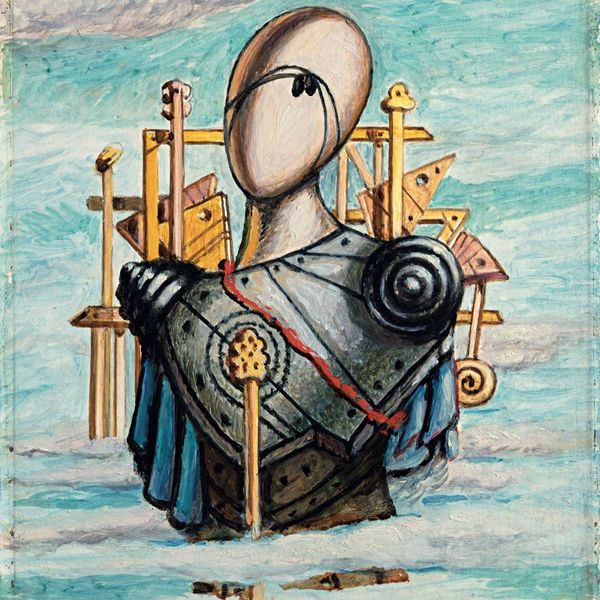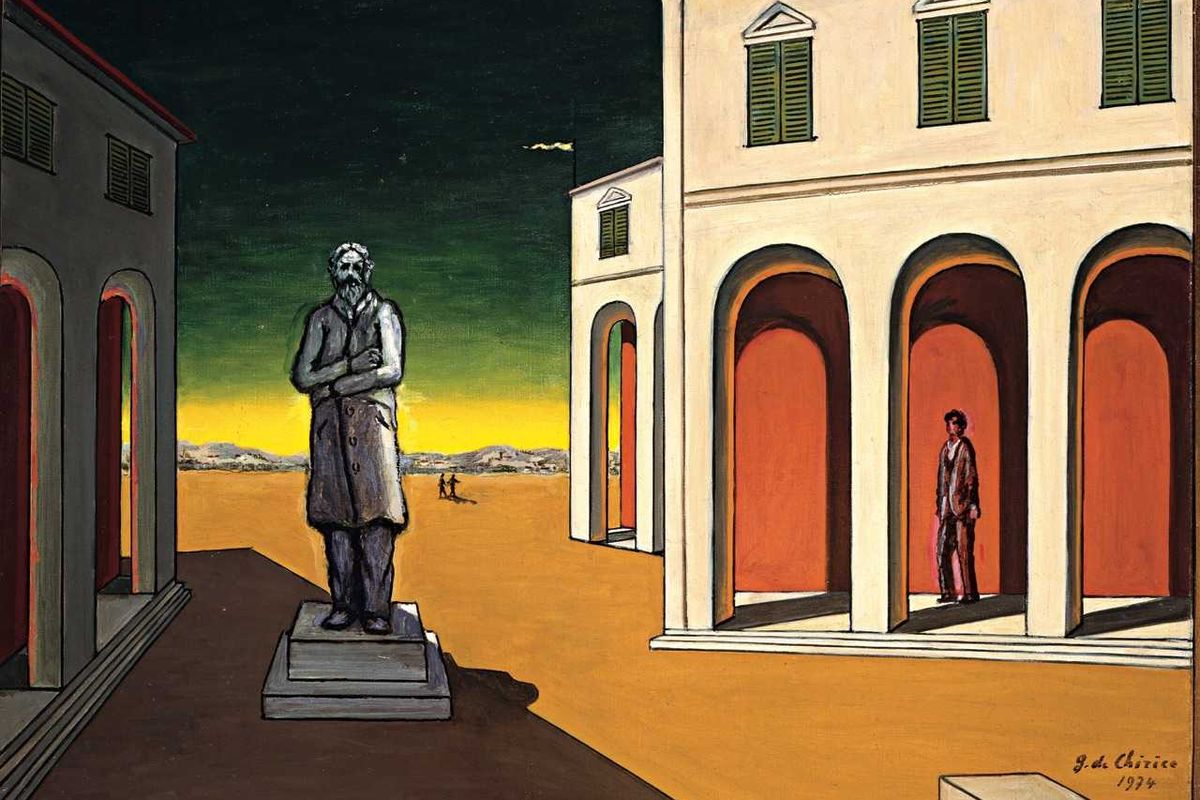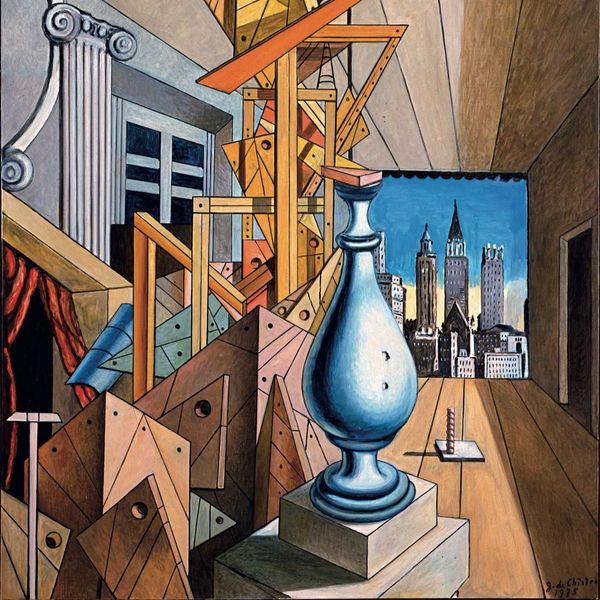I Simpson avevano previsto il Me too. Ma non un femminismo così ottuso

Se è vero, come si ama dire da qualche tempo, che i Simpson hanno previsto il futuro (un caso su tutti: nel 2000 una puntata immaginava Donald Trump presidente degli Stati Uniti con 17 anni di anticipo), il Me too non fa eccezione. Anche in questo caso, infatti, Homer e compagni ci erano arrivati prima. Peccato che la realtà si sia rivelata essere molto peggiore delle previsioni. Ma andiamo con ordine. Era il 27 novembre 1994 - esattamente trent’anni fa, quindi - quando sulla Fox andava in onda uno dei più iconici e discussi episodi dei Simpson. Si intitolava «Homer Badman». In Italia sarebbe arrivata il 7 luglio 1996, con il titolo «Homer l’acchiappone». Il Daily Telegraph lo ha inserito nei 10 migliori episodi televisivi del cartoon sulla famiglia gialla, mentre una vera e propria autorità della comicità anglosassone come Ricky Gervais ha dichiarato che si tratta della sua puntata preferita.
A tale notorietà ha certamente contribuito l’aspetto di forte satira sociale, ma è per l’appunto con lo scandalo sessuale relativo ad Harvey Weinstein che l’episodio ha conosciuto una seconda giovinezza. Partiamo dalla trama. Nella puntata, Homer e Marge vincono dei biglietti per una fiera sui dolciumi. Lasciano quindi i piccoli assieme a una babysitter, Ashley Grant, una studentessa impegnata. Al ritorno, accompagnando a casa la giovane, Homer la infastidisce con una serie di uscite fuori luogo: «Com’è che voi studiosi andate sulla Luna ma non riuscite a non far puzzare le mie scarpe?», o «Può prendere il volante un secondo? Mi devo grattare in due posti diversi contemporaneamente». Quando poi la studentessa, seccata, chiede di scendere, Homer nota che, sul sedere della giovane, si è appiccicata la Venere gommosa, la caramella più ambita della fiera. Il capofamiglia dei Simpson, trasfigurato dalla gola, stacca il dolcetto dalle terga della ragazza, che scambia l’operazione per una palpata di sedere. Il giorno dopo, Homer si trova un picchetto di femministe davanti casa. Il suo volto è sbattuto su tutti i programmi tv, che non esitano a ricorrere ai mezzi più biechi per avvalorare la tesi del disgustoso predatore sessuale, a costo di manipolare la realtà. Alla fine, tuttavia, un video amatoriale svela come sono andate realmente le cose e Homer riceve il perdono di Ashley.
Rivista dopo il ciclone Me too, in effetti la puntata sembra avere diversi aspetti di preveggenza. Il modo in cui i media cucinano Homer è da manuale. In una trasmissione, una donna in lacrime racconta, stravolta, di non aver mai incontrato Homer Simpson, ma la conduttrice taglia corto: «Non fa niente, le sue lacrime dicono molto di più di qualsiasi prova tangibile». È la perfetta incarnazione del «sorella ti credo», lo slogan neo femminista che, nei casi di presunta molestia, intende sostituire le confessioni unilaterali della vittima alla ricerca della verità. Ha scritto il Guardian: «Sebbene l’episodio faccia un ottimo lavoro nel mettere in questione una cultura mediatica ossessionata dagli ascolti più che dalla verità, “Homer Badman” dipinge anche un ritratto delle denunce per molestie sessuali come una pericolosa caccia alle streghe contro uomini innocenti, guidata da un gruppo di giovani eccessivamente politicizzati e da media ossessionati da notizie piccanti». Insomma, da qualunque lato la si guardi, si tratta di una puntata che permane attuale. Eppure, c’è qualcosa che gli sceneggiatori dei Simpson non avevano previsto, qualcosa su cui l’evoluzione del dibattito ha seguito un’altra strada, un peggioramento della razionalità collettiva che neanche gli illuminati creatori della fortunata serie americana avrebbero potuto prevedere. Se facessimo rivedere «Homer Badman» a un’attivista neo femminista di oggi, probabilmente non capirebbe il finale: perché quel maschio bianco (giallo, in realtà, ma nell’universo Simpson è la stessa cosa), di mezza età e della classe media, il marito tiranno di una moglie relegata fra le quattro mura che egli quotidianamente umilia, quel patriarca chiaramente impregnato di mascolinità tossica alla fine viene assolto? In compagnia della babysitter, Homer dice una serie di cose non appropriate, prima mettendo in discussione con argomenti dozzinali il suo status di studiosa (qualcuno ha detto mansplaining?), poi mettendola in imbarazzo con la notazione corporea sul «doversi grattare in due posti diversi contemporaneamente». Infine, quando recupera la caramella dal sedere della giovane, invade chiaramente la sua sfera intima. Il fatto che egli non avesse alcuna intenzione di tipo sessuale era giudicato dirimente nel 1994, mentre oggi sarebbe poco più di un dettaglio. Trent’anni fa c’erano già media che manipolavano la verità, ma almeno restava l’idea di fondo condivisa che la verità comunque esistesse. C’erano le molestie e c’era la cafonaggine. Erano due sfere nettamente separate. E un’accusa falsa poteva comunque essere ribaltata portando le prove. Ora, il portato specifico del Me too è proprio questo: far saltare i confini tra le situazioni, le pratiche, i discorsi. Non esiste più la prova che una molestia sia stata o non sia stata commessa, perché nel frattempo la molestia si è trasformata in una mera percezione soggettiva. Con gli occhi di oggi, Ashley è stata molestata davvero.
Lo dimostra anche l’ultima campagna contro la violenza sulle donne, quella che prende una serie di frasi decontestualizzate, in alcuni casi apparentemente innocue, e le riconduce tutte alla violenza. Non fatichiamo a immaginare uno di quei manifesti con la frase «Può prendere il volante un secondo? Mi devo grattare in due posti diversi contemporaneamente». E la chiosa: «Se te lo dice, è violenza».