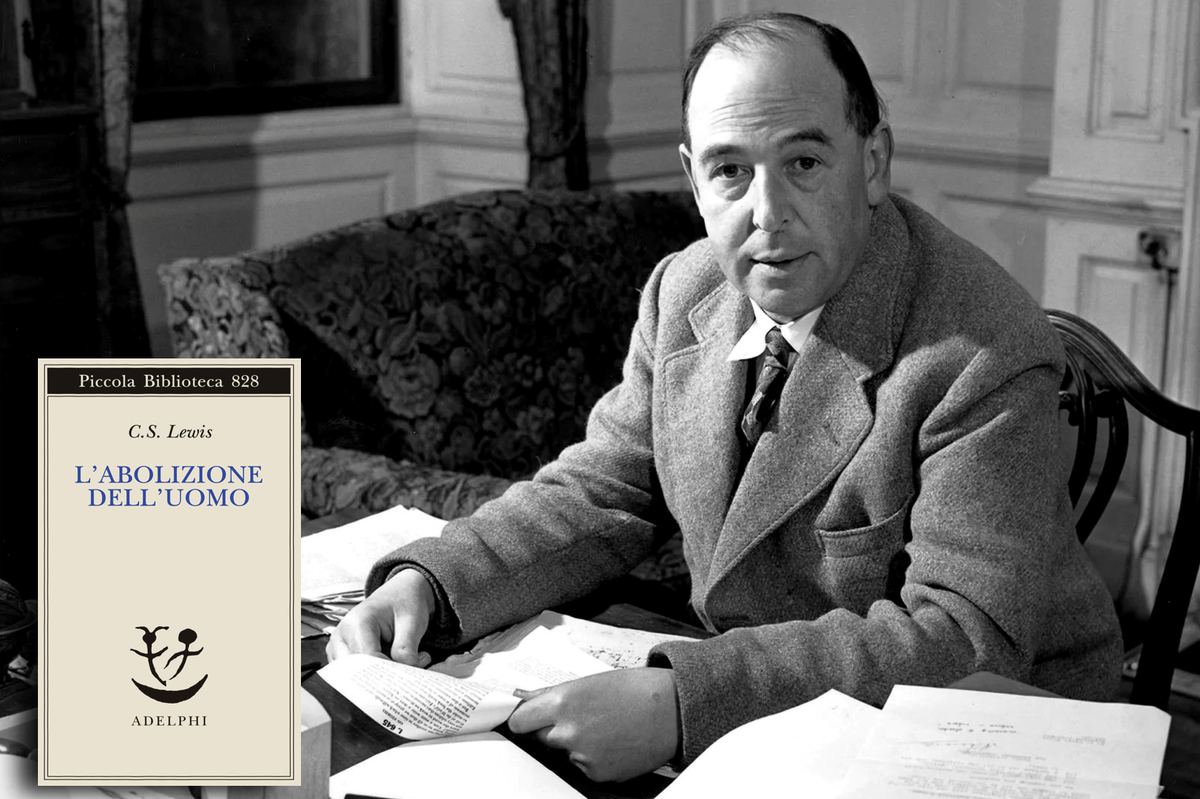True
2024-04-06
«Sfruttava il lavoro»: indagini sulla Armani
Giorgio Armani (Ansa)
Le borse di pelle firmate Giorgio Armani si vendono ad almeno 1.800 euro (se non di più) nelle boutique dello stilista in tutto il mondo. Produrle però costa, secondo la Procura di Milano, appena 75 euro senza Iva (con cui si arriva a 93), grazie al lavoro della manovalanza cinese costretta «a turni di lavoro massacrante» anche di notte, superiori a 14 ore al giorno e con una paga talvolta di appena un euro a pezzo. È il quadro che emerge secondo le accuse del decreto della sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano che ha messo in «amministrazione giudiziaria» la Giorgio Armani operations spa rispetto ai rapporti con i fornitori. In pratica, all’azienda del noto stilista italiano (che non risulta indagato) viene contestato di non aver controllato il caporalato sulla manodopera straniera irregolare del suo fornitore ufficiale italiano, ovvero Manifatture lombarde, che a sua volta subappaltava la realizzazione di borse e accessori del gruppo Giorgio Armani a opifici cinesi. Per questo motivo verrà affiancata nei prossimi mesi da un amministratore, il commercialista e revisore Piero Antonio Capitini. In questo modo, si legge nel decreto, il tribunale si auspica di «far cessare questa situazione, in un’ottica di interventi proporzionali […] È una moderna messa alla prova aziendale finalizzata ad affrancare l’impresa da relazioni (interne ed esterne) patologiche».
Secondo l’accusa, la Giorgio Armani avrebbe «colposamente alimentato» questo meccanismo perché non avrebbe mai verificato «la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici, alle quali affidare la produzione». Siamo nell’area delle misure di prevenzione, il provvedimento non è ancora penale. Ma di certo per i pm di Milano il quadro è a tinte fosche. Secondo gli inquirenti (i pm Paolo Storari e Luisa Baima Bollone affiancati dei carabinieri) infatti, «nella Giorgio Armani operation spa vi è una cultura di impresa gravemente deficitaria sotto il profilo del controllo, anche minimo, della filiera produttiva della quale la società si avvale; cultura radicata all’interno della struttura della persona giuridica, che ha di fatto favorito la perpetuazione degli illeciti». Si legge nel decreto: «Nel corso delle indagini, infatti, si è disvelata una prassi illecita così radicata e collaudata, da poter essere considerata inserita in una più ampia politica d’impresa diretta all'aumento del business. Le condotte investigate non paiono frutto di iniziative estemporanee e isolate di singoli, ma di una illecita politica di impresa». È dal 2015 che vanno avanti le indagini del nucleo ispettorato del lavoro del comando dei carabinieri di Milano. A gennaio era stata l’Alviero Martini a finire sempre commissariata dal tribunale milanese. Anche in questo caso l’azienda specializzata in borse e accessori con le carte geografiche era stata «ritenuta incapace di prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo». Sarebbe una pratica comune nel mondo della moda con i grandi marchi che affidano, mediante contratti di appalto, l’intera produzione a società terze. A sua volta l’azienda appaltatrice dispone soltanto nominalmente di adeguata capacità produttiva, potendo di fatto provvedere alla sola campionatura del materiale e non alla produzione dell’intera linea. Queste realtà possono competere sul mercato solo esternalizzando le commesse a opifici cinesi, riuscendo ad abbattere i costi grazie a manodopera irregolare. A sua volta chi coordina i laboratori recluta connazionali in difficoltà.
Z.Y., uno dei lavoratori cinesi delle aziende sotto indagine, ha raccontato agli inquirenti di aver negli anni assemblato «cinture di marchi come Zara, Diesel, Hugo Boss, Hugo Boss orange che è la prima linea della Hugo Boss, Trussardi, Versace, Emporio Armani, che è la prima linea dell’Armani, Alviero Martini, Tommy Hilfygher, Gucci, Gianfranco Ferré, Dolce&Gabbana, Marlboro e Marlboro classic; Replay, Levi’s e tanti altri che al momento mi sfuggono». I lavoratori sarebbero stati spesso cinesi irregolari, con generalità intercambiabili tra loro. Sarebbero stati costretti a mangiare in qualche angolo del capannone, con reperibilità e disponibilità per tutte le 24 ore della giornata. Nessuno sarebbe mai stato sottoposto a visita medica. Alcuni macchinari sarebbero stati senza le misure di prevenzione per aumentare la velocità di produzione. Un’altra lavoratrice, A.E., ha dichiarato che «seppur assunta formalmente per 4 ore giornaliere, in realtà lavora per 10 ore giornaliere dal lunedì al sabato».
Non solo. L’azienda non avrebbe fornito ai lavoratori nemmeno i dispositivi per evitare il contatto con agenti chimici pericolosi come colla e solventi. La paga sarebbe andata dai 3 ai 4 euro l’ora. Anche se c’è chi ha dichiarato di lavorare a cottimo per l’azienda Minoronzoni, con una paga da mezzo euro a 1 euro a pezzo per un lavoro che poteva durare anche quattro ore. Per esempio, quest’ultima azienda appaltatrice sotto inchiesta ha i contratti per le cinture di marchi d’alta moda. E rimette direttamente la fattura agli stessi marchi come se la merce fosse stata prodotta e assemblata da lei. Z. Y. ha raccontato che l’azienda «paga più o meno 60 centesimi costo di manifattura e confezionamento. Poi la Minoronzoni rimette poi il prodotto con apposita fattura ai loro committenti, Guess, Versace o Armani con ricarico di materiale prodotto, manodopera confezionamento e trasporto per circa 15 euro a cintura. E non può far risultare che l’assemblaggio e il confezionamento siano stati fatti da altre aziende». Durante un’ispezione i lavoratori sarebbero stati perfino costretti a nascondersi al buio durante un controllo qualità. Queste cinture arrivano a costare anche 500 euro.
«Apprendiamo della misura di prevenzione decisa dai Tribunali di Milano nei confronti della GA operations», si legge in una nota dell’azienda. «La società ha da sempre in atto misure di controllo e di prevenzione atte a minimizzare abusi nella catena di fornitura. La GA operations collaborerà con la massima trasparenza con gli organi competenti per chiarire la propria posizione rispetto alla vicenda».
L’impero e la successione blindata. Ma l’inchiesta può scombinare i piani
Vedremo quali saranno i risvolti della bufera che si è abbattuta sul gruppo Armani. Di certo, dal punto di vista dell’immagine il colpo è pesante. Classe 1934, Re Giorgio ha costruito un impero economico che conta 9.000 dipendenti, 2,35 miliardi di fatturato e 162 milioni di utile. Il problema è che non ha eredi diretti e la successione è ancora un segreto custodito in famiglia. Le conseguenze dell’inchiesta avviata dalla Procura di Milano avranno un impatto anche su una possibile futura vendita e, nel caso, sul prezzo del passaggio di mano o di un’eventuale quotazione in Borsa? Sin qui lo stilista ha sempre respinto i corteggiamenti, soprattutto quello del gigante francese Lvmh di Bernard Arnault. Intervistato l’anno scorso dal Financial Times nei corridoi del suo show veneziano, lo stilista aveva ribadito di non voler vendere il proprio marchio. «Questi gruppi francesi vogliono prendersi tutto, non lo capisco, lo trovo un po’ ridicolo, perché dovrei essere dominato da una di queste mega strutture che mancano di personalità?». Nel 2017 Armani aveva detto in un’altra intervista sempre all’Ft che per la successione del suo impero «era tutto pronto». Lo scorso ottobre il Corriere della Sera ha rivelato il contenuto di un documento, approvato in un’assemblea straordinaria del 2016, integrato a settembre e rimasto fino a quel momento riservato. È lo statuto della futura Giorgio Armani spa che governerà il gruppo, all’insegna della continuità, quando il Re non ci sarà più. Sarà una società con la porta aperta sulla Borsa, darà «priorità allo sviluppo continuo a livello globale del nome Armani», avrà «sei categorie di azionisti nel capitale, tutti uguali davanti al dividendo» (solo «il 50% degli utili netti verrà ripartito») ma alcuni avranno il triplo dei voti e il diritto a nominare l’amministratore delegato. Lo statuto sarà formalmente adottato all’apertura della successione di Armani, che possiede il 99,9% del gruppo mentre lo 0,1% fa capo alla Fondazione Giorgio Armani. Lo stilista ha tre nipoti: Silvana e Roberta, figlie del fratello Sergio scomparso anni fa, e il figlio della sorella Rosanna, Andrea Camerana, tutti già in cda. Gli eredi dovrebbero includere la sorella, altri tre membri della famiglia che lavorano nell’azienda, il collaboratore di lunga data Pantaleo Dell’Orco e una fondazione (anche il fondatore di Rolex, Hans Wilsdorf, nel 1960 lasciò il marchio a una fondazione che tuttora possiede l’azienda di orologi di lusso). Lo statuto divide il capitale azionario della società in sei categorie con diversi diritti di voto e poteri, ed è stato modificato a settembre per creare due categorie senza diritto di voto. Nel documento ci sono anche altre indicazioni: un’eventuale quotazione in Borsa richiede il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti in cda «decorso il quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente statuto». Qualsiasi attività di M&A (ossia fusione o acquisizione di altre aziende) dovrà avvenire con «approccio prudente» e «finalizzato unicamente a sviluppare competenze che non esistono internamente dal punto di vista del mercato, del prodotto o del canale». Lo statuto della fondazione prevede inoltre che si gestisca la partecipazione al gruppo con l’obiettivo di creare valore, mantenere i livelli occupazionali e perseguire i valori aziendali.Prima di Giorgio Armani, non c’era un’industria di moda italiana, c’era solo un’industria di fabbriche italiane. Oggi, mentre Valentino, Gucci e Versace sono stati tutti venduti a investitori stranieri, Armani rimane il solo proprietario della ditta che porta il suo nome. Prada, Zegna e Ferragamo sono le poche altre case di moda italiane rimaste indipendenti. In mani straniere, soprattutto francesi, sono già finiti i grandi marchi del made in Italy: Lvmh possiede Bulgari, Fendi, Emilio Pucci e Loro Piana, mentre Kering, il colosso di François-Henri Pinault, in meno di 30 anni ha accumulato brand come Gucci, Bottega Veneta, Brioni, Pomellato e pure il 30% di Valentino acquistato dal fondo qatariota Mayhoola. La conglomerata americana Tapestry-Capri holdings è invece proprietaria di Versace, Coccinelle è stata comprata dal gruppo coreano E-land nel 2012, che aveva precedentemente acquisito Mandarina duck in un periodo di difficoltà. Krizia è passata sotto il controllo della cinese Shenzhen marisfrolg fashion nel 2014, mentre nel 2021 Fosun ha acquistato le calzature Sergio Rossi per 60 milioni. Il comparto della moda italiano, secondo l’ultimo rapporto dell’ufficio studi di Mediobanca dedicato al settore, chiuderà il 2023 con un aumento del fatturato del 6% rispetto agli 85,9 miliardi di un 2022 a doppia cifra (+19,1%). La crescita rallenterà ulteriormente quest’anno, con i ricavi aggregati delle 175 aziende italiane con un giro d’affari superiore ai 100 milioni che dovrebbe salire del 3%, a ridosso dei 94 miliardi. Tra i 37 gruppi europei, l’Italia con i suoi 12 big è il Paese con più protagonisti, ma è la Francia ad aggiudicarsi il primato per giro d’affari (43% del totale europeo), davanti a Germania (11%), Spagna e Regno Unito (10% entrambi), con l’Italia al 7%. E al primo posto per ricavi tra i colossi mondiali si conferma Lvmh (79,2 miliardi), davanti a Nike (48 miliardi), Inditex (32,6 miliardi) ed Essilorluxottica (24,5 miliardi). Prima tra gli italiani si posiziona Prada (4,2 miliardi), al 33° posto in classifica, seguita da Oniverse (44°), Moncler (50°) e Giorgio Armani (54°).
Continua a leggereRiduci
Per i pm la società, non indagata, coi subappalti favoriva il caporalato cinese. «Pagati 3 euro l’ora. Borse prodotte a 93 euro e vendute a 1.800». Lo stilista, che sta per compiere 90 anni, ha sempre rifiutato di vendere ai francesi e ha disegnato il futuro del marchio per farlo restare in mani italiane. Ora però potrebbe entrare in gioco l’onda lunga dello scandalo. Lo speciale contiene due articoli.Le borse di pelle firmate Giorgio Armani si vendono ad almeno 1.800 euro (se non di più) nelle boutique dello stilista in tutto il mondo. Produrle però costa, secondo la Procura di Milano, appena 75 euro senza Iva (con cui si arriva a 93), grazie al lavoro della manovalanza cinese costretta «a turni di lavoro massacrante» anche di notte, superiori a 14 ore al giorno e con una paga talvolta di appena un euro a pezzo. È il quadro che emerge secondo le accuse del decreto della sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano che ha messo in «amministrazione giudiziaria» la Giorgio Armani operations spa rispetto ai rapporti con i fornitori. In pratica, all’azienda del noto stilista italiano (che non risulta indagato) viene contestato di non aver controllato il caporalato sulla manodopera straniera irregolare del suo fornitore ufficiale italiano, ovvero Manifatture lombarde, che a sua volta subappaltava la realizzazione di borse e accessori del gruppo Giorgio Armani a opifici cinesi. Per questo motivo verrà affiancata nei prossimi mesi da un amministratore, il commercialista e revisore Piero Antonio Capitini. In questo modo, si legge nel decreto, il tribunale si auspica di «far cessare questa situazione, in un’ottica di interventi proporzionali […] È una moderna messa alla prova aziendale finalizzata ad affrancare l’impresa da relazioni (interne ed esterne) patologiche». Secondo l’accusa, la Giorgio Armani avrebbe «colposamente alimentato» questo meccanismo perché non avrebbe mai verificato «la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici, alle quali affidare la produzione». Siamo nell’area delle misure di prevenzione, il provvedimento non è ancora penale. Ma di certo per i pm di Milano il quadro è a tinte fosche. Secondo gli inquirenti (i pm Paolo Storari e Luisa Baima Bollone affiancati dei carabinieri) infatti, «nella Giorgio Armani operation spa vi è una cultura di impresa gravemente deficitaria sotto il profilo del controllo, anche minimo, della filiera produttiva della quale la società si avvale; cultura radicata all’interno della struttura della persona giuridica, che ha di fatto favorito la perpetuazione degli illeciti». Si legge nel decreto: «Nel corso delle indagini, infatti, si è disvelata una prassi illecita così radicata e collaudata, da poter essere considerata inserita in una più ampia politica d’impresa diretta all'aumento del business. Le condotte investigate non paiono frutto di iniziative estemporanee e isolate di singoli, ma di una illecita politica di impresa». È dal 2015 che vanno avanti le indagini del nucleo ispettorato del lavoro del comando dei carabinieri di Milano. A gennaio era stata l’Alviero Martini a finire sempre commissariata dal tribunale milanese. Anche in questo caso l’azienda specializzata in borse e accessori con le carte geografiche era stata «ritenuta incapace di prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo». Sarebbe una pratica comune nel mondo della moda con i grandi marchi che affidano, mediante contratti di appalto, l’intera produzione a società terze. A sua volta l’azienda appaltatrice dispone soltanto nominalmente di adeguata capacità produttiva, potendo di fatto provvedere alla sola campionatura del materiale e non alla produzione dell’intera linea. Queste realtà possono competere sul mercato solo esternalizzando le commesse a opifici cinesi, riuscendo ad abbattere i costi grazie a manodopera irregolare. A sua volta chi coordina i laboratori recluta connazionali in difficoltà. Z.Y., uno dei lavoratori cinesi delle aziende sotto indagine, ha raccontato agli inquirenti di aver negli anni assemblato «cinture di marchi come Zara, Diesel, Hugo Boss, Hugo Boss orange che è la prima linea della Hugo Boss, Trussardi, Versace, Emporio Armani, che è la prima linea dell’Armani, Alviero Martini, Tommy Hilfygher, Gucci, Gianfranco Ferré, Dolce&Gabbana, Marlboro e Marlboro classic; Replay, Levi’s e tanti altri che al momento mi sfuggono». I lavoratori sarebbero stati spesso cinesi irregolari, con generalità intercambiabili tra loro. Sarebbero stati costretti a mangiare in qualche angolo del capannone, con reperibilità e disponibilità per tutte le 24 ore della giornata. Nessuno sarebbe mai stato sottoposto a visita medica. Alcuni macchinari sarebbero stati senza le misure di prevenzione per aumentare la velocità di produzione. Un’altra lavoratrice, A.E., ha dichiarato che «seppur assunta formalmente per 4 ore giornaliere, in realtà lavora per 10 ore giornaliere dal lunedì al sabato».Non solo. L’azienda non avrebbe fornito ai lavoratori nemmeno i dispositivi per evitare il contatto con agenti chimici pericolosi come colla e solventi. La paga sarebbe andata dai 3 ai 4 euro l’ora. Anche se c’è chi ha dichiarato di lavorare a cottimo per l’azienda Minoronzoni, con una paga da mezzo euro a 1 euro a pezzo per un lavoro che poteva durare anche quattro ore. Per esempio, quest’ultima azienda appaltatrice sotto inchiesta ha i contratti per le cinture di marchi d’alta moda. E rimette direttamente la fattura agli stessi marchi come se la merce fosse stata prodotta e assemblata da lei. Z. Y. ha raccontato che l’azienda «paga più o meno 60 centesimi costo di manifattura e confezionamento. Poi la Minoronzoni rimette poi il prodotto con apposita fattura ai loro committenti, Guess, Versace o Armani con ricarico di materiale prodotto, manodopera confezionamento e trasporto per circa 15 euro a cintura. E non può far risultare che l’assemblaggio e il confezionamento siano stati fatti da altre aziende». Durante un’ispezione i lavoratori sarebbero stati perfino costretti a nascondersi al buio durante un controllo qualità. Queste cinture arrivano a costare anche 500 euro. «Apprendiamo della misura di prevenzione decisa dai Tribunali di Milano nei confronti della GA operations», si legge in una nota dell’azienda. «La società ha da sempre in atto misure di controllo e di prevenzione atte a minimizzare abusi nella catena di fornitura. La GA operations collaborerà con la massima trasparenza con gli organi competenti per chiarire la propria posizione rispetto alla vicenda».<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/sfruttava-lavoro-indagini-sulla-armani-2667707262.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="limpero-e-la-successione-blindata-ma-linchiesta-puo-scombinare-i-piani" data-post-id="2667707262" data-published-at="1712384636" data-use-pagination="False"> L’impero e la successione blindata. Ma l’inchiesta può scombinare i piani Vedremo quali saranno i risvolti della bufera che si è abbattuta sul gruppo Armani. Di certo, dal punto di vista dell’immagine il colpo è pesante. Classe 1934, Re Giorgio ha costruito un impero economico che conta 9.000 dipendenti, 2,35 miliardi di fatturato e 162 milioni di utile. Il problema è che non ha eredi diretti e la successione è ancora un segreto custodito in famiglia. Le conseguenze dell’inchiesta avviata dalla Procura di Milano avranno un impatto anche su una possibile futura vendita e, nel caso, sul prezzo del passaggio di mano o di un’eventuale quotazione in Borsa? Sin qui lo stilista ha sempre respinto i corteggiamenti, soprattutto quello del gigante francese Lvmh di Bernard Arnault. Intervistato l’anno scorso dal Financial Times nei corridoi del suo show veneziano, lo stilista aveva ribadito di non voler vendere il proprio marchio. «Questi gruppi francesi vogliono prendersi tutto, non lo capisco, lo trovo un po’ ridicolo, perché dovrei essere dominato da una di queste mega strutture che mancano di personalità?». Nel 2017 Armani aveva detto in un’altra intervista sempre all’Ft che per la successione del suo impero «era tutto pronto». Lo scorso ottobre il Corriere della Sera ha rivelato il contenuto di un documento, approvato in un’assemblea straordinaria del 2016, integrato a settembre e rimasto fino a quel momento riservato. È lo statuto della futura Giorgio Armani spa che governerà il gruppo, all’insegna della continuità, quando il Re non ci sarà più. Sarà una società con la porta aperta sulla Borsa, darà «priorità allo sviluppo continuo a livello globale del nome Armani», avrà «sei categorie di azionisti nel capitale, tutti uguali davanti al dividendo» (solo «il 50% degli utili netti verrà ripartito») ma alcuni avranno il triplo dei voti e il diritto a nominare l’amministratore delegato. Lo statuto sarà formalmente adottato all’apertura della successione di Armani, che possiede il 99,9% del gruppo mentre lo 0,1% fa capo alla Fondazione Giorgio Armani. Lo stilista ha tre nipoti: Silvana e Roberta, figlie del fratello Sergio scomparso anni fa, e il figlio della sorella Rosanna, Andrea Camerana, tutti già in cda. Gli eredi dovrebbero includere la sorella, altri tre membri della famiglia che lavorano nell’azienda, il collaboratore di lunga data Pantaleo Dell’Orco e una fondazione (anche il fondatore di Rolex, Hans Wilsdorf, nel 1960 lasciò il marchio a una fondazione che tuttora possiede l’azienda di orologi di lusso). Lo statuto divide il capitale azionario della società in sei categorie con diversi diritti di voto e poteri, ed è stato modificato a settembre per creare due categorie senza diritto di voto. Nel documento ci sono anche altre indicazioni: un’eventuale quotazione in Borsa richiede il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti in cda «decorso il quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente statuto». Qualsiasi attività di M&A (ossia fusione o acquisizione di altre aziende) dovrà avvenire con «approccio prudente» e «finalizzato unicamente a sviluppare competenze che non esistono internamente dal punto di vista del mercato, del prodotto o del canale». Lo statuto della fondazione prevede inoltre che si gestisca la partecipazione al gruppo con l’obiettivo di creare valore, mantenere i livelli occupazionali e perseguire i valori aziendali.Prima di Giorgio Armani, non c’era un’industria di moda italiana, c’era solo un’industria di fabbriche italiane. Oggi, mentre Valentino, Gucci e Versace sono stati tutti venduti a investitori stranieri, Armani rimane il solo proprietario della ditta che porta il suo nome. Prada, Zegna e Ferragamo sono le poche altre case di moda italiane rimaste indipendenti. In mani straniere, soprattutto francesi, sono già finiti i grandi marchi del made in Italy: Lvmh possiede Bulgari, Fendi, Emilio Pucci e Loro Piana, mentre Kering, il colosso di François-Henri Pinault, in meno di 30 anni ha accumulato brand come Gucci, Bottega Veneta, Brioni, Pomellato e pure il 30% di Valentino acquistato dal fondo qatariota Mayhoola. La conglomerata americana Tapestry-Capri holdings è invece proprietaria di Versace, Coccinelle è stata comprata dal gruppo coreano E-land nel 2012, che aveva precedentemente acquisito Mandarina duck in un periodo di difficoltà. Krizia è passata sotto il controllo della cinese Shenzhen marisfrolg fashion nel 2014, mentre nel 2021 Fosun ha acquistato le calzature Sergio Rossi per 60 milioni. Il comparto della moda italiano, secondo l’ultimo rapporto dell’ufficio studi di Mediobanca dedicato al settore, chiuderà il 2023 con un aumento del fatturato del 6% rispetto agli 85,9 miliardi di un 2022 a doppia cifra (+19,1%). La crescita rallenterà ulteriormente quest’anno, con i ricavi aggregati delle 175 aziende italiane con un giro d’affari superiore ai 100 milioni che dovrebbe salire del 3%, a ridosso dei 94 miliardi. Tra i 37 gruppi europei, l’Italia con i suoi 12 big è il Paese con più protagonisti, ma è la Francia ad aggiudicarsi il primato per giro d’affari (43% del totale europeo), davanti a Germania (11%), Spagna e Regno Unito (10% entrambi), con l’Italia al 7%. E al primo posto per ricavi tra i colossi mondiali si conferma Lvmh (79,2 miliardi), davanti a Nike (48 miliardi), Inditex (32,6 miliardi) ed Essilorluxottica (24,5 miliardi). Prima tra gli italiani si posiziona Prada (4,2 miliardi), al 33° posto in classifica, seguita da Oniverse (44°), Moncler (50°) e Giorgio Armani (54°).
(Arma dei Carabinieri)
Il sequestro è avvenuto nel territorio del Comune di Caraffa del Bianco, in provincia di Reggio Calabria, in un’area particolarmente isolata e difficilmente accessibile.
L’ operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata ed è stata resa possibile grazie all’apporto altamente specialistico dei militari dello Squadrone Eliportato «Cacciatori di Calabria», reparto d’élite dell’Arma dei Carabinieri specializzato nelle attività di ricerca in ambienti difficilmente accessibili. Proprio durante una perlustrazione accurata del territorio, i militari hanno individuato un fusto in plastica nascosto tra le pietre di un muro di contenimento, molto bene mimetizzato per sfuggire a eventuali controlli.
All’interno del contenitore è stato trovato un vero e proprio arsenale: un fucile d’assalto tipo Kalashnikov, completo di caricatore e munizioni calibro 7.62 x 39, un fucile semiautomatico calibro 12 con matricola abrasa, una doppietta dello stesso calibro, tre bombe anticarro di tipo M-60 e altri tre razzi anticarro. Un quantitativo e una tipologia di armi che fanno presumere una destinazione ad attività criminali di elevata pericolosità.
Considerata l’estrema minaccia alla sicurezza rappresentata dall'esplosivo rinvenuto, i Carabinieri hanno immediatamente richiesto l’intervento degli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale di Reggio Calabria. L’area è stata prontamente isolata e messa in sicurezza attraverso un’accurata cinturazione per tutelare l’incolumità degli operatori e prevenire rischi per la popolazione. In seguito, gli ordigni sono stati fatti brillare sul posto secondo le procedure previste. L’intervento degli specialisti è durato diverse ore, a conferma della complessità e delicatezza delle operazioni.
Le attività di controllo non si sono fermate al primo ritrovamento. Nel proseguimento delle perlustrazioni, i militari dell’Arma hanno esteso le ricerche anche a strutture rurali e fabbricati dismessi della zona. All’interno di un casolare abbandonato sono stati così ritrovati altri quattro fucili e una pistola Smith & Wesson, assieme a diverse munizioni di vario calibro poste sotto sequestro con il resto delle armi.
Il consistente sequestro ha consentito di sottrarre alla disponibilità della criminalità un ingente quantitativo di armi e materiale esplodente, che avrebbe potuto essere impiegato per compiere gravi fatti di sangue o azioni intimidatorie.
L’operazione rappresenta un ulteriore segnale della costante presenza dell’Arma dei Carabinieri sul territorio, capace di intervenire con prontezza anche in contesti operativi complessi.
Continua a leggereRiduci