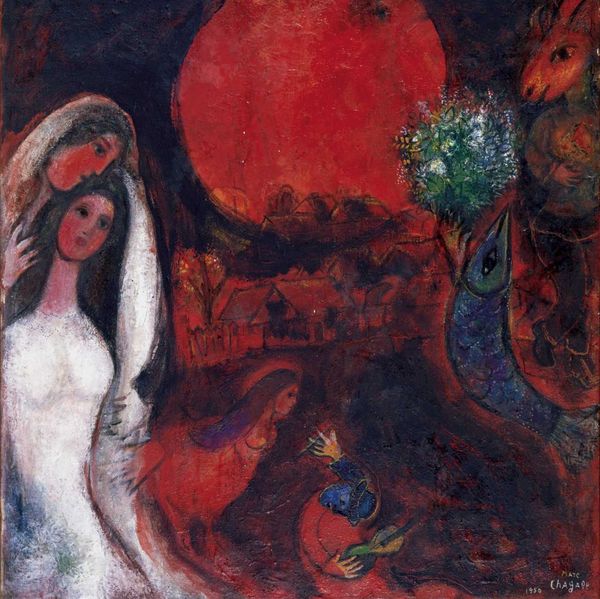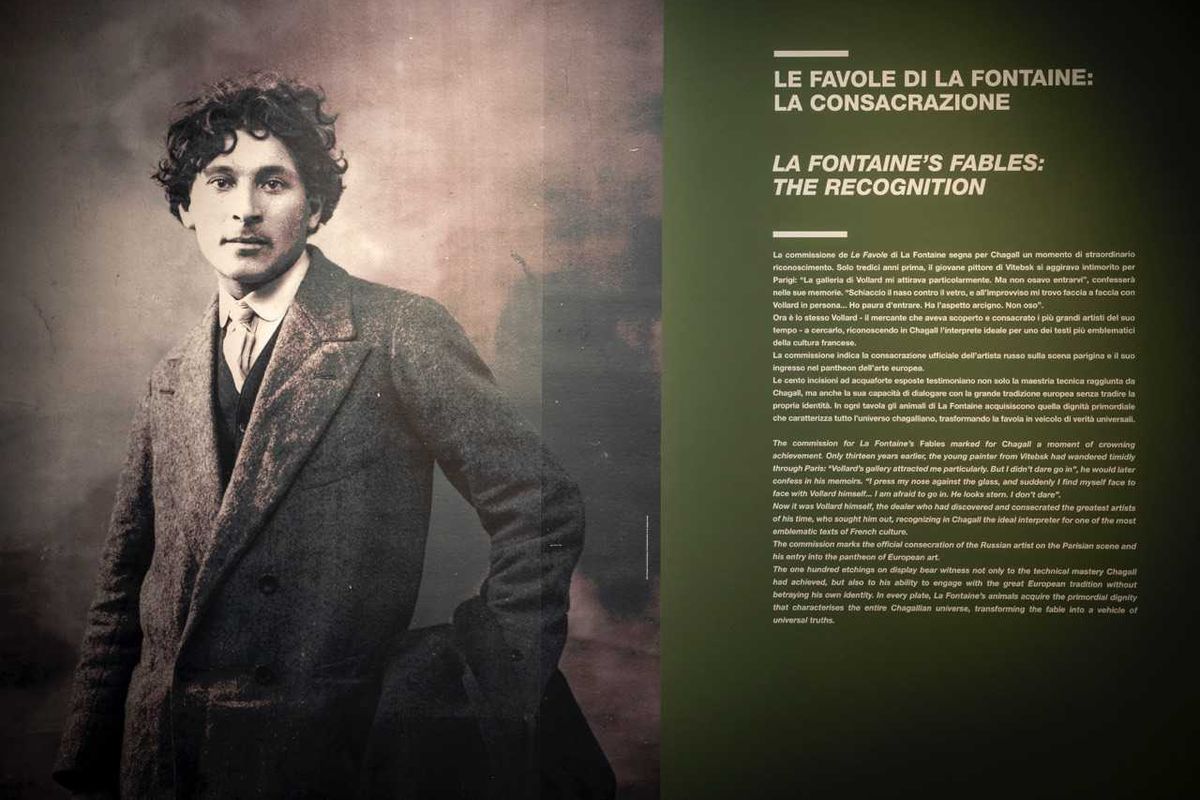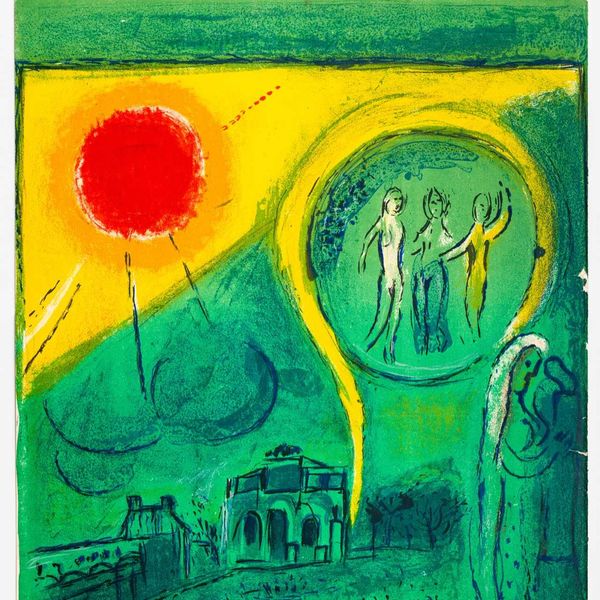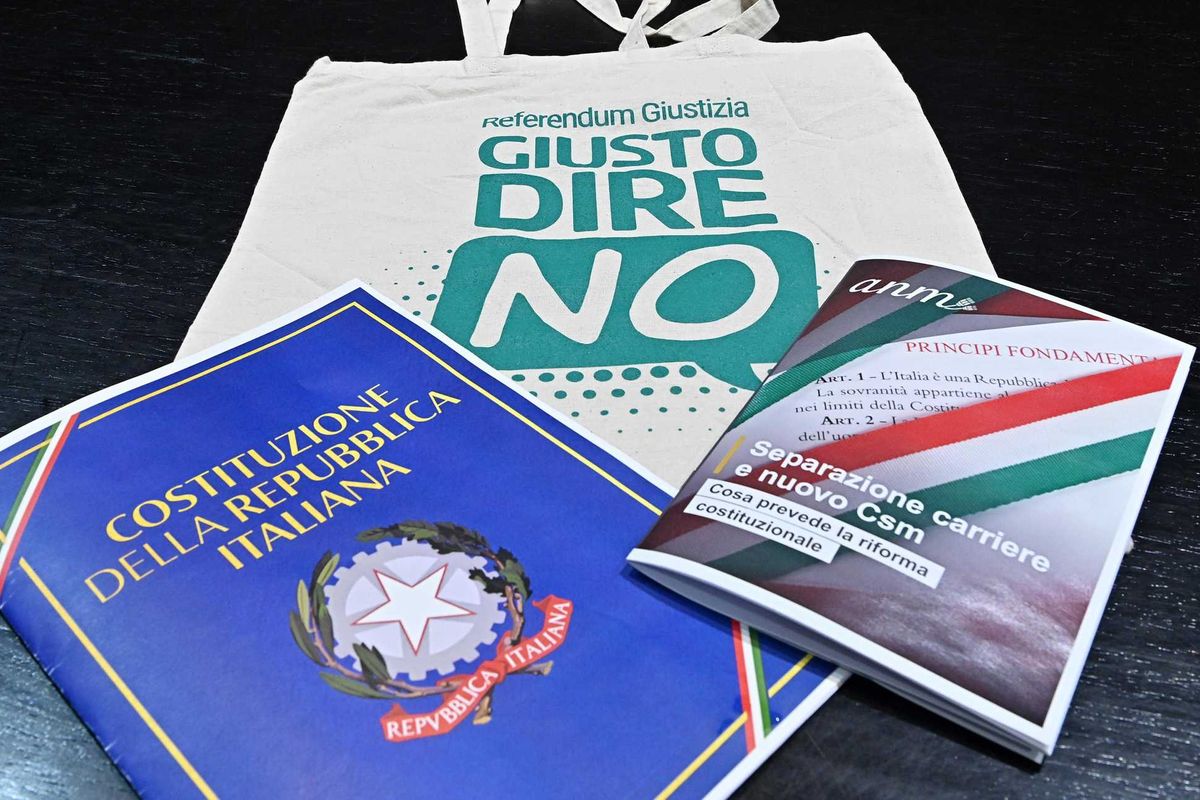Questa è la storia di un ragazzo che voleva a tutti i costi fare lo sceneggiatore, ma i produttori che tentava di incontrare si negavano sempre. Allora scrisse un cortometraggio su questa sua esperienza e lo realizzò con un amico, cominciando così la sua scalata nel mondo del cinema. Oggi quel ragazzo, Nicola Guaglianone, è lo sceneggiatore più ricercato dai produttori italiani e il suo nuovo film, Freaks Out, diretto da quel suo amico di gioventù, Gabriele Mainetti, è uno dei più attesi di questa sfortunata stagione cinematografica.
Qual è stato il suo primo approccio al mondo del cinema?
«La prima volta che ho visto un set è stato sotto casa mia: stavano girando un film di Sergio Corbucci, A tu per tu, con Johnny Dorelli e Paolo Villaggio. Ero un ragazzino e ho visto questo grande circo Barnum che si metteva in moto e trasformava i sogni in immagini. Poi, durante il primo anno di università, ho saputo che lo sceneggiatore Leo Benvenuti teneva un seminario all'Anac, l'Associazione nazionale autori cinematografici. L'ho scoperto per caso, su un'agenda che ho comprato a Porta Portese. Il corso era come la bottega di un artigiano fiorentino del Cinquecento: Leo leggeva tutti i lavori dei partecipanti al corso. Ho scritto un cortometraggio, Leo ne ha parlato davanti a tutti e mi ha fatto capire che potevo fare questo lavoro. Poi con Gabriele Mainetti siamo riusciti a realizzare questa storia: è stato il primo corto che abbiamo fatto assieme. Si chiamava Il produttore».
A chi si era ispirato per questo cortometraggio?
«Era ispirato a tutti quei produttori che, quando li chiamavi, non ti rispondevano mai, stavano sempre in riunione o in qualche festival. Raccontava la storia di due ragazzi, un regista e uno sceneggiatore, che facevano di tutto per riuscire a raccontare l'idea del loro film a questa figura mitologica».
Come ha conosciuto Mainetti?
«Avevamo un amico comune, Giorgio Melidoni, con il quale lavoravo al Piper il sabato pomeriggio: “Tu vuoi fare lo sceneggiatore, lui vuole fare il regista: perché non vi incontrate?". Ci siamo visti per la prima volta a viale Parioli, mi ricordo che Gabriele aveva un cappotto blu lungo fino ai piedi. Era un ragazzino pieno di passione, con un fuoco dentro: non riusciva a stare fermo, gesticolava, ti toccava, raccontava storie, faceva delle voci, cambiava la faccia, una sorta di Jim Carrey. Infatti ha cominciato come attore. Siamo diventati amici e piano piano abbiamo cominciato a fare insieme dei cortometraggi, l'ultimo dei quali, Tiger Boy, ha vinto molti premi ed è arrivato persino in short lista agli Oscar».
È arrivato quindi il momento di passare al lungometraggio.
«Ho detto a Gabriele: “Che film vuoi fare? Un film con le pistole o con i sentimenti?" e lui: “Con le pistole". Ho chiamato Menotti (nome vero Roberto Marchionni, ndr), mi ero trovato bene a lavorare con lui perché a entrambi piace studiare la struttura narrativa e la trasformazione del personaggio: per noi è come un'equazione da risolvere».
Poi avete scritto un film, Lo chiamavano Jeeg Robot, sia con le pistole che con i sentimenti!
«Diciamo un film con i sentimenti a mano armata perché di fatto, Jeeg Robot, è una storia d'amore. Grazie all'amore di Alessia il protagonista Enzo Ceccotti riesce a salvare la vita degli altri. In questo personaggio ho riversato l'esperienza straordinaria che avevo fatto durante il servizio civile a Tor Bella Monaca, in un centro di integrazione sociale con minori sotto custodia legale. Da là mi sono portato dietro tantissime storie, fra le quali il monologo di Enzo: l'idea di essere andato a vivere lì negli anni Ottanta quando ogni cosa era bella, scintillante, c'era la comitiva di amici, poi è finito tutto, come finiscono le cose belle».
Il passato del protagonista del film era quindi tratto da storie reali.
«Da quello che mi avevano raccontato quei ragazzi: le storie tragiche di quindicenni morti dopo essere andati a fare una rapina per comprarsi le Nike, tossicodipendenti scappati dalla comunità a 13 anni e mezzo. Erano degli emarginati alla continua ricerca di un'identità e quando la trovavano, era quella imposta dall'ambiente: non erano mai scelte proprie, ma scelte già fatte da altri. L'idea di un destino immodificabile a quell'età è drammatico».
Dopo il grande successo del film, come si è orientato nelle sue scelte?
«È stato un po' difficile. Un mese prima che uscisse Jeeg Robot è morto mio padre, quindi mi è cambiata la vita da un giorno all'altro. Ovviamente poi mi sono ritrovato ricoperto di proposte, di contratti, di collaborazioni, di esclusive, che ho sempre rifiutato, perché il posto fisso, già quando studiavo legge all'università, mi dava molta ansia. Io sono un giocatore, preferisco sempre la precarietà. Se ho un pregio, è quello di avere tante storie. Allora ho pensato: me le tengo e faccio sì che diventino il mio superpotere. Il primo film che ho fatto dopo Jeeg Robot è stato Indisivibili. Avevo scritto il soggetto, ne ho parlato a Edoardo De Angelis e ci siamo molto divertiti insieme. Uno dei fattori fondamentale per la scelta di un film, oltre al progetto, è la qualità delle persone coinvolte. Io trascorro a volte più tempo con Menotti o con Gabriele Mainetti che con mia moglie!».
È stato fortunato perché ha avuto dei compagni d'avventura simpaticissimi, da Carlo Verdone a Ficarra e Picone.
«Verdone era il mito della mia infanzia. Una mattina mi ha chiamato Luigi De Laurentiis per propormi un progetto. Pensando che si trattasse di un film di Natale, gli ho detto: “Sto facendo un sacco di cose... dimmi comunque perché cosa mi avevi chiamato". A quel punto lui non me lo volevo dire, io ho insistito e me: “Avevamo pensato a te per un film di Carlo Verdone". “Vabbè, allora domani vengo in ufficio". Mi sono fiondato e abbiamo scritto, con lui e Menotti, Benedetta follia».
Com'è stato lavorare con Verdone?
«Carlo è veramente un talento incredibile: quando pensi una scena e gliela descrivi, lui te la recita immediatamente. È un maestro, ma quando proponeva una cosa, diceva: “Se non vi piace, non la mettiamo". Una grande umiltà. Da parte sua abbiamo trovato una disponibilità totale. È uno dei segreti del suo successo: l'idea di non essere punti esclamativi, ma punti interrogativi, ovvero essere pronti a cambiare idea. Quando si scrive una sceneggiatura, ci deve essere sempre un conflitto tra gli autori, non per vanità o per un gioco di potere, ma sempre su argomentazioni orientate a realizzare il miglior film possibile».
Com'è nato il rapporto con Ficarra e Picone?
“Stavo lavorando a Suburra e un pomeriggio mi ha telefonato Salvo Ficarra. Dopo cinque minuti sembrava che ci conoscessimo almeno da una ventina di anni: è stato veramente un amore a prima vista. Lui e Valentino Picone hanno sempre grandi idee: per L'ora legale pensavano di fare la storia di due sindaci e di un paese che desidera tantissimo la legalità, poi gli viene data, ma gli abitanti scoprono che vivere una vita nelle regole è più difficile di quanto possa sembrare. Mi sono portato dietro il bagaglio di Leo Benvenuti e di tutta la commedia all'italiana: amare i tuoi personaggi anche se non sono proprio degli eroi positivi».
È la chiave di Sono tornato sul ritorno di Mussolini.
«Esattamente. La prima cosa che ci siamo detti con il regista Luca Miniero è stata: “Come si può provare simpatia per un personaggio così?". Secondo me, è una sceneggiatura ben riuscita perché arrivi quasi a dimenticarti che quello è Mussolini: è un pesce fuor d'acqua, prova ad adattarsi a un mondo che non è più il suo, a volte fa pure tenerezza. Mi piace prendere in contropiede lo spettatore: lo porti in una direzione e poi cambi subito le carte in tavola, riconducendolo alla realtà».
Non ci resta che il crimine come nasce?
«L'idea originale è mia, di almeno una decina di anni fa. L'avevo proposta a diversi produttori: “Ho un'idea per una commedia criminale", ripetevo, ma nessuno sembrava interessato. Me la sono tenuta nel cassetto, finché un giorno sono andato da Federica Lucisano con tre idee e poi c'era anche questa. Le ho raccontato l'inizio proprio come si vede nel film, facendo sentire la musica di Stelvio Cipriani in Mark il poliziotto, e lei ha detto: “Questa è un'idea molto bella"».
Aveva pensato a Non ci resta che piangere come espediente narrativo?
«Quel film, quando lo vedi, rimane sempre un capolavoro, però ho pensato più a Ritorno al futuro. L'idea di vedere Ritorno al futuro dentro Romanzo criminale, di fondere degli immaginari, mi divertiva. C'è un fattore che ha caratterizzato molte storie su cui ho lavorato: l'idea della svolta. Vengo da una famiglia del Sud, sono cresciuto con il gioco del lotto, il terno, i sogni premonitori della nonna defunta che dava i numeri...».
La befana vien di notte di Michele Soavi?
«È un'idea che mi ronzava per la testa da tanti anni perché per le famiglie del Sud la Befana era quasi più importante del Natale. Volevo scrivere un film per bambini: non c'era un prodotto destinato a quel pubblico e il film invece ha dimostrato che quel pubblico esiste e ha risposto molto bene».
Prima o poi farà il regista?
«Ogni volta che scrivo delle mie idee, penso sempre di realizzarle perché me ne innamoro e non voglio condividerle con nessun altro. Però sono uno che scrive tanti soggetti, ho tante idee, e il pensiero di fissarmi per due anni, come fanno i registi, soltanto su di una un po' mi spaventa. Vedremo! Il giorno che amerò talmente una storia...».