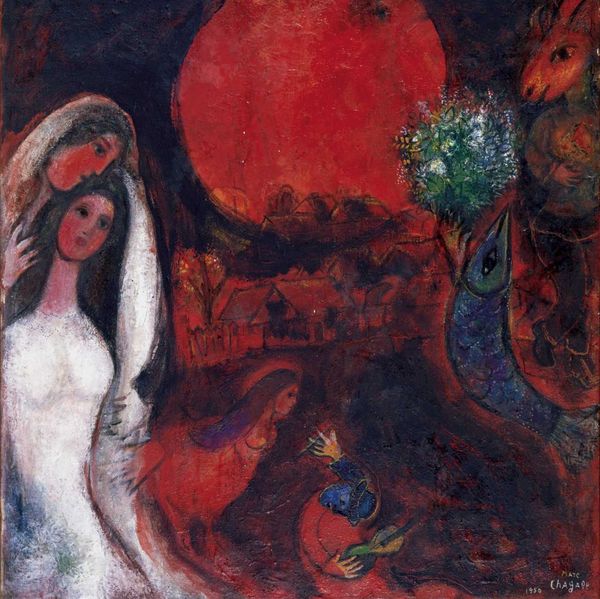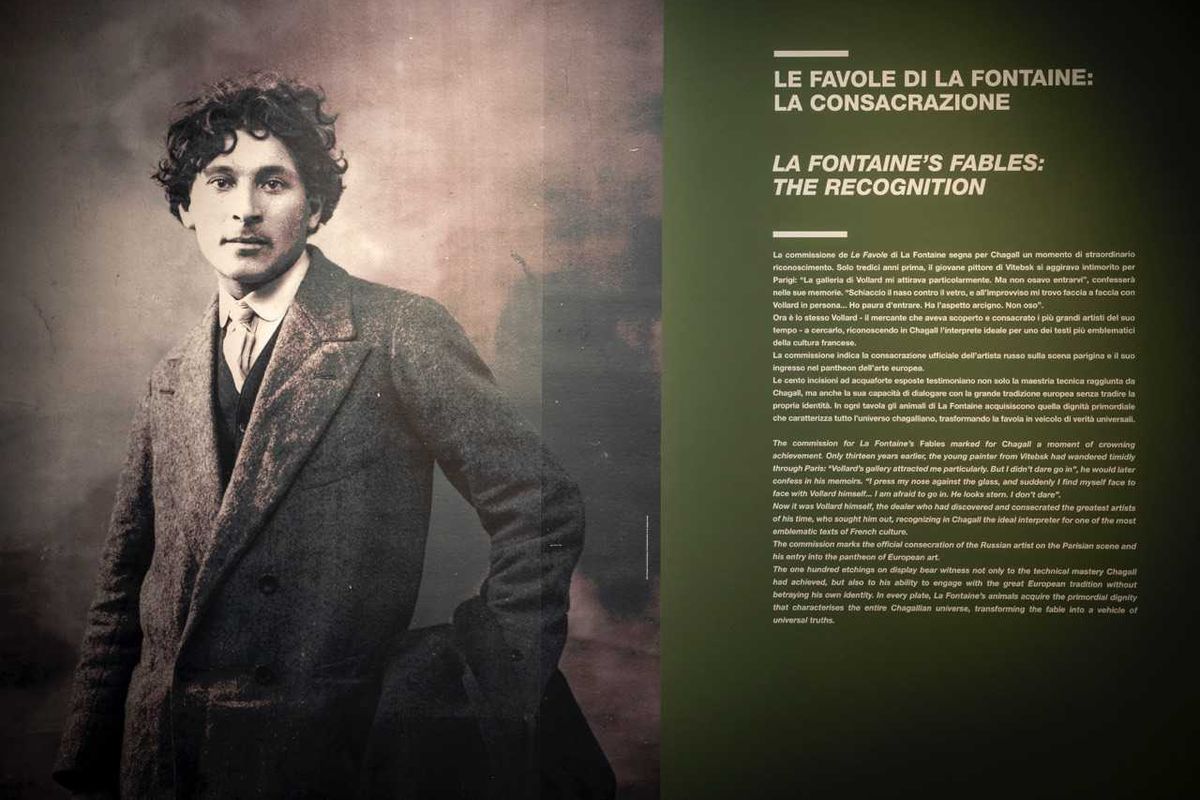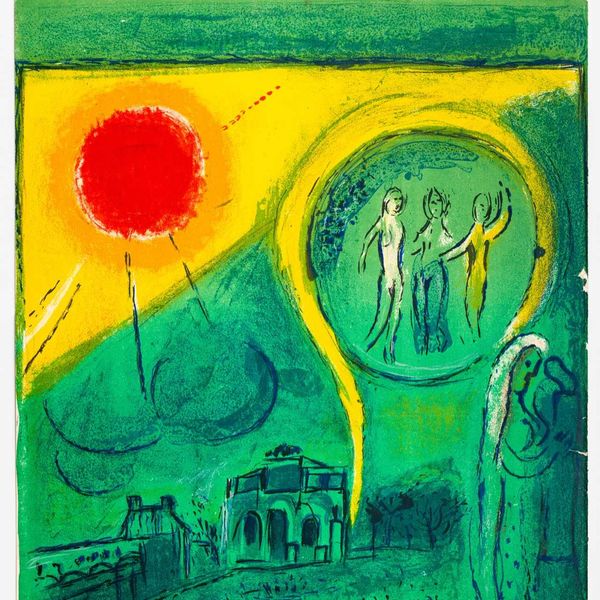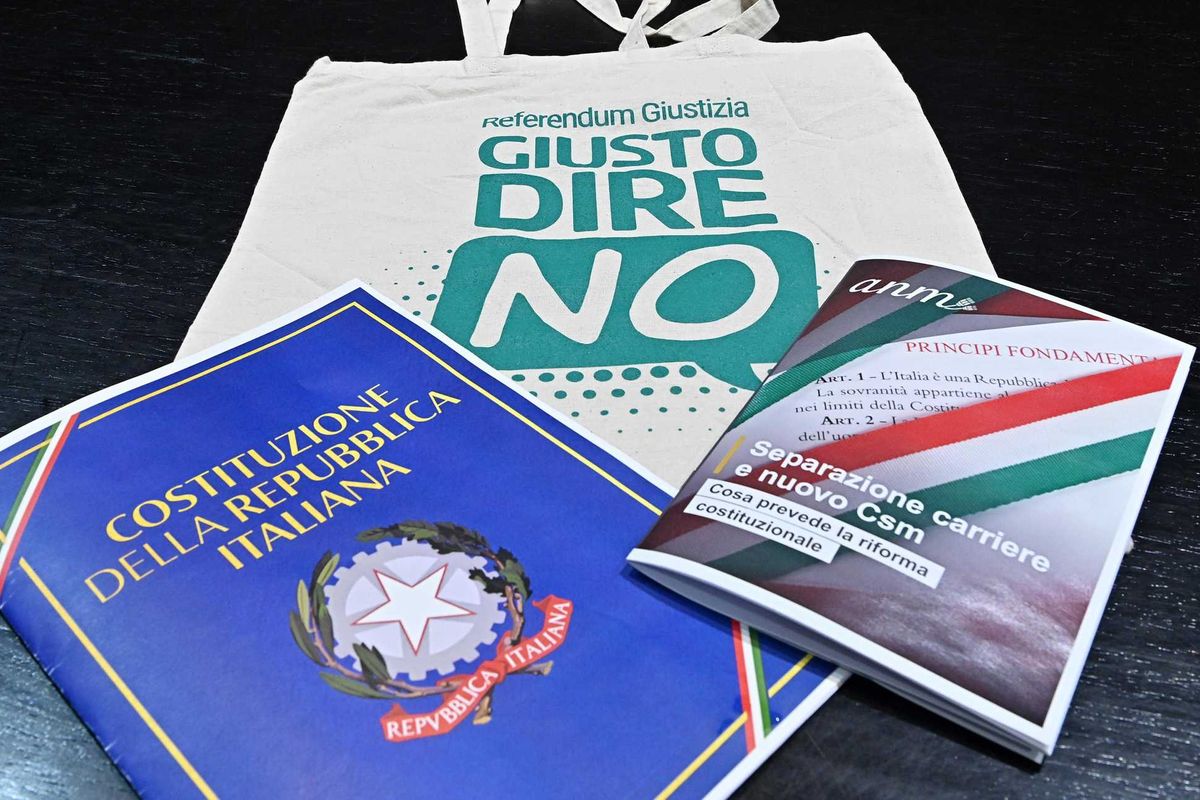Il professor John Haldane è un filosofo scozzese, consigliere papale, ideatore della definizione «tomismo analitico», una corrente che si propone di integrare il pensiero di San Tommaso con la filosofia analitica, il movimento predominante in ambito angloamericano.
Professor John Haldane, lei tra pochi giorni sarà tra i relatori principali alla conferenza «Etica e società. In occasione del centesimo anniversario dalla nascita di Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe». Che cosa ha oggi di importante il pensiero della Anscombe?
«Primo, la Anscombe era un'autrice di grande profondità, che ha affrontato una serie di importanti questioni sulla natura umana, l'etica e la metafisica. Secondo, è stata sia un'esponente raffinata dello stile analitico, dominante nella filosofia angloamericana del XX secolo, sia una critica delle assunzioni comuni agli autori di quella tradizione».
Quali, in particolare?
«Il materialismo nella metafisica e l'utilitarismo nell'etica. Inoltre, la Anscombe ha compreso profondamente il pensiero di Aristotele e aveva una notevole familiarità con quello di San Tommaso, il che ha ovviamente avuto un certo peso nella sua opera. In ultimo, è stata anche una grande interprete della filosofia di Ludwig Wittgenstein, di cui è stata allieva e traduttrice. Ed è stata in grado di combinare il suo metodo con il proprio bagaglio artistotelico, per produrre un contributo duraturo e peculiare alla filosofia contemporanea».
La Anscombe è autrice del saggio Intention, una perla della filosofia analitica del Novecento, uno dei lavori più significativi sulla teoria dell'azione dopo Aristotele. Perché questo testo merita di essere riproposto?
«Intention presenta molte delle caratteristiche che hanno reso la Anscombe un'illustre filosofa, ma in particolare l'intreccio tra il metodo di Wittgenstein di affrontare le questioni riguardanti il pensiero e l'azione umana e la sfida ai pregiudizi filosofici. Al contempo, la Anscombe adotta un approccio aristotelico alla comprensione dell'azione umana, ma con maggior rigore e acume rispetto persino ad Aristotele stesso. Ciò che il saggio promette, è un modo di intendere le persone come esseri naturali, ma non in un senso materialistico o riduzionistico».
Lei è autore di Faithful Reason. In questo testo ha esplorato diversi aspetti del pensiero cattolico in riferimento alla corrente che definisce «tomismo analitico». Crede sia possibile parlare oggi di un pensiero cristiano d'Occidente?
«Per parlare del pensiero cristiano, bisogna avere in mente o precise dottrine teologiche, o una maniera ampia di pensare la natura della realtà e il posto degli esseri umani al suo interno, alla luce delle Scritture e della tradizione cristiana. Ovviamente, ci sono grandi differenze tra i cristiani in merito alla teologia e in generale al pensiero cristiano. Inoltre, c'è stato un declino nell'influenza e persino nell'interesse per le credenze cristiane tra gli intellettuali. Al contempo, però, è possibile pensare a problemi filosofici comuni in modo tale da attingere dall'antropologia cristiana e dalla metafisica della creazione, ma entrando in contatto efficacemente con idee e argomentazioni della filosofia secolarizzata contemporanea. È qualcosa che ho fatto per 40 anni e negli ultimi 20 anni, o giù di lì, ho notato che l'interesse per tutto ciò cresceva tra i filosofi cristiani più giovani».
In una sua curiosa pubblicazione, dal titolo Reasonable Faith, lei si interroga sull'esistenza di Dio e sulla natura dell'anima umana. È evidente che nel suo pensiero lei insiste nel rintracciare una connessione tra la fede e la ragione. Oggi però assistiamo a ragionamenti che tante volte escludono dal loro orizzonte la fede, quasi fosse un oltraggio coinvolgerla nel discorso. Una laicità minacciata dalla sua storia, come se possa esistere una laicità spuria. Qual è l'origine di questa rottura nel pensiero?
«L'odierna cultura secolare combina una serie di idee e impulsi che non sono davvero coerenti, ma che in generale risultano ostili al pensiero religioso tradizionale, che in Occidente coincide con le credenze giudeocristiane».
Quali sono le caratteristiche di questa cultura secolare?
«Innanzitutto, il relativismo: l'idea che non c'è alcuna verità oggettiva sulla realtà o sull'etica, bensì solo il modo di ciascuno di noi di pensare e di vivere. Secondo, il conformismo ideologico: l'idea che l'unica vera forma di conoscenza sia la scienza e che questa possa spiegare tutto, inclusa la natura umana, in base a una prospettiva riduzionistica».
E poi?
«C'è un ritrarsi dal pensiero e dalla pratica religiosa, vista come restrittiva, superstiziosa e incompatibile con la libertà personale. E poi c'è una perdita della fiducia nelle tradizioni della cultura occidentale, concepite come imperialistiche - se non addirittura una forma di odio di sé stessi».
Che conseguenze hanno queste idee?
«Come dicevo, esse non sono veramente coerenti, ma sono utilizzate ripetutamente in contrapposizione alle interpretazioni cristiane dell'individuo e della società. Dal punto di vista psicologico, non è altro che una forma di ribellione giovanile all'autorità e ci vorranno ancora un paio di generazioni prima di essere cresciuti abbastanza per liberarcene».
Il convegno che si aprirà a Urbino la vedrà relatore con un intervento intitolato Anscombe, metodo filosofico e metafisica del pensiero. Che cosa si intende per metodo filosofico?
«Con “metodo filosofico" intendo i modi di affrontare le questioni filosofiche: nel caso della Anscombe, è il fatto di formularle come questioni che rivelano enigmi e paradossi nella nostra maniera comune di pensare ed è lo scavare sotto la superficie, per portare alla luce la fonte di essi e chiarire i problemi in maniere nuove, libere da pregiudizi e assunzioni inconsce».
E la metafisica del pensiero che cos'è?
«Con “metafisica del pensiero" mi riferisco a idee o teorie sulla natura del pensiero, la sua relazione con l'esperienza, la fonte dei concetti in esso espressi e il suo rapporto con la realtà. Sono questioni molto ampie e sarò in grado solo di ripercorrere a grandi linee la filosofia della Anscombe su questi temi. Si tratta di un aspetto del suo pensiero che non è stato molto discusso, in parte perché lei stessa non è stata chiarissima a riguardo».
In un suo recente intervento, Benedetto XVI osserva che sul finire degli anni Novanta «si era ampiamente affermata la tesi che al magistero della Chiesa spetti la competenza ultima e definitiva (“infallibilità") solo sulle questioni di fede, mentre le questioni della morale non potrebbero divenire oggetto di decisioni infallibili del magistero ecclesiale. In questa tesi c'è […] un minimum morale che è inscindibilmente connesso con la decisione fondamentale di fede e che deve essere difeso, se non si vuole ridurre la fede a una teoria e si riconosce, al contrario, la pretesa che essa avanza rispetto alla vita concreta». Benedetto XVI rimarca così la ragionevolezza della proposta cristiana. Crede si possa oggi parlare di un minimum morale oggettivo, cioè di una morale ancorata alla realtà piuttosto che al ritener per vero personale?
«L'idea fondamentale della morale, riconosciuta in modi diversi da Platone, Aristotele, Sant'Agostino, San Tommaso, David Hume e Immanuel Kant, è che l'azione retta è quella che conduce alla nostra natura di esseri razionali, o la esprime. Certo, ci sono importanti differenze tra questi pensatori a proposito del modo di concepire la natura umana, la razionalità ciò che tali caratteristiche o le esprime. Nondimeno, tutti quanti loro guardano al di là dell'opinione individuale e delle convenzioni sociali, verso qualcosa di universale, in cui si possano trovare norme e standard per l'agire umano - quel che si soleva definire “diritto naturale"».
La Anscombe ha scritto pagine su questo…
«La versione della Anscombe di tale tradizione, come quelle di Aristotele e Tommaso, enfatizza la nostra natura di specie, ciò che è vero di noi in quanto membri di una specie naturale comune, oltre al ruolo degli abiti di pensiero, dei sentimenti e delle azioni (le virtù) naturali o acquisiti, nel realizzare e nel perfezionare quella natura in ciascuno di noi, per quanto possibile. Certo, come Tommaso e Benedetto XVI, lei ritiene che noi abbiamo anche un destino sovrannaturale e che il movimento verso di esso abbia bisogno di grazia e beatitudine, che non sono cose sulle quali noi possiamo esercitare un controllo, anche se possiamo riconoscerne il bisogno e cooperare con Dio nel nostro perfezionamento».